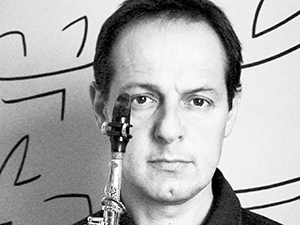Interviste

Gianni Mimmo: creatività senza confini
Se dovessimo attribuire paternità o influenze sulla libera improvvisazione, non potremmo certamente riferirci ad una sola fonte. Un'analisi profonda dei legami della storia, unita a delle interpretazioni non fallaci e supportate da una logica, ci conducono a qualcosa di più di quanto rivendicato dai musicisti e studiosi del jazz. Se gli sviluppi della musica afroamericana sono importanti per inquadrare una tendenza di base dei musicisti-improvvisatori, è anche necessario ammettere che risorse fondamentali sono arrivate dall'arte europea del Novecento, dai movimenti aleatori creati nel mondo della composizione, dall'elevazione a potenza della performance e dei networks interdisciplinari (Fluxus, spettacoli dell'happening, futuristi, dadaisti, surrealisti, etc.). Soprattutto le prime generazioni di improvvisatori liberi (i musicisti nati intorno alla seconda guerra mondiale e quelli nati tra la metà e la fine degli anni cinquanta del secolo scorso) hanno incarnato queste risorse nel loro DNA, unendole ad una pratica di condivisione sociale e politica. A differenza di quanto si può pensare, gli improvvisatori liberi hanno anche materializzato le consuetudini di un'arte musicale autonoma fatta di ore e ore di pratica giornaliera, un modus operandi finalizzato all'espansione delle competenze sugli strumenti: tra questi musicisti, uno bravissimo che vi regala tutte queste qualità appena accennate è lo specialista del sax soprano Gianni Mimmo (1957).
Di Mimmo, su queste pagine, ne abbiamo parlato sempre con ammirazione e in passato Donatello Tateo ci regalò anche un'intervista quando la rivista Percorsi Musicali esisteva nella forma di blog (puoi leggere liberamente l'intervista qui); a proposito di Gianni, devo rimarcare non solo l'importanza e il valore del musicista nell'ambito di ciò che è stata la storia della libera improvvisazione e del jazz in Italia, ma ribadire anche la nostra amicizia, bella, sincera, allegra e sempre piena di discussioni e spunti progettuali costruttivi; tante telefonate, discorsi sull'arte e sulla musica e una stima incondizionata reciproca acclarata nei nostri incontri personali. Sentivo da tempo il desiderio di voler estrapolare in scrittura un pò delle nostre conversazioni e penso che questo sia il momento migliore per farlo, poiché Gianni sta raggiungendo un culmine internazionale, ottenendo riconoscimenti all'estero che si aggiungono alla sua preziosa attività concertistica italiana; dopo aver accantonato l'esperienza di Amirani Records, l'etichetta discografica da lui gestita che ha pubblicato 75 CD ottemperando ad una dimensione contemporanea della musica, Gianni ha riflettuto sul suo modo di essere musicista e senza fermarsi mai ha cominciato a dedicare il suo tempo all'arte del vivere, qualcosa che ricorda un pò per analogia il surrealismo di Magritte e le motivazioni nascoste nel suo quadro L'arte di vivere, dove si nota una divisione funzionale tra corpo (un abito maschile con giacca e cravatta rossa) e testa (una grande palla con piccoli lineamenti di un viso al centro), un modo per evidenziare come sia importante la riflessione, l'esperienza e una connessione surreale che vada oltre l'ottica del mondo per ottenere un equilibrio vero. La ricerca di Gianni è la ricerca di una luce nell'oscurità che attanaglia oggi la prospettiva umana intelligente.
Prima dell'intervista, vorrei spendere due parole di apprezzamento sull'ultima produzione discografica di Gianni, ossia Say When, un duetto con Ove Volquartz (a clarinetto basso, contrabbasso e flauto) pubblicato per Aut Records qualche mese fa; è al solito, una testimonianza del valore artistico del sassofonista nonché brulica di quella bellissima filosofia interpretativa che si stabilisce in tutta la sua musica. Say when è improvvisazione libera fluida, dove l'istinto real time dei musicisti si trasferisce con opportuno sviluppo sugli strumenti: i due musicisti lanciano dettagli da decifrare nello spazio dell'ascolto, linee melodiche 'gentili' (la title track o anche Athen Amidst the Olive Trees), punteggiature fantasiose (Stay Reluctant) o anche gangli armonici (More than One Threshold ma soprattutto Distant Peaks), a volte sovrapponendosi altre volte rendendosi complementari. Le liner notes di Andrea Dani e la cover CD di Andrea Montanari cercano di oggettivare una relazione musicale che sta tra Jean Dubuffet e le tecniche di collage. Dubuffet è uno dei pionieri dimenticati della free improvisation e basterebbe andare a rovistare nella sua musica (che era comunque un'appendice della sua personalità pittorica e scultorea) per capire che l'Art Brut nei primi anni sessanta del Novecento era già una forma di arte spontanea e terribilmente matura che doveva fare i conti con le cognizioni accademiche per via di una considerazione dell'arte accessibile a tutti (soprattutto il riconoscimento di una superiorità creativa dei bambini, dei portatori di deficit mentali o clienti di cliniche psichiatriche); tuttavia in Say When se è vero che verifichiamo un'eguale spontaneità della musica è anche vero che non c'è aderenza alla musica caotica e rumorosa di Dubuffet e si esclude Distant Peaks, che a causa degli armonici rumorosi strappa delle somiglianze, si è comunque distanti da un automatismo delle posizioni musicali e più vicini ad una forma sonica prescrittiva che è il frutto delle qualità e delle sensibilità dei due musicisti.
Quanto a Montanari, poi, è evidente che la relazione che vuole essere instaurata con Say When è quella di due 'corpi' che fluiscono e perciò il disegno è scelto con oculatezza: il messaggio alla fine è chiaro perché la fluidità e il divenire quasi idilliaco della musica significa arrivare alla dimostrazione che esiste una saggezza aldilà degli eventi, la quale è indispensabile per affrontare le turbolenze del mondo, è qualcosa che unisce e si attesta in un'area di resilienza: Say When dona benessere all'ascolto, è una ricerca di luce che si scorge in un atteggiamento e un'effusione musicale, uno standard che può durare.
Ecco l'intervista.
EG: Ciao Gianni e complimenti a te e Ove per il bellissimo Say When. Parto da qui. Se non sbaglio questa è la terza registrazione dove suoni con Volquartz (le altre due sono Current Air e Cadenza del Crepuscolo) e mi chiedevo qual è la genesi di Say When?
GM: Ciao Ettore, grazie sempre per la tua attenzione e il tuo ascolto di questo Say When! Con Ove Volquartz esiste anche una pubblicazione per Amirani Records di Reciprocal Uncles, il cui nucleo originario era il mio duo con Gianni Lenoci, in questo caso in forma di quartetto con appunto Ove e Cristiano Calcagnile alle percussioni. Il titolo era: Glance and Many Avenues [amrn# 042]. Si tratta di un live all'Apex di Göttingen, la prima volta che incontravo Ove. Da allora la nostra collaborazione è stata intensissima, abbiamo suonato con Reciprocal Uncles in tutta Europa, ma anche con il quartetto con John Hughes al contrabbasso e Björn Lücker alla batteria, in festival di danza con il progetto Panji, in ensemble di fiati e in duo in diverse occasioni... Ci conosciamo da oltre 10 anni e davvero credo abbiamo fatto un sacco di cose insieme, inclusi stage nei conservatori, teatri, gallerie d'arte, chiese, persino negozi. Il progetto Cadenza del Crepuscolo, che contempla il lavoro insieme al contrabbasso di Hughes e l'incredibile church-organ di Peer Schlechta, ha poi dato un ulteriore impulso alla forma dialogica di timbri così distanti...
Tuttavia, non avevamo mai registrato un duo, forse lo praticavamo, ma non lo avevamo mai concepito con modalità compiute. Ove ha un'esperienza vastissima, ha suonato con nomi storici come Cecil Taylor, Günter Hampel... E poi è un musicista molto completo e versatile. Ci siamo resi conto di avere, in un certo senso, maturato delle affinità nel modo di procedere, una certa nuova attenzione verso la forma. Forse questo deriva da un'attenzione, piuttosto spiccata in entrambi, per la dinamica e i contrasti timbrici e per un'attitudine forse più narrativa, non saprei... Questi elementi risultano spesso più diluiti in ensemble più espansi, mentre emergono come protagonisti in formule rivelatorie come il duo. Nel tempo si è creata una specie di stanza sonora nella quale era molto facile far convergere le rispettive energie e ho pensato che fosse ora di documentarlo. Ci siamo presi tempo in studio, il suono era ottimo, non è stato difficile produrre un bel materiale. Nel riascolto è emerso un fil rouge, un percorso direi, sul quale abbiamo convenuto. Aut Records si è detta subito interessata al lavoro che poi ha visto la luce all'inizio dell'anno.
EG: Sax soprano e clarinetto basso/contrabbasso è una combinazione non frequente nelle registrazioni di free improvisation. A mia memoria ci sono i duetti di Parker/Rothenberg, Doneda/Rühl, Coxhill/Ward, Sjöström/ Gratkowski e poi ci sei tu in Explicit con Vinny Golia. E' qualcosa che sembra comunque appartenere agli specialisti del soprano ed ha certamente delle qualità timbriche implicite che lo avvicinano alla chamber music. Cosa ne pensi?
GM: La fascinazione per il clarinetto basso e in particolar modo per quello contrabbasso è storia antica per me. Sono strumenti che assommano estensione nel range e incredibile flessibilità timbrica. Rimangono per me in parte imprendibili per una certa natura ibrida nella qualità del tono che producono, conoscono il calore di un violoncello e le asperità di una fibrillazione, di micro-battimenti, di improvvise lacerazioni del suono. "Sussurri e grida", mi dico spesso. Sono timbriche che riescono ad avere un doppio ruolo: dialogico e di tessitura. Questo spiega anche il loro impiego in contesti cameristici (per il cl.basso penso a Webern e ai suoi meravigliosi lieder e per il cl.contrabbasso all'impiego nel soundtracking ad es.). Insomma, posseggono una forza tellurica con la quale mi piace avere a che fare, la distanza nel range mi costringe a procedere per associazioni insolite. È molto stimolante, specie si tiene acceso l'ascolto reciproco e con Ove questo avviene sempre. Inoltre, quando la palette a disposizione è molto ampia, è forse più naturale procedere con maggiore attenzione, con più accortezza forse, verso uno spontaneo impianto formale dell'improvvisazione. Sembra forse contraddittorio, ma emerge chiaramente un carattere compositivo in queste improvvisazioni.
EG: Nelle liner notes di Say When Andrea Dani ha menzionato il grande Jean Dubuffet, la cui musica è assolutamente straordinaria, soprattutto per quei tempi. Cosa pensi di Dubuffet, anche alla luce di alcune critiche che gli vengono rivolte proprio dagli improvvisatori riguardo ad una presunta automaticità dell'impulso prescritta dal francese?
GM: Ho affidato ad Andrea Dani, il quale ha gentilmente acconsentito, l'idea di scrivere un liner per questo album perché è un sensibile pensatore e possiede una capacità di lettura trasversale che fa appello a categorie spesso distanti, ma che insieme concorrono a offrire un risultato composito e ricco di insolite prospettive. Anche stavolta mi ha sorpreso, cogliendo nel segno, citando Dubuffet. (Ri)Conosco Dubuffet come artista completo, non sento di dividere il suo agire in differenti discipline: la pittura, le maschere, i disegni infantili, la musica, la scultura... Lo sento come una figura "intera" che racchiude nel suo fare una spinta creativa primordiale, qualcosa prima del pensiero. La cosa che a mio parere accomuna il processo di fruizione dell'opera di Dubuffet e questa musica è forse una specie di innocenza che pur da prospettive distanti si avverte, una fragranza che sta prima della (o forse eccede la) sua interpretazione per categorie. Sempre sono tuttavia individuabili linguaggi, provenienze, derivazioni. Credo sia inevitabile: siamo essere complessi, fatti di biblioteche interiori cui facciamo naturalmente riferimento. Ma c'è forse una postura, quasi visibile per quanto mi riguarda, che mi fa pensare a questa similitudine.
La posizione critica che considera l'automaticità dell'impulso un minus della musica di Dubuffet è comprensibile, ma parte forse da una posizione impropria. Mi torna alla mente una conversazione intorno a un filmato nel quale un uccellino zampettava curioso su una chitarra elettrica, sdraiata a terra e collegata ad un amplificatore. Potevamo obiettare al fatto che si trattasse di un'improvvisazione? Il richiamo della musica di Dubuffet sembra rivolgerci la domanda "Senti quante cose accadono nel suono prima della sua assegnazione a qualsiasi categoria? Al netto di qualsiasi sovrastruttura culturale?". È una domanda ancora interessante, direi. Anche se senz'altro legata a quel tempo e a quella temperie culturale. Assertiva allora, più confusamente percepita oggi, penso.
EG: Ci spieghi quando è nata la tua collaborazione con Andrea Montanari e cosa ti ha colpito della sua 'astrazione' profusa nel collage?
GM: Ho incontrato la prima volta Andrea Montanari, dopo un mio live al festival del cinema di Bergamo nel 2016 dove avevo portato un mio lavoro di live-soundtracking. Lui aveva appena collaborato con Gianni Lenoci in un altro progetto sulla relazione fra musica e immagine. Dopo la scomparsa di Gianni ci siamo risentiti in occasione di una serata dedicata al ricordo di questo bravissimo pianista e compositore con il quale ho condiviso un decennio di attività. Andrea aveva ritrovato dei disegni a pastello che aveva fatto e poi non usato per quel progetto con Gianni. Guardandoli insieme abbiamo pensato che contenessero una tenera cifra narrativa, allusiva e non priva di una certa malinconia. Il tratto mi ricordava Folon... e abbiamo individuato una successione e io ho pensato alla musica, un solo soprano sax. Il lavoro ha preso il titolo di "The Lost Frames" ed è stato presentato al teatro Radar di Monopoli nella serata appunto dedicata a Gianni e poi anche al festival Urticanti nel 2021. In quel caso i disegni astratti rimangono proiettati uno ad uno e ad ognuno di essi viene dedicato un brano suonato dal vivo.
Andrea ama molto il collage, il suo lavoro è piuttosto accurato e mi ricorda quello degli affichistes milanesi negli anni '60. Ma mentre in questi ultimi il senso sembra emergere da uno strappo, una lacerazione che fa emergere il segno di stratificazioni precedenti, nei collage di Andrea il tratto compositivo è più evidente, netto. Ne risulta un processo fruitivo più articolato, fatto di continue messe a fuoco, uno spostamento delle profondità che per me è molto stimolante e che sento molto vicino al mio modo di procedere nella pratica improvvisativa. Abbiamo presentato un lavoro al festival Osvaldo in Rovereto che è andato piuttosto bene nel 2022. Anche qui musica e immagine sono abbinate in una specie di lettura reciproca, quasi mai didascalica. In questo senso è anche interessante ricordare "Costellazioni Incidentali" che ho presentato a Fano Jazz nel 2021, una commissione del festival, in cui partitura grafica e mappe astratte preparate da Andrea sono diventate la mia solo performance. Questo collage che appare in copertina è parte di una sua serie intitolate ABSTRACT IN YOUR HOUSE e offre un buon indice di lettura della musica che si ascolta nell'album. Ci sono elementi che galleggiano e che chiamano la nostra attenzione in un processo di riconoscimento, ancora una specie di continua messa a fuoco, ecco. I titoli dei brani sono anche un po' così: fra gli altri si citano gli occhi di Atena (come viene chiamato il contrasto di luce causato dal vento tra la parte opaca e quella lucida delle foglie dell'olivo) [Athena Amidst The Olive Trees] oppure ci si riferisce al concetto di soglia [More than One Threshold]...
EG: Dove si dirige secondo te l'"astratto" nei tempi attuali? (riferito a tutte le arti).
GM: Davvero non so rispondere a questa domanda. I tempi sono così densi e confusi e il processo fruitivo così sollecitato che le valenze sono spesso imprevedibili. Alcuni richiami sembrano efficaci e tuttavia c'è uno smarrimento della comprensione. Non so, credo che nell'astratto risieda ancora un richiamo misterioso, che credo abbia attinenza con un certo appetito spirituale mai completamente perduto, un bisogno non sopito di catarsi. Forse leggera, direi, tuttavia presente. Penso a certi effetti di un segno assertivo e potente all'interno di un non luogo come una stazione della metropolitana, pensa a un'opera di Emilio Vedova... c'è qualcosa di inesplicabile ma estremamente presente in quel luogo... ancora oggi. L'astratto continua a chiamare e ad attraversare.
EG: Noi parliamo spesso della musica improvvisata sia di ieri che di oggi e ci riferiamo spesso ad un metodo di comportamento dell'improvvisatore, uno che deve introitare competenze, accettare i transiti e saper analizzare i cambiamenti, trasformare la tensione in spunti creativi, essere consapevole di una visione. Qual è lo sforzo che l'improvvisatore deve implementare e qual è il vantaggio da acquisire in una pratica quotidiana dello strumento?
GM: Collaboro con musicisti di ogni parte del mondo e noto che gli approcci, il percorso, persino la pratica ha aspetti e cammini molto personali forse dettati dalla formazione o forse dalle frequentazioni, non so. Per quanto mi riguarda sono con te d'accordo sul fatto di lavorare per possedere una visione d'insieme, una consapevolezza dei tempi e della misura da usare. Un senso della posizione, per usare una categoria di un maestro a me caro. Questo credo che abbia a che fare con il concetto di responsabilità, del sapere che con la tua musica consegni qualcosa. Diciamo, per essere brevi, voglio che l'improvvisazione prenda (e doni) il meglio da me. Lavoro per una qualità buona di ciò e di come faccio, ecco. Per ognuno questa soglia di qualità è differente, credo. Alcuni si affidano ciecamente alla propria spontaneità, altri ricercano un percorso attraverso la tecnica, altri da processi reattivi... Personalmente, il suono e la sua pratica su uno strumento arcigno ed ingrato come il sassofono soprano mi richiedono una sorta di dedizione talvolta severa. Ma mi rendo conto che la frequentazione assidua rende la relazione ricca e vera nelle sue contraddizioni. Una parte per me anche molto importante è rivestita dalla frequentazione di altre prospettive artistiche. A volte una mostra d'arte rappresenta per me un serbatoio ispirativo straordinario e di grande durata. Per rispondere più direttamente direi che l'impegno è dato dal rimanere aperti e curiosi, severi e attenti. Ma questo ha molto a che fare con il carattere di ognuno...
EG: Ho sempre pensato che la tua musica sia collocata in un perfetto assioma di elementi anche extramusicali: il surrealismo e l'arte inconsueta del primo novecento, l'area della performance, un tenero richiamo all'arte espressionista. Condividi questa mia idea? E se non è così puoi specificare i tuoi drivers extra-musicali?
GM: Ho spesso detto che la mia maggiore fonte ispirativa risiede nella pittura, nella scultura, nella fotografia anche... o nell'architettura. In generale direi che la forma o le forme in senso lato hanno per me un richiamo che risveglia la mia curiosità. Ma sono certo d'accordo con te circa la fascinazione del primo Novecento, le forze che si agitano a Vienna per esempio, Webern, Berg. Ma anche certa narrativa giapponese ad esempio.. Kawabata, certe volte penso che vorrei fare musica come lui ha scritto romanzi o la pittura di Casorati... anche lì una sospensione un incanto che vorrei avesse la mia musica... ma sono troppe per essere menzionate, queste fonti...
EG: Vorrei che per me e per i lettori di PM illustrassi le tue bellissime esperienze all'estero. Partirei da quella del SoundOut festival a Canberra dove sei stato partecipe di un festival dell'improvvisazione che pochissimi conoscono in Italia. Vorrei sapere che cosa ti ha dato questa esperienza e se hai potuto maturare un'idea sulla scena improvvisativa australiana?
GM: Davvero posso dire che l'esperienza al SoundOut è stata proficua sotto diversi aspetti. Ho conosciuto musicisti molto bravi, ho avuto scambi molto interessanti che penso frutteranno altre collaborazioni importanti, mi sono piaciuti moltissimo i giovani che ho trovato ottimisti e curiosi. Ho avuto una masterclass con loro e c'era una bellissima energia. Ho avuto modo anche modo di ascoltare e osservare intersezioni e comunicazioni diverse. Il direttore artistico del Festival Richard Johnson ha un'attenzione molto accurata e una spiccata propensione a favorire incontri e scambi artistici a molti livelli. Credo tornerò laggiù, stiamo pensando a una mia composizione per large ensemble per la prossima edizione. Mi sono molto piaciuti i musicisti francesi di Hubbub, ho suonato con alcuni di loro in diverse combinazioni. Mi è piaciuta moltissimo la cellista canadese ma ora residente a Melbourne, Peggy Lee. Credo proprio funzionerebbe molto bene suonare ancora con lei. Al SoundOut abbiamo avuto un sestetto con, fra gli altri, lei e Frederick Blondy al piano... davvero molto buono. Ho avuto uno splendido scambio con l'artista Locust Jones, ho interpretato in una parte del mio solo concert due suoi grandi dipinti e credo senz'altro che faremo qualcosa ancora insieme in futuro. Con Richard Johnson abbiamo anche fatto una camminata e registrato in una caverna in un parco nel quale la natura davvero ha una forza percepibile. E poi ho riscontrato una ottima curiosità ed attenzione nell'audience, una certa freschezza delle proposte... insomma vista da laggiù, lo dico con dispiacere, la vecchia Europa sembrava malinconica e lontana...
EG: A metà Marzo sei stato in Germania per suonare con il Wild Chamber Trio, assieme a Clementine Gasser ed Elisabeth Harnik, due grandissime improvvisatrici anche sbilanciate su una visione classica della musica per ciò che concerne progetti di partitura tradizionali e grafiche. Qual è il valore aggiunto che avverti in questo trio?
GM: Beh, Wild Chamber è per me speciale. Lo fu dall'inizio dell'avventura, ormai 13 anni fa, quando Elisabeth suonava in un set differente dal mio al Vortex a Londra e dopo il mio set mi chiese: ti va se proviamo a fare musica insieme? Da lì è partito questo viaggio che ha portato al primo disco 10.000 Leaves insieme a Clementine. Il valore aggiunto, mi chiedi... Il valore aggiunto è che sono due musiciste molto aperte, che sanno ascoltare moltissimo e con derivazioni solide e molto consapevoli, veramente posseggono e sono possedute dai loro rispettivi strumenti e da una passione sincera per la musica. Entrambe sono enormemente cresciute in maturità artistica e in skill strumentale. Il concerto di Monaco all'Einstein Kultur per la serie Offene Ohren curata da Hannes Scheider e anche quello all'ArtActs 25 a St.Johann Tirol sono stati davvero eccellenti. È un impianto cameristico selvaggio e raffinatissimo insieme. Io sempre trovo un senso formale pazzesco, una concentrazione altissima. È un trio che richiede di essere sempre in ascolto, l'interplay molto vivace. Suoneremo ancora in Austria a Graz e Klagenfurt il prossimo fine Maggio. Spero tanto di poter portare in Italia questo trio, davvero sarebbe bello.
EG: Un'altra esperienza incredibile è quella del progetto in Giappone con Hashira Yamamoto che include delle affascinanti sorprese. Ci parli di come è nata questa collaborazione e che cosa hai vissuto nei concerti in Giappone?
GM: Il progetto con Hashira Yamamoto ha una declinazione molto particolare che parte da una mia mail. Avevo visto alcune sue fotografie in rete e gli avevo chiesto un'immagine per "Transient" il secondo album del trio Clairvoyance (con Adriano Orrù al contrabbasso e Silvia Corda al pianoforte e al toy piano). Hashira aveva gentilmente acconsentito e anche impiegato la musica di quel disco per insonorizzare la mostra delle sue fotografie in una galleria di Osaka. Il lavoro di Hashira è spesso basato sull'utilizzo di tecniche assolutamente analogiche nello sviluppo e nella stampa. Le sue foto hanno spesso un impianto formale piuttosto tradizionale e tuttavia molto affascinante.
Il suo progetto che raccoglie le immagini scattate lungo un tragitto di tre anni che ha ripercorso la via della seta dalla prefettura di Nara in Giappone fino alla costa atlantica del Portogallo è molto particolare e regala inquadrature dal carattere contemplativo di vari luoghi lungo il cammino, come degli sguardi lanciati dalla propria anima. Hashira ha poi raccolto tutte queste fotografie, incollandole in tre makimono, rotoli di carta di riso lunghi 8 metri ciascuno, interamente assemblati a mano che celebrano questo viaggio d'incanto che accosta immagini provenienti da angoli remoti e silenziosi. In certe immagini sembra di poter ascoltare un vento che le attraversi...Durante una visita in Italia per una sua mostra a Milano, Hashira mi ha lasciato i tre makimono come elementi diciamo così ispirativi... ebbene io ho scelto 7 immagini da queste raccolte e ho incominciato a pensare a delle musiche che ne potessero scaturire.
L'idea ha preso corpo e abbiamo deciso di dare forma al progetto cominciando con una registrazione del mio solo sassofono in un luogo significativo, abbiamo quindi scelto un tempio, il Tachibana-dera di Asuka, nella prefettura di Nara, regione da dove il viaggio di Hashira partì. Grazie a una lunga trattativa con il priore buddhista di questo tempio abbiamo infine avuto il permesso di organizzare una recording session il quel luogo.
Era la seconda volta che tornavo in Giappone, la prima fu nel 2018 per un tour con Satoko Fuji e per alcuni concerti con Yoko Miura. Questa volta, grazie ad Hashira ho avuto modo di approfondire alcune personali curiosità sul Giappone e su un certo semplice equilibrio che sembra attraversare lo sguardo e il pensiero. Il tempio si trova in aperta campagna, i ciliegi erano in fiore, le immagini di Hashira aperte sui tatami e la luce perfetta. Credo che una prima parte di questo progetto abbia ora preso corpo e sono molto curioso di proseguire. La mia intenzione è arrivare a un prodotto misto, immagine e musica, non so ancora se un libro o un altro tipo di pubblicazione, sono ancora in una fase fattiva, ma la materia è davvero ricca.
Sempre in Giappone mi è capitato di trovare un'attenzione e una concentrazione particolare. Il rapporto con il fare artistico ha un peso del tutto diverso, le mie categorie semplicemente scompaiono a vantaggio di una specie di pratica complessiva che coinvolge vissuto quotidiano e musica. Non è facile spiegare come, ma sento di fare bene laggiù... Tornerò, questo è certo, devo affinare alcune strategie ma credo che tornerò presto...
EG: In 60 anni e passa di storia, jazz e libera improvvisazione hanno acquisito un certo status nella formazione degli artisti, soprattutto nei conservatori o nelle scuole di musica i generi sono entrati nei piani di studio degli allievi. Riguardo alla free improvisation, pensi che questo abbia provocato dei cambiamenti nella considerazione dei giovani artisti, che non hanno avuto la fortuna di sperimentare gli anni d'oro?
GM: Sì, credo di sì. Ma è anche un tempo diverso. Io ricordo che uno certo spirito di opposizione animava le mie scelte di gioventù. Ma è sempre auspicabile che nel percorso di formazione si incontrino possibilità di approfondimento e possibilmente insegnanti che sappiano accendere e tenere acceso il fuoco della conoscenza... Tuttavia, anche per ragioni anagrafiche tendo a rimpiangere quello spirito che animò i miei inizi… Bisogna avere domande, non sempre è meglio partire dalle risposte… ecco. Il mio timore è quello di una mancanza di ascolto, di una ricerca, della mancata occasione per creazione di unpantheon personale… insomma i limiti dell’apprendimento scolastico. Naturalmente esistono esempi brillanti, mi vengono alla mente certe esperienze americane o tedesche ad esempio. Ma sempre si tratta, più che di programmi, di capacità di trasmissione, di usare la scintilla per accendere un fuoco più che di chiedere “chi ha un accendino?”
EG: Ti faccio una domanda che tutti vorrebbero fare. Molti si chiedono quale sarà il tuo orientamento musicale dopo che hai chiuso l’Amirani R. e forse il motivo della loro interrogazione sta nel fatto che vorrebbero suonare con te.
GM: Come ebbi a dirti alla chiusura dell’avventura di Amirani Records, ero arrivato ad avvertire un senso di compiutezza. Come fosse tempo di girare pagina, improvvisamente quel sentore era divenuto chiarezza e mi sono detto che poi non era così strano. Le cose, semplicemente, cambiano. La mia idea è di partire con una nuova avventura, forse più personale, documentativa, e magari proprio con il progetto con Hashira Yamamoto come primo passo. Ho anche in mente un nome per questa nuova “cosa”, ma non voglio spingere, credo che verso al fine dell’anno avrò le idee più chiare.
EG: Tutti sentiamo ancora la mancanza di Gianni Lenoci ma tu lo celebri sempre nei discorsi e nei pensieri e poi la Puglia è certamente uno dei tuoi punti di riferimento in Italia, non solo per le radici familiari. Puoi dirci qualcosa sui tuoi progetti con i musicisti pugliesi.
GM: Tornerò in Puglia il prossimo mese! Proprio con Ove Volquartz presenteremo questo “Say When” nello studio di Gianni Lenoci, l’album come sai è lui dedicato. Avremo anche intersezioni con Pierpaolo Martino all’Università di Bari, suoneremo a Mola e a Lecce. I miei rapporti con la Puglia e i suoi bravissimi musicisti si sono intensificati moltissimo durante la collaborazione con Gianni. Anche questa volta incontrerò diversi musicisti pugliesi alcuni dei quali hanno pubblicato con Amirani in passato. Per me tornare in Puglia è fare “campo”, è ritrovare amici e collaboratori… che sono tutti molto cresciuti, il tempo passa… spero davvero in un abbraccio con tutti loro.
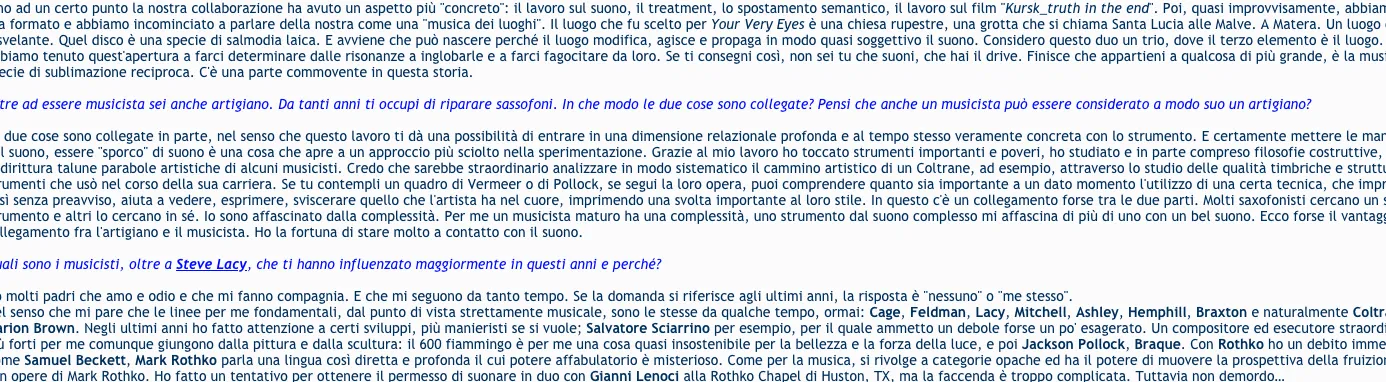
Saxofonista, artigiano e produttore con la sua etichetta Amirani Records, Gianni Mimmo è uno degli artisti più interessanti legati al panorama italiano della musica di ricerca.
Quando e come si è avvicinato per la prima volta al sassofono?
Fu nel 71. Avevo comprato un LP di Archie Shepp. Credo sia l’unica cosa di Shepp che si possa chiamare R&B., è una registrazione del 68/69 ... Intorno a me i ragazzi più grandi ascoltavano cose pop americane e inglesi.
Alcuni più smaliziati, conoscevano gli scaffali “giusti” in un negozio del centro della mia città. Io ero troppo giovane e così frequentavo quel negozio solo quando i più grandi ci andavano, ma non riuscivo mai a vedere quegli scaffali perché loro ci stavano davanti tutto il tempo. Così presi a pensare che in qualche altro scaffale avrei trovato qualcosa.
Mi svenai per quel disco fra la derisione dei miei amici. Viso nero in copertina viola.
La voce nera del tenore di Sheep fu quella la scintilla.
Entro l’anno recuperai uno strumento veramente rudimentale proveniente da una banda di paese.
Ma ebbi un vero sax professionale, un paio d’anni più avanti. Un alto che potei compare perché mio padre vinse una piccola cifra al casinò.
È da lì che il sax mi cadde nel cuore.
Steve Lacy ha avuto un’importanza fondamentale per la sua formazione da musicista. A lui deve probabilmente la sua stessa ossessione per la ricerca. Una ricerca “monacale” che vuole andare alla radice della propria persona al fine di regalare una performance “sincera”, slegata da una comunicazione di tipo idiomatico. Quanto lavoro richiede un tipo di approccio allo strumento così profondo?
Steve Lacy ha avuto un’importanza nella mia formazione come uomo. Steve mi ha detto poche cose, tutte fondamentali. Io rimasi colpito dalla profondità dell’uomo e dalla lucidità della sua musica. Al suo primo concerto che vidi nel 74, in duo con un poeta bolognese che ora non c’è più Adriano Spatola, andai letteralmente per terra.
Ancora la ritengo una delle esperienze più belle che mi è stato dato modo di vivere. Era un lavoro quasi sillabico sulle cellule fonetiche, era così dentro la materia da rivelare improvvisamente, e in modo così inequivocabile, quante possibilità si incontravano lavorando sul suono.
Non puoi muoverti sinceramente senza essere vicino alla parte più nascosta di te quando decidi di esporti come musicista, come artista.
Questo viene da Steve e da altri maestri in genere: lo scultore Alberto Giacometti, Orson Welles, indubbiamente Cage, Francis Bacon…
La ricerca diventa “monacale” quando ha dentro una rinuncia.
Cioè deriva da una sottrazione. Ho incominciato a sottrarre strumenti, linguaggi, abitudini, e improvvisamente tutto è divenuto chiaro e duro.
Ho scelto di dedicarmi a un solo strumento che avesse dentro un numero importante di cose insolute, non per risolverle, ma perché è solo lì che vedo chi sono.
Voglio dire, devo averlo ripetuto spesso…, io credo che se ho davanti un certo numero di difficoltà da affrontare, ho l’occasione di dire e fare il meglio che posso.
Il lavoro presenta momenti molto ostici, nei quali lo sconforto viene a trovarti e tu pensi che forse hai sbagliato tutto.
Così ho semplicemente accettato che io posso talvolta anche odiare questo strumento. In media, una volta ogni dieci giorni mi capita...
È come stare con una persona e convivere anche con la parte più scomoda della faccenda. Non conta chi è più forte, conta la relazione.
Al 2000 risale l’inizio della sua collaborazione con la poetessa Chandra Livia Candiani. Devo ammettere che la correlazione tra improvvisazione e poesia mi ha sempre affascinato molto. La musica si limita a modellare il contesto nel quale le poesie vengono raccontate, come fosse una colonna sonora, oppure nasce un’interazione più profonda tra le due forme d’arte?
Chandra è una straordinaria persona, con una spiritualità in bilico tra l’infanzia e l’inesorabile. Rappresenta per me un incontro indimenticabile tra la sua parola e la mia musica. Il nostro è stato un lavoro di “traduzione”, del tempo di mezzo fra la musica che diviene parola e della parola che diviene suono. Su questo crinale si gioca l’enorme responsabilità di spostare le rispettive qualità e mancanze.
La poesia, quando è buona, non ha per nulla bisogno di altra musica. Prendi T.S. Eliot, prendi Beckett, che bisogno c’è di farci musica sopra, sotto, intorno?
È così che abbiamo deciso di sollevare il velo e muovere le parti. Portare la poesia fuori dalla lettura privata, intima e farla viva lavorando su echi di suono provocato, capendo quanto c’è dentro l’asprezza di certe consonanti e trovando una declinazione musicale oltraggiosa, sollecitatoria dell’ascolto.
Con Chandra abbiamo dato decine di house concert prima con “Lettere mai scritte” e poi con “Io con vestito leggero” e abbiamo davvero provocato un ascolto nudo, nel quale ci si trova a bazzicare intorno a dei confini.
Abbiamo incontrato audience incantate, stupite, attonite, ostili ma tutte vicine, toccate.
È stato un’incredibile collaborazione, con tratti quasi trascendentali.
Tutti dovrebbero leggere Chandra.
Io metterei un’ora di Chandra a settimana nel calendario scolastico…
Insieme a Xabier Iriondo, col quale ha collaborato in tantissime occasioni, ha avuto la possibilità di sperimentare un nuovo approccio alla musica, dove il luogo in cui ha sede la performance è parte integrante della stessa. Addirittura è il “luogo a suonare voi” e non viceversa. In quale modo il luogo della performance può essere così determinante?
Ho avuto maestri più giovani di me, pazienti e comprensivi della mia inadeguatezza.
Questi giovani leoni hanno sempre le mani sporche di marmellata… così ho incominciato a chiedermi dove fosse la marmellata di questa generazione e cosa la rendesse così desiderabile a un cane sciolto come me…
Xabier ed io abbiamo un dialogo stretto e molte cose in comune, compresa una certa curiosità riguardo a ciò che spinge un uomo a esprimersi con il suono.
Ciò non toglie che abbiamo provenienze e declinazioni differenti. Fino ad un certo punto la nostra collaborazione ha avuto un aspetto più “concreto”: il lavoro sul suono, il treatment, lo spostamento semantico, il lavoro sul film “Kursk_truth in the end”.
Poi, quasi improvvisamente, abbiamo compreso quanto pulsante fosse questo metalinguaggio che si era formato e abbiamo incominciato a parlare della nostra come una ”musica dei luoghi”.
Il luogo che fu scelto per Your Very Eyes è una chiesa rupestre, una grotta che si chiama Santa Lucia alle Malve. A Matera. Un luogo che fosse acusticamente decisivo e che avesse una forza disvelante.
Quel disco è una specie di salmodia laica. E avviene che può nascere perché il luogo modifica, agisce e propaga in modo quasi soggettivo il suono. Considero questo duo un trio, dove il terzo elemento è il luogo.
Abbiamo portato questo lavoro in diversi luoghi e ogni volta abbiamo tenuto quest’apertura a farci determinare dalle risonanze a inglobarle e a farci fagocitare da loro.
Se ti consegni così, non sei tu che suoni, che hai il drive. Finisce che appartieni a qualcosa di più grande, è la musica che ti attraversa e tu non puoi fare che appartenervi.
Una specie di sublimazione reciproca. C’è una parte commovente in questa storia.
Oltre ad essere un valido musicista è anche un bravissimo artigiano. Da tantissimi anni si occupa di riparare sassofoni, sicuramente si può dire che la conoscenza del suo strumento ha raggiunto livelli enciclopedici. In che modo le due cose sono collegate? Pensa che anche un musicista può essere considerato a modo suo un artigiano?
Le due cose sono collegate in parte, nel senso che questo lavoro ti dà una possibilità di entrare in una dimensione relazionale profonda e al tempo stesso veramente concreta con lo strumento. E certamente mettere le mani “nella” fisica del suono, essere “sporco” di suono è una cosa che apre a un approccio più sciolto nella sperimentazione.
Grazie al mio lavoro ho toccato strumenti importanti e poveri, ho studiato e in parte compreso filosofie costruttive, compreso addirittura talune parabole artistiche di alcuni musicisti.
Credo che sarebbe straordinario analizzare in modo sistematico il cammino artistico di un Coltrane, ad esempio, attraverso lo studio delle qualità timbriche e strutturali gli strumenti che usò nel corso della sua carriera.
Se tu contempli un quadro di Vermeer o di Pollock, se segui la loro opera, puoi comprendere quanto sia importante a un dato momento l’utilizzo di una certa tecnica, che improvvisamente, così senza preavviso, aiuta a vedere, esprimere, sviscerare quello che l’artista ha nel cuore, imprimendo una svolta importante al loro stile.
In questo c’è un collegamento forse tra le due parti.
Molti saxofonisti cercano un suono dentro lo strumento e altri lo cercano in sé.
Io sono affascinato dalla complessità. Per me un musicista maturo ha una complessità, uno strumento dal suono complesso mi affascina di più di uno con un bel suono.
Ecco forse il vantaggio e il collegamento fra l’artigiano e il musicista. Ho la fortuna di stare molto a contatto con il suono.
Quali sono i musicisti, oltre a Steve Lacy, che l’hanno influenzata maggiormente in questi anni e perché?
Ho molti padri che amo e odio e che mi fanno compagnia. E che mi seguono da tanto tempo. Se la domanda si riferisce agli ultimi anni, la risposta è “nessuno” o “me stesso”.
Nel senso che mi pare che le linee per me fondamentali, dal punto di vista strettamente musicale, sono le stesse da qualche tempo, ormai: Cage, Feldman, Lacy, Mitchell, Ashley, Hemphill, Braxton e naturalmente Coltrane, Dolphy, Marion Brown.
Negli ultimi anni ho fatto attenzione a certi sviluppi, più manieristi se si vuole… Salvatore Sciarrino per esempio, per il quale ammetto un debole forse un po’ esagerato.
Un compositore ed esecutore straordinario che sempre mi incanta è Stefano Scodanibbio.
Le influenze più forti per me comunque giungono dalla pittura e dalla scultura: il 600 fiammingo è per me una cosa quasi insostenibile per la bellezza e la forza della luce, e poi Jackson Pollock, Braque.
Con Rothko ho un debito immenso, credo sia forse la mia più grande influenza degli ultimi anni. Come Samuel Beckett, Mark Rothko parla una lingua così diretta e profonda il cui potere affabulatorio è misterioso. Come per la musica, si rivolge a categorie opache, e ha il potere di muovere la prospettiva della fruizione.
Darei molto per avere la possibilità di suonare in una stanza con opere di Mark Rothko. Ho fatto un tentativo per ottenere il permesso di suonare in duo con Gianni Lenoci alla Rothko Chapel di Huston, TX, ma la faccenda è troppo complicata. Tuttavia non demordo…
Come se non bastasse da diverso tempo porta avanti anche un’ottima etichetta discografica, la Amirani Records, con la quale ha prodotto album di artisti del calibro di Anthony Braxton. Com’è nata questa collaborazione? Ha qualche aneddoto da raccontarci?
Beh, tutto è cominciato con un’idea di Cristiano Calcagnile che oltre ad essere un eccellente percussionista e compositore e improvvisatore, è una persona alla quale sono legato in modo speciale. E’ stato Cristiano, batterista del quartetto di Braxton, a suggerire la mia label ad Anthony…
E così si è chiuso un cerchio iniziato tanti anni fa, quando vidi il primo concerto di sax solo della mia vita, a Milano e un giovane Braxton entrava a far parte della mia esperienza…
In questa produzione tutto si è svolto con apertura e condivisione.
Ho voluto proporre un concept intorno all’idea di “standards”, (in fondo ripercorrendo un’idea di circa trent’anni prima, quando ascoltai “Donna Lee” suonata a una velocità incredibile sul clarinetto contrabbasso in quel vinile Steeplechase con Braxton e Montoliu al piano...) come un cammino spaziale attraverso forme date… così anche la copertina è stata pensata in quel modo: una donna che lieve attraversa il cortile arredato di opere di un museo...
E poi il bellissimo saggio di Erika Dagnino … A tutto questo Braxton ha sempre aderito con un entusiasmo, un’innocenza direi e al tempo stesso una lucidità e una consapevolezza artistica uniche.
Ecco un uomo del suo tempo con una visione totale e aperta. Certamente un migliore.
Riuscire ad “aprirsi” agli altri è l’unica cosa che conta nella musica d’improvvisazione? O secondo lei ci sono altri aspetti importanti di cui tenere conto?
La cosa più importante è aprirsi a se stessi, avere a che fare con una parte con certe volte non vorresti avere, stare con la difficoltà. Se faccio così il mio apporto all’improvvisazione, è doppio: da una parte imprimo una direzione e dall’altra ne assumo la responsabilità.
“Nell’improvvisazione è una questione di vita o di morte”, diceva Lacy.
Non sono sempre stato d’accordo con lui, tuttavia penso che una cosa non utile all’improvvisazione sia il nascondimento.
È una questione di responsabilità. Io raramente mi diverto, improvvisando.
Non so, mi sembra di avere a che fare con qualcosa di più grande. E sono molto orgoglioso per non dire la mia, ma abbastanza supponente da prenderne la responsabilità. Eppure finisco per appartenere alla musica e questo è meraviglioso.
Poi ci sono aspetti più formali che sono egualmente importanti: un senso multi - prospettico che negli ultimi anni, da quando l’improvvisazione si è divincolata dalle provenienze stilistiche in modo deciso, ha preso il sopravvento. E sempre più spesso l’improvvisazione sembra una composizione istantanea… anche questo è un aspetto che è emerso negli ultimi anni. C’è qualcosa di più perentorio che si può dire. Io sono per un’improvvisazione dove succede qualcosa, dove si agitino forme, dove si valichino confini.
Io penso a una drammaturgia dell’improvvisazione.
Rispetto a qualche tempo fa, ora cerco di non perdere di vista il senso complessivo di quello che sta succedendo mentre improvviso... la costruzione e la decostruzione, la dislocazione nello spazio, il peso timbrico, una specie di neo-narrazione che sgorga anche dal più radicale degli approcci…
Sto attento a non stare troppo attento, ecco.
Guardandosi indietro, quali sono stati i momenti fondamentali della sua carriera da musicista? Per fondamentali intendo quelli che hanno determinato una svolta nel suo approccio alla musica o al suo strumento.
È buffo parlare di carriera, davvero. Ma posso dire quali sono alcuni punti fondamentali e originatori di svolte in questo cammino confuso:
- l’innamoramento per i rumori di ogni genere (lo sono stato fin da ragazzo. Posso enumerarne decine, anche non più ascoltabili.)
- entrata di nascosto in un teatro durante le prove orchestrali di La Mer di Debussy
- lettura di “Silenzio” di John Cage
- interpretazione di Demetrio Stratos dei Mesostics di Cage
- concerto di Roscoe Mitchell trio con Tom Buckner e Gerald Oshita a Londra
- la frase pronunciata da Lacy a Bologna nel 94 durante uno stage “ and now let’s play it wrong”
- il periodo dolorosissimo di studio degli overtones sul soprano in un bosco lungo il fiume
- l’imboccatura preparatami da Jon Van Wie
- la decisione di circa quindici anni fa di imbracciare solo il sax soprano
- ascolto di For Samuel Beckett di Morton Feldman
- Suite per cello solo di Bach nella versione di Pierre Fournier
- il primo cd in solo per amirani records
- la morte di mio padre
Molto spesso si trova a suonare lontano dal nostro “bel paese”. Com’è la situazione per la musica d’improvvisazione nel resto dell’Europa e di conseguenza come giudica la situazione Italiana attualmente?
Io penso ci sia un problema di fruizione, o meglio, di modalità fruitiva.
Il musicista si trova oggi a ricoprire una serie di ruoli che forse neanche nel rinascimento avevano questo carattere multiplo… ma tutti gli sforzi produttivi, performativi, compositivi, improvvisativi, di studio ecc., si scontrano con una fruizione molto addomesticata, televisiva e in genere poco curiosa.
Forse un ripensamento circa il fatto che si tratta di comunicazione si deve fare.
In Italia la situazione è semplicemente drammatica, non ho altre parole.
Ci sono straordinari musicisti, ci sono musicisti meno straordinari, c’è un pubblico poco numeroso, pigro, forse stanco e ripiegato, ci sono poche e opache figure di mediazione.
Inoltre il panorama musicale dell’area improvvisativa è molto diviso e giace in tristi cortili.
C’è una certa corruzione mentale, direi. Una cosa che davvero ritengo impossibile è che ci sia pochissimo confronto, e qui uso una parola quasi fuori moda, “culturale”.
Tra i musicisti, intendo. Quasi che questo spazio di riflessione non possa essere che gestito a livello micro - societario, a tavola, in modo carbonaro…
Magari tornare a pensare che la musica, come le altre arti, ha un potere sublimativo che va ben oltre entrare nel circolo vizioso di produzione, recensione (banale anche quando molto buona) e scomparsa, potrebbe farci ricominciare a prendere respiri più ampi.
Pensiamo che noi facciamo cose che ri - penetrano la società, che l’improvvisazione è un indicatore di nuovi paradigmi sociali.
In Europa, trovo una maggiore curiosità e meno schemi precostituiti. La formazione musicale è ad altri livelli e la possibilità di condivisione più alta. Tuttavia sono tempi bui, nei quali mantenere la barra è prova non facile.
Di queste cose negli Stati Uniti se occupano le università, non dimenticando che il rapporto con il divenire sociale è per l’arte un parametro indimenticabile.
Siamo arrivati all’ultima domanda. Colgo l’occasione per ringraziarla e chiederle quali sono i suoi prossimi progetti?
Anch’io voglio ringraziarti per le domande e per l’occasione che mi hai dato per tentare nuove connessioni. È anche tempo di semina.
Ho al momento, musicalmente, diversi progetti attivi.
Il duo Reciprocal Uncles con il meraviglioso pianista Gianni Lenoci che uscirà nei primissimi mesi 2010. Una musica incredibilmente intensa e drammatica che portiamo in un micro tour negli Usa il prossimo dicembre. Con Gianni, l’intesa, la condivisione, lo spessore e il peso timbrico hanno immediatamente preso corpo dal primo momento.
Gianni ha un tocco molto elegante e un senso del silenzio molto contemporaneo e suonare con lui è “challenging”!
Il trio Granularities con Martin Mayes al corno francese e all’alphorn e Lawrence Casserley al signal processing instrument è una combinazione fantastica. Credo senza dubbio che Lawrence sia un guru del processing, il suo lavoro rivoluziona la gran parte delle mie intenzioni improvvisative e sposta gli elementi in modo imprevedibile. Il tutto in quadrifonia, con un lavoro di spazializzazione affascinante e per me nuovissimo.
La sua idea di accostare uno strumento di derivazione classica con il french horn, che nelle mani di Martin diviene flessibilissimo, al mio sax soprano crea un ibrido molto complesso e ricco di cose che vi si agitano dentro. I piani armonici e melodici sono traslati e la musica è assolutamente, starei per dire”fisicamente”, molto coinvolgente. Abbiamo avuto tre live bellissimi e siamo stati invitati al festival “Musiche Possibili” per il prossimo novembre all’Antica Sinagoga di Ivrea, dove registreremo e filmeremo e avremo anche il concerto trasmesso a Radio3 Battiti.
La mia idea di avere un trio con pianoforte e violoncello sta prendendo forma in questi giorni in UK dove con Hannah Marshall e al piano di Nicola Guazzaloca cerchiamo di dare forma a un incrocio timbrico che mi sta molto a cuore. Sono molto curioso di che potrà uscirne.
Sono ora in tour in Belgio con il chitarrista Enzo Rocco in una serie di date in duo e poi insieme al mio fidatissimo alter-ego trombonista Angelo Contini, Enzo e alla voce funambolica di Jean-Michel Van Schouwburg, a frantumare le certezze di Brussells, con il quartetto Sparkle 4.

Quattordici anni fa, all'uscita dei primi dischi dell'allora neonata Amirani Records, intervistammo il protagonista di quei dischi, nonché ideatore dell'etichetta, Gianni Mimmo, scoprendo un personaggio decisamente atipico, se non proprio unico. Da allora il sopranista pavese è stato autore di molti lavori di indubbio interesse, mentre la sua etichetta ha significativamente contribuito a diffondere in Italia la musica improvvisata e quella contemporanea, facendo conoscere importanti artisti italiani e stranieri. Siamo quindi tornati a parlare con Mimmo per conoscere l'attuale "stato dell'arte" sia della sua carriera di musicista, sia della Amirani.
All About Jazz: Cominciamo dalla dolorosa attualità: come hai passato quest'anno complicato di cautele e blocco delle attività pubbliche?
Gianni Mimmo: Il tempo si è aperto, credo avere sfruttato l'occasione per fare altro, principalmente per studiare, visto che l'attività concertistica è svanita e ho fatto solo due concerti live. Ti confesso che in più di un'occasione ho avuto la sensazione della necessità di quello "stop." Oggettivamente, stavamo correndo tutti come dei pazzi e improvvisamente avevo l'occasione per riflettere con calma. L'opportunità di riascoltare! Un vero lusso... e ho scoperto quanto fosse necessario riascoltare. Non trascurerei l'aspetto ammonitorio di questo tempo: ero troppo schiacciato sul fare e avevo bisogno di guardare. Per questa ragione, nonostante l'affermazione possa sembrare cinica (il prezzo pagato a questa pandemia è stato, e ancora è, altissimo), questo tempo ha avuto una sua importante utilità.
AAJ: La penso anch'io nello stesso modo e mi spiace che, invece, siano così pochi a rendersene conto. L'ansia dettata, anche comprensibilmente, da mille cose—il rischio del virus, il cambio di abitudini, l'assenza di reddito, i timori economici per il futuro—ha impedito ai più di cogliere i molti elementi positivi che ci offriva la situazione, che potevano essere un escamotage per cambiare qualcosa in un mondo che anche prima era pieno di aberrazioni.
GM: È vero, sebbene molti siano stati travolti dalle difficoltà. Ma non posso non sottolineare che, anche prima di questa situazione, le cose non andassero esattamente a gonfie vele e come la gran parte dei musicisti non vivesse di musica. Non posso dimenticare di quanto ci siamo lamentati per non avere il tempo di provare, di scrivere, di progettare... Questo forse era il momento per prendersi quel tempo. Ma può anche darsi che io veda le cose a questo modo per ragioni anagrafiche...
AAJ: In effetti gli anni passano: da quando ti intervistai la prima volta ne sono passati quattordici ed era appena nata Amirani Records, che oggi ha un bellissimo e invidiabile catalogo di sessantacinque titoli. Cominciamo da qui, dalla vita dell'etichetta.
GM: Guardavo il catalogo proprio qualche giorno fa e consideravo che complessivamente sono abbastanza soddisfatto di questi tre lustri di attività. Certo le condizioni sono profondamente mutate, a cominciare dalla liquidità della fruizione. Il catalogo è ora disponibile quasi completamente anche in digitale. Nel corso degli anni ho ricevuto davvero molto materiale, ho spesso rifiutato anche cose molto buone, ma sempre per ragioni di possibilità. Tuttavia, credo di avere tenuto aperto il ventaglio delle proposte editoriali e cercato di mantenere integra l'identità della label. C'è stato un periodo in cui ho immaginato la collaborazione si potesse allargare, potesse formarsi un team... Non è andata così. Forse l'Italia non è un paese adatto a formare squadre... o forse, più semplicemente, il mio versante individualista non agevola la collaborazione. Ma questo, in fondo, non ha penalizzato l'etichetta, direi. Forse ne ha indirizzato meglio l'identità, che oggi mi sembra sufficientemente chiara, magari a discapito di una più numerosa produzione.
AAJ: Sembra anche a me, proprio per questo ritengo che per la musica improvvisata in Italia Amirani sia stata un momento importante: le ha dato una visibilità e un'autorevolezza che a mio parere prima mancava. Non perché non ci fossero le etichette—penso per esempio a Setola di Maiale—ma perché la visibilità era diversa. E Amirani ha contribuito ad aumentarla per tutti.
GM: L'approccio editoriale era ed è molto diverso, perché l'ottimo Stefano Giust, con Setola di Maiale, ha un'apertura a 360 gradi. È una scelta coraggiosa e anche necessaria. Non credo esistano altri cataloghi di quella portata. Quando guardo i numeri resto sempre stupefatto, ha un catalogo immenso, con alcune cose di livello altissimo accanto ad altre più modeste, ma sempre genuine e frutto di un lavoro originale. Il mio lavoro è diverso. Personalmente sono sempre stato affascinato dalla "presunzione selettiva" del ruolo editoriale. Guarda per esempio certe case editrici librarie, osserva quanto sia importante il loro segno per l'opera che editano. È come un abbraccio che scalda ciò che pubblicano. Certe label hanno questa stessa caratteristica. Cito sempre l'austriaca Kairos, che adoro, per fare un esempio. La mia presunzione ulteriore è di avere questa funzione pur senza sovvenzioni, senza una squadra, artigianalmente. "L'orgoglio del pezzente," avrebbe detto mio padre.
AAJ: In effetti credo che la caratteristica di Amirani sia stata quella di presentare molto bene, anche a livello di copertine e libretti, lavori tutti di qualità e tutti di un genere magari ampio, ma comunque sempre identificabile in ragione della sua radicalità. E questo ha permesso di alzare il livello dell'immagine della musica improvvisata nel nostro Paese.
GM: Mi trovo spesso a insistere con i musicisti affinché ci sia rigore. Quello che si pubblica non deve essere un demo, deve avere la dignità per stare in un catalogo. Questo valeva per Amirani Records già ai suoi esordi, quindici anni fa, ma oggi forse ancora di più. Liquidità della musica e della fruizione, frammentazione dell'esperienza, piattaforme internet confusive a costo zero: perché fare un CD o un LP, costoso, faticoso e ascoltato molto meno? Un lavoro si pubblica quando si vuol mirare in un altro luogo, lasciare l'opera come un segno cui poter ritornare fisicamente. E questo può servire, come è infatti accaduto, a dare una visibilità e una dignità pubblica diversa al settore, a far sì che quell'opera non si perda nel mare delle proposte, possa essere ricercata anche a distanza di anni, oppure essere notata da soggetti che altrimenti non se ne sarebbero accorti. Io sono un po' old fashioned, l'ascolto per me continua ad avere un aspetto rituale, in un certo senso. Un buon esempio può essere la prossima uscita di Amirani: un lavoro del trombettista e compositore Mario Mariotti intorno all'opera di Boris Vian, in collaborazione con l'editore Marcos Y Marcos. Il disco, in vinile a tiratura limitata, sarà distribuito insieme al libro di Vian. Piccoli numeri, si intende, ma cose belle e fatte per bene, produrre le quali ha un valore in sé.
AAJ: E che, di nuovo, hanno la possibilità di gettare altra luce su un settore della musica altrimenti non solo trascurato, ma anche difficile da far conoscere per la sua indubbia singolarità.
GM: Anche da un punto di vista terminologico non è facile comunicare intorno a questa musica. La vocalist e performer inglese Viv Corringham mi raccontava che nel presentare per promuovere i suoi lavori evitava di usare la parola "sperimentale," in quanto intimorisce chi la legge o sente. Anche l'espressione "musica di ricerca" è controproducente. Picasso affermava che nessuno è interessato a uno che cerca qualcosa di nuovo, ma guarda con attenzione a chi ha trovato qualcosa: "Quando dipingo, il mio obiettivo è mostrare ciò che ho trovato, e non ciò che sto cercando. In arte le intenzioni non bastano."
AAJ: Ed è anche per questo genere di difficoltà, mi pare, che diventa importante la valorizzazione di tutto ciò che sta attorno alla musica: per comunicare con chi non conosce questo tipo di musica e far passare che c'è altro dietro quei suoni che al primo ascolto un inesperto potrebbe semplicemente considerare sgraziati e privi tanto di logica, quanto d'interesse.
GM: L'obiettivo è far giungere questa musica laddove non arriva. Condizione senza la quale il rischio di autoreferenzialità è alto, magari lamentando un immeritato isolamento. Ogni luogo è diverso e peculiare naturalmente, ma in Italia trovo necessario (ri)-costruire una relazione con l'audience, cosa che si è andata smarrendo nel tempo. Più che in passato tendo a costruire una relazione anche attraverso le parole. Nulla di particolare: indicazioni su quello che farò, oppure ho appena fatto; considerazioni su quel che mi guida, o che ho provato suonando. È questo un aspetto spesso trascurato, invece credo che su questo piano ci sia molto da fare, che curare con la giusta misura questa relazione permetta di rendere il cammino dell'ascoltatore in quella matassa di stimoli che gli viene offerta. C'è stato un tempo in cui l'ascolto era più attivo, meno "seduto," e questo tipo di aiuto non era necessario; ma oggi le condizioni sono veramente mutate.
AAJ: Io aggiungerei anche che si corre il rischio di scivolare nell'ideologia dell'ascolto non mediato, che ha un suo indiscutibile valore, ma va bene solo per l'ascoltatore già pronto ad affrontarlo. Nessuno "nasce" predisposto ad ascoltare la classica o il jazz o la contemporanea: se ne diviene capaci grazie a processi educativi attraverso i quali, spesso, si è passati inconsapevolmente; processi analoghi per la musica improvvisata sono rari: perché rifiutarsi di spargerne dei semi? Forse perché, come dice qualcuno, sarebbe paternalistico? Ebbene, credo sia il momento di riconoscere che ogni processo formativo è paternalistico, ma che togliendo quel paternalismo restano solo l'ignoranza e l'incompetenza, camuffate da "spontaneità."
GM: Condivido, ritengo davvero molto importante la ricucitura del rapporto tra opera e fruizione. La viva fragranza di ciò che accade nell'improvvisazione è talmente importante che non può esser buttata lì, confusa con altri stimoli. Credo sia importante individuare una strada, una lettura, attraverso la quale i diversi piani di ricezione di chi ascolta possano trovare il modo di cogliere gli elementi di interesse, di far voltare lo sguardo verso quel che accade, così da far tornare a casa le persone con la consapevolezza che durante il concerto sia successo, anche solo per alcuni momenti, qualcosa di vivo e rilevante. Vedo che anche le cose più ostiche, se introdotte, riescono a essere avvicinate meglio da un maggior numero di persone, per cui oggi fare qualcosa del genere mi sembra necessario. Il chitarrista John Russell, che è da poco prematuramente scomparso, mi ha ripetuto più volte come fosse necessario "to stay welcoming."
AAJ: Penso che servano anche nuovi spazi e nuove rassegne, che oggi mi pare manchino quasi completamente. Perché anche le cornici sono importanti ed è fondamentale che siano diverse da quelle di altri generi musicali.
GM: Questa è un'altra cosa sulla quale spesso insisto con le persone con cui collaboro, siano essi musicisti, organizzatori, responsabili di istituzioni: gli spazi devono avere il medesimo tipo di rigoredella musica che vi eseguiamo. Non possono essere buttati là: un pensiero vi deve risiedere. Se vogliamo avere spazi e possibilità -dobbiamo farlo mostrando di avere una caratura che ci differenzi e che dimostri il nostro peso. Un profilo magari di nicchia, ma che in mancanza di quella cura non avrà il riconoscimento che gli spetta. In un workshop che tenni nel Regno Unito ho usato l'espressione a detached profile per indicare questa figura.
AAJ: Un profilo—mi permetto di aggiungere—che potrebbe includere un aspetto importante dal punto di vista generale e umano, e che invece viene spesso trascurato: il fatto che l'improvvisazione non è solo un genere musicale, né è caratteristica solo dell'arte, bensì è una forma d'agire che l'uomo utilizza sempre e ovunque, anzi, che esercitiamo quotidianamente tutti, senza però che ci si sia mai occupati molto né di capire come la usiamo, né di imparare a usarla meglio. Parlarne, o farvi cenno, potrebbe avvicinare molti all'improvvisazione musicale.
GM: Ricordo che anni fa al Dimitria Festival di Salonicco, dove mi trovavo con Gianni Lenoci, il pianista Sakis Papadimitriou, che era il direttore artistico per la sezione "improvvisazione" del festival, ci chiese di fare una specie di introduzione approfondita prima dei concerti, ritenendo fosse proprio ciò che mancava al contesto della rassegna. Io e Gianni ci appassionammo alla cosa e gli esiti furono davvero interessanti: non solo un numero particolarmente elevato di spettatori al concerto, ma anche una serie di scambi e riflessioni successive al live, con i commenti del pubblico e anche di artisti di campi diversi. Ricordo l'intervento molto pertinente di un pittore che introdusse un confronto con l'ispirazione a dipingere, a partire dalle spiegazioni preliminari che avevamo dato. Una signora nel pubblico trovò una curiosa relazione tra quella musica e la freschezza dello sguardo, parlò di fragranza e disincanto. Bellissimo.
AAJ: Tornando ad Amirani, oggi qual è lo stato dell'arte?
GM: Le ultime uscite sono state molto ben accolte e importanti anche sul piano del coinvolgimento produttivo e personale. Di solito non brillo per autoindulgenza, ma credo di aver fatto un buon lavoro. Credo che in alcune di queste l'intensità creativa sia piuttosto alta. L'ultimo nato, A Few Steps Beyond, ultimo concerto tenuto dallo "zio" Gianni Lenoci, in solo al Talos Festival 2019, pochi giorni prima della sua scomparsa, è anche un documento importante e luminoso.
AAJ: So peraltro che ci si sta occupando degli inediti di Gianni, ne parlava il suo allievo Francesco Massaro in un'intervista di qualche mese fa.
GM: Sì, c'è moltissimo materiale, alcune cose molto buone. Mi auspico che, per gestirlo, si formi un soggetto con un profilo capace di valorizzare la grande quantità e la qualità delle cose che Gianni ha lasciato sui tanti versanti che lo interessavano: compositivo, esecutivo, didattico, critico. Il libro appena pubblicato da Haze-Auditorium Alchimia dell'istante, ci regala uno sguardo sulle molte sfaccettature della sua personalità artistica, la cultura non solo musicale e la sua acutezza: il suo lascito non può e non deve essere sprecato. Tornando all'etichetta, vorrei riservarmi un'uscita per un mio lavoro in solo, per poi dedicarmi a una ben precisa programmazione delle uscite successive: vorrei continuare a selezionare, anzi forse farlo ancor di più che in passato, limitandomi a due o tre dischi l'anno, ma curando molto tutto dal punto di vista concettuale. Insomma, guardando avanti l'etichetta farà meno ma, spero, farà meglio, selezionando i materiali migliori e pensando molto i progetti editoriali.
AAJ: Mi sembra una buona direzione, anche alla luce di quel che dicevamo prima: distinguere ciò che viene editato su disco da quel che finisce in rete, valorizzandone le specificità.
GM: L'esperienza sembra dire che l'edizione limitata, se ben presentata e curata, comunque arriva. Proprio stamattina da Anversa mi hanno chiesto il cofanetto (6 CD) di Anthony Braxton, che è il numero 14 del catalogo, adesso siamo al numero 65. Il fatto che cerchino un disco così "vecchio" significa che il catalogo funziona: mantiene attenzione sui prodotti artistici che raccoglie, fa sì che non ci si dimentichi di loro. Amirani Records ha anche qualche ascoltatore affezionato in giro per il pianeta: USA, Europa e Giappone. Alcuni fedelissimi collezionisti. Aggiungiamo anche che le uscite in vinile (per ora solo tre in catalogo) raccolgono nuove adesioni e interesse trasversale. Quando incisi il mio solo Further Considerations, per Tarzan Records, mi trovai a riflettere in modo differente alla musica che volevo fare. Il vinile cambia gli spazi disponibili—due facciate relativamente brevi—ti forza a pensare diversamente la tua progettualità. Inoltre, l'oggetto in sé presenta aspetti di relazione interessanti e nuovi per chi non lo conosce (per chi non è nato con i vinili). A parte il vezzo (mi è capitato diverse volte di vendere LP a chi non possedeva il giradischi!), vi è un aspetto rituale nel mettere un disco sul piatto, che chiama a una relazione forse nuova con l'oggetto per i più giovani... Non saprei dire. A me piacciono moltissimo e ne posseggo una quantità...
AAJ: Questo mi ricorda una cosa che ho ascoltato da Wolfgang Sachs, uno dei padri dell'ambientalismo, il quale per rivalutare il concetto di limite—che di solito pensiamo solo come una cosa negativa—usava la metafora del quadro, osservando che il pittore deve la possibilità di realizzare qualcosa di artistico proprio alla limitatezza dello spazio disponibile sulla tela: senza quel limite, finirebbe solo per riprodurre la realtà.
GM: In generale quello del limite è un concetto chiave, nell'improvvisazione e anche nell'esecuzione di partiture grafiche, una pratica compositiva e tattica cui faccio talvolta ricorso. Dirimente, all'interno di un contesto pulviscolare, capire come gestire la libertà e come costruire, o essere parte di, una forma, che è poi ciò che esprime la libertà stessa. Steve Lacy insisteva sull'utilità dei tight corners, il limite come luogo cui dedicarsi. Martin Davidson di Emanem ha pubblicato del materiale inedito di Steve in un album intitolato Free for a Minute, sua espressione fulminante per comunicare la necessità di darsi dei tempi per la libertà, senza i quali non si può neppure capire di essere stati liberi.
AAJ: In proposito, e in riferimento anche alla facilità di pubblicazione "liquida" delle performance di cui parlavamo, a me sembra che quest'ultima abbia insito il rischio di documentare anche improvvisazioni "non riuscite," ovvero concerti nei quali le cose "sono andate," ma non si è prodotto qualcosa dotato di una forma chiara. Secondo te, come si può distinguere un'improvvisazione "riuscita" da una che non lo è?
GM: Credo si possa dire che il discrimine risieda nella qualità, nella sincerità artistica. E che il rischio principale dell'improvvisazione sia il "catalogo," una pratica espositiva che fa ricorso all'intero vocabolario posseduto. È una cosa che succede spesso, l'ho vista fare anche ad alcuni miei "dei." È un rischio che bisogna correre e trascendere. L'improvvisazione ha forse a che fare con un'eccedenza, se è efficace produce qualcosa che rimane a farsi osservare per qualche tempo. Lascia segni. Il problema si situa nel passaggio dalla soggettività all'oggettività: quando si improvvisa, il punto di partenza è inevitabilmente la posizione dell'ego, che decide come e cosa agire nel suono. Ma, dopo questo avvio, è necessario andar oltre, applicando una determinata qualità complessiva di produzione e di ascolto. Se questo processo avviene si è anche in grado di lasciare, superare quella fase egoica, arrivando ad "appartenere" a quel che si suona, quasi fosse la musica a suonare il musicista. Questo passaggio è ciò che determina la qualità di un processo improvvisativo, lo avverto come dirimente. Non è facile descriverlo, o almeno io non ho molte parole per farlo meglio di così, ma è davvero ciò che distingue le improvvisazioni significative da quelle che non lo sono. Anzi, che talvolta sono proprio noiose, perché permeate da una catalogazione auto-affermativa, ombelicale. L'improvvisazione meglio riuscita ha un maggiore rispetto per il silenzio e per le voci di tutti. Per la forma, in definitiva. Un processo meno sommatorio, più luminoso direi. "Act not Re-Act."
AAJ: Cosa intendi per "forma"?
GM: In questa accezione, intendo per "forma," agire la pratica improvvisativa esercitando una visione del particolare e al tempo stesso, possibilmente, globale. Per me questo vale anche nella solo performance, non è una caratteristica esclusiva della comunicazione con gli altri. È ovvio che tutti noi abbiamo i nostri licks, la nostra biblioteca, tuttavia è importante che vi si arrivi ogni volta con freschezza e innocenza, quasi fosse la prima volta. È proprio questo che ci consente di guardare alle stesse cose con prospettive differenti e con stimoli diversi. Se si mantiene questo tipo di qualità, umana ancor prima che musicale, difficilmente un'improvvisazione fallisce: può darsi che non arrivi a quel livello di perfezione formale cui aspiravamo ma, se c'è questo passaggio dal decidere all'essere deciso e si riesce a non scivolare nel catalogo, allora la "riuscita" è quasi sempre assicurata. Non so se sono riuscito a rispondere...
AAJ: Sì, per quanto è oggi possibile rispondere non solo a te, ma a chiunque altro, direi di sì. Il problema è che ci si è sempre occupati troppo poco dell'improvvisazione, non solo come modalità artistica musicale, ma come prassi umana in generale, per cui siamo carenti in primo luogo di strumenti linguistici e concettuali, una lacuna che paga chiunque provi a esprimersi sull'argomento.
GM: Aggiungerei solo una cosa: ciò che informa l'improvvisazione è molto di più di quel che noi musicisti pensiamo. Noi stessi dobbiamo cercare di comprendere cosa sia questo "di più." Ricordo che Ran Blake, in un suo bellissimo libro, dice che questa musica è così ricca perché molte cose vi abitano e per suonarla bene è necessario guardarsi attorno, essere consapevoli del periodo storico in cui si vive, essere attivi e aperti rispetto al mondo. Non basta suonare e saper suonare, per fare improvvisazione.
AAJ: Con ciò siamo già passati da Amirani Records all'artista Gianni Mimmo, che con l'etichetta discografica è certo intrecciato, ma è anche ben altro, sia perché Amirani non si riduce a te, sia perché pubblichi anche altrove. E tu, in questi quattordici anni, di esperienze ne hai fatte tantissime, lavorando con musicisti più o meno noti, ma spesso veramente straordinari.
GM: Senza dubbio la nascita di Amirani Records ha aiutato anche la mia attività di musicista, forse rendendomi più visibile. Però, anche dopo la sua apertura, alcune delle mie collaborazioni sono nate semplicemente per affinità artistica. Quella con Satoko Fujii, per esempio, è iniziata perché Fabrizio Perissinotto di LongSong Records -che conosce bene il mio lavoro e che aveva da poco pubblicato un lavoro della Fujii -un giorno mi ha detto papale-papale: "Tu devi assolutamente suonare con Satoko, c'è un'affinità ineludibile." Il live a Milano e il giorno dopo la registrazione in studio sono stati semplicemente formidabili. Il disco Triad , pubblicato da LongSong è andato davvero molto bene. Nel mio tour in Giappone abbiamo suonato, anche assieme a Natsuki Tamura, in diverse occasioni. E così è nata un'intesa che poi abbiamo sfruttato in altri concerti e nelle registrazioni con Joe Fonda al contrabbasso.
Con quel trio dovevamo essere in tour in Austria, Germania e Polonia proprio adesso, ma ovviamente è saltato tutto per la pandemia. Da poco ci hanno confermato lo slittamento delle date all'anno prossimo, il 2022, speriamo bene. Joe era veramente entusiasta del trio: lui, oltre che estremamente capace, è molto generoso e offre una quantità di suggestioni, quasi tutte leggibili; Satoko, invece, ha un incedere quasi misterioso e per certi versi ricorda l'attitudine di Achim Kaufmann, pianista sopraffino del Sestetto Internazionale che ho costituito insieme ad Harri Sjolstrom: c'è un'estetica sempre sorprendente, una certa fragranza, che richiede dapprima concentrazione e anche una certa sobrietà, un equilibrio da abbandonare e cui ritornare.
Con altri le affinità sono profondissime... con Gianni Lenoci, per esempio, la nostra condivisione era sopraffina, mi mancherà per sempre. Con Alison Blunt, altra artista cui sono assai legato, abbiamo fatto molte cose e abbiamo una relazione quasi telepatica, nonostante siamo molto diversi. Anche la collaborazione con Vinny Golia è nata esclusivamente da affinità artistiche: ci incontrammo nel 2009 negli Stati Uniti, mentre ero là con Angelo Contini e Stefano Pastor per un'iniziativa sull'improvvisazione presso l'università di Denver, Colorado. Avemmo così occasione di ascoltarci reciprocamente dal vivo (io come musicista ovviamente lo conoscevo già), ci piacemmo, passammo del buon tempo a tavola e decidemmo subito di collaborare. Abbiamo dovuto aspettare il 2014, quando ho fatto un lungo e bellissimo tour negli Stati Uniti con Alison. Avevamo anche quattro date in California e la contrabbassista Lisa Mezzacappa riuscì a organizzarci un'occasione per suonare insieme. Da allora non ci siamo più mollati, siamo diventati molto amici e ci sentiamo spesso, ancora nei giorni scorsi... Abbiamo suonato in molti posti d'Europa, anche con lo "zio" [Gianni Lenoci]. In concerto Vinny è una macchina da guerra, ma condividiamo anche molte risate. Insegna al California Institute for Arts di Los Angeles, un gran bel posto, e adesso sta scrivendo dei bellissimi brani per orchestra. Ho un bel legame di amicizia e di collaborazione anche con il clarinettista tedesco Ove Volquartz, ho suonato moltissimo con lui... Ho avuto molte collaborazioni con artisti assai distanti per derivazione, trovando spesso la profondità, la sincerità: questo è davvero un privilegio.
AAJ: Sono curioso di sapere qualcosa anche delle tue collaborazioni con Silvia Corda e Adriano Orrù.
GM: Silvia e Adriano sono artisti gentili, preparati, colti e al tempo stesso semplici. Qualità rarissime. Mi verrebbe di dire che sono persone necessarie. Musicalmente, Silvia è bravissima e non smette di apprendere: adesso sta studiando "Musica ricercata" di Ligeti e "Diary" del compositore cinese Xiaoyong Chen. Sotto una leggera scorza si nasconde una grande intensità. Nel live emerge piano piano, ma inesorabilmente. Adriano è solido, ha un bel suono grave e sa ascoltare, cosicché in trio funzioniamo benissimo e, col passare del tempo, mi rendo conto che ho sempre meno necessità di spingere, c'è un bellissimo amalgama tra spazio e densità. Anche con loro (unitamente al percussionista Thierry Wazianiak, mio partner nel trio di Yoko Miura) più o meno di questi tempi dovevamo essere in tour in Francia, ed è il secondo anno che rinviamo.... Con Silvia, però in duo, ho anche fatto uno dei miei ultimi concerti dal vivo, a Cala Gonone Jazz lo scorso luglio. I tempi sono maturi per incidere un secondo album, dopo Clairvoyance, stiamo riflettendo sul programma. Quella è una formazione piuttosto cameristica, avere un'idea di come disporre i pesi drammatici di quel tipo di narrazione può permettere di ottenere un prodotto più compiuto. E loro sono persone con le quali è bello fare questo tipo di esperienze. Ci penalizza il fatto di vivere un po' lontani, ma siamo sempre in stretto contatto e senz'altro riusciremo.
AAJ: Artisti di provenienze geografiche e con ascendenze molto diverse l'uno dall'altro. A parte l'amore per modalità improvvisativa, c'è qualcosa che permetta di accomunarli, delle ascendenze stilistiche o degli ascolti che condividete?
GM: Sicuramente sì, senza però che sia possibile farne un elenco, perché siamo tutti molto aperti, curiosi, interessati a tantissime cose diverse. Considero che ci siano nomi imprescindibili che compaiono spesso nelle conversazioni... sia del mondo del jazz che della musica classica o contemporanea o antica. Tuttavia, oltre al rispetto e al peso stilistico dei giganti, compaiono spesso derivazioni estetiche originali, dei punti nodali per ognuno che risiedono in nomi secondari, ma illuminanti che presiedono le scelte di ciascuno di noi. Delle affinità che legano in modo sorprendente tempi e stili distanti. Personalmente credo di aver un debito con la scuola viennese dei primi del secolo scorso: Berg, Webern, eccetera. Lì io trovo una luce obliqua che ricompare in Braxton, così come il Roscoe Mitchell degli ensemble cameristici non ha un afflato lontano da certe arditezze di Gesualdo. Molti musicisti con i quali ho lavorato mi hanno suggerito ascolti specifici, alcuni solo per la luce di un intervallo, di una combinazione armonica... Questo del lockdown è stato un tempo per studiare, per ritrovare cose. Tracce di altri musicisti, semi coltivati da Eric Dolphy, resi noti da Yusef Lateef, riemersi in certe frasi di Bennie Wallace. Un intrico di sentieri nei quali spesso i rimandi sono così sorprendenti...
AAJ: Oltre a quel che dicevi, hai altri progetti in vista?
GM: Il mio ultimo concerto dal vivo è stato lo scorso 30 settembre al teatro Radar di Monopoli. Era l'anniversario della scomparsa di Gianni, in quell'occasione avevo portato un lavoro intitolato The Lost Frames, la mia musica intorno/insieme alle immagini di Andrea Montanari, che a sua volta aveva collaborato con Gianni un paio di anni prima. Il giorno dopo il contrabbassista Pierpaolo Martino e Francesco Cusa, che come sai ha lavorato intensamente con Gianni negli ultimi anni della sua vita, hanno fissato una sessione di registrazione nello studio di Mimmo Galizia. Ho ascoltato proprio in questi giorni il master di quella seduta. Ne è uscita una cosa piuttosto interessante, che ha un colore "telefilmico," un po' notturno. Ci trovavamo nello studio che era un po' la seconda casa di Gianni. Il pianoforte coperto ci ha osservato per tutto il tempo. Non tutti sanno della passione che aveva per certe serie televisive degli anni '60 e '70. Gianni conosceva bene la serie del Tenente Colombo e ricordava i primissimi episodi nei quali l'estetica della borghesia californiana contemplava scene di interni nei quali comparivano dipinti di Rothko, Barnett Newman e McLaughlin... A San Francisco, stavamo in piedi a guardare certi incroci e ci dicevamo che il set era la città, già pronto. Poco dopo sul molo gli scattai la foto accanto a Farrah Fawcett... Per farla breve, credo che pubblicheremo entro l'estate questo album per il quale abbiamo scelto tutti titoli, appunto, ispirati a telefilm. Sarà un po' la colonna sonora di quel momento di memoria. Perciò sarà in parte buffo, in parte groovy e in parte perfino lirico, quasi fossero i titoli di coda di un telefilm visto tanti anni fa.
AAJ: Curioso, o forse persino rivelatore, che una cosa così sia nata proprio in occasione di una commemorazione.
GM: Infine, come dicevo, nel corso di quest'anno di ritiro obbligato ho riordinato un po' di idee, perfezionandone alcune, cosicché ho una serie di cose pronte, per quintetto e per sestetto, che vorrei riprendere e realizzare una volta usciti/transitati dalla pandemia. Ma ripartire non sarà facilissimo e, come osservavo, sarà necessario ricreare anche modi e—soprattutto—luoghi dove fare musica: i migliori concerti che ricordo di aver fatto sono avvenuti in spazi come chiese, musei, atelier, nei quali l'arte era già a proprio agio, così che le antenne dei presenti—artisti e spettatori—erano già tutte dritte. Sarebbe bello ripartire tenendone conto. Per l'estate ci sono alcuni concerti in programma in Italia. Per scaramanzia aspetterei ad annunciarli...

MUSICISTI E PENSATORI ITALIANI: GIANNI MIMMO, UN COSMOPOLITA
Iniziamo una serie di interviste ad artisti attivi nel mondo della ricerca musicale contemporanea. Musicisti e pensatori italiani che non vedono la musica come mero intrattenimento o merce di consumo, ma come un linguaggio in continua evoluzione che ci porti a riflettere più per i dubbi che solleva che per le soluzioni che offre
Gianni Mimmo, musicista, artigiano e produttore discografico con una forte propensione al cosmopolitismo, si racconta rispondendo ad alcune domande sul proprio percorso artistico e sul proprio concetto di fare musica oggi. È possibile acquistare e ascoltare gli eccellenti lavori discografici registrati da Gianni Mimmo e prodotti da Amirani Records collegandosi al sito: https://www.amiranirecords.com/contacts
1. Gianni potresti raccontare brevemente ai lettori il tuo percorso artistico?
Molteplice nelle applicazioni, unitario nelle radici. Ho recentemente riconsiderato quanto questo percorso sia ancora profondamente ancorato alle radici che lo hanno generato. La mia impressione è che, avendo attraversato la temperie degli anni ‘70 e ’80 del secolo scorso, la formazione e il suo divenire siano profondamente informati dalla pluralità di fonti di ispirazione che hanno colorato quei tempi. La musica e l’esperienza creativa in genere erano intese come una possibilità sublimativa. Molte intersezioni fra ambiti: teatro,rapporto musica-testo, improvvisazione e poesia, arte visiva e danza.
Il tutto innestato sull’irruento contributo che il jazz andava assumendo nelle sue derivazioni più spericolate, della musica contemporanea e del suo rapporto con la dimensione sociale. Categorie altissime delle quali oggi parliamo in modo preminentemente antologico e documentale.
Era una musica forse più cosciente del contesto storico e l’omologazione successiva ancora non ben visibile all’orizzonte.
Ho lavorato a lungo sul rapporto musica-testo, musica-immagine e credo che questo abbia inesorabilmente segnato anche la mia parte più squisitamente musicale. Nel corso degli anni, e in particolare nella relazione con la scena internazionale della improvvisazione, ho intersecato molte esperienze di differente derivazione, ma non sono un eclettico.
2. Chi sono gli artisti, in senso lato, che maggiormente ti hanno influenzato e allo stesso tempo come hai sviluppato la tua ricerca verso un linguaggio personale?
Ho un pantheon piuttosto ampio cui guardo, impossibile menzionare tutti, pittori come De Chirico e Mondrian, come Bacon o Scialoja hanno enormemente influenzato la mia musica. Il rapporto formale fra gli elementi sonori ha molto a che fare con l’oggettivazione che possiamo osservare in un dipinto o in una scultura. Le mie influenze più propriamente musicali sono rintracciabili in Steve Lacy, Roscoe Mitchell, Anthony Braxton, ma ho un debito “estetico” verso Alban Berg, Anton Webern e quell’area viennese. Queste influenze sono per me egualmente importanti ed è spesso nell’accostamento di elementi distanti che trovo una prospettiva interessante.
La mia improvvisazione, per esempio, ha preso a manifestare un carattere compositivo. Cerco di mantenere uno sguardo particolare, ma anche di non perdere una visione più globale. Dal punto di vista di rapporto con lo strumento sax soprano, l’evoluzione di un segno originale è proprio legata a questa molteplicità di scintille che la animano. Non so quanto questo sia personale, ma certamente è quello cui mi è naturale tendere.
3. Sei ideatore di numerosi progetti multimediali: qual è il rapporto fra la tua musica con le altre arti? Su quale piano e in che modo avviene il tuo confronto con un’opera visuale piuttosto che un testo scritto?
Il rapporto è strettissimo sul piano ispirativo e sul piano progettuale. Ispirativo perché, per quanto mi riguarda, il livello formale in, per esempio, pittura e scultura possiede una fortissima relazione con la composizione e con l’improvvisazione. Tendo a pensare la musica come luogo, come dislocazione degli elementi, il materiale sonoro, nello spazio. Vi sono gradi di distribuzione dei pesi drammatici, significativi, di colori timbrici che articolano in un brano musicale così come elementi stilistici, toni e pigmenti, figure e prospettive in un dipinto. In un festival lo scorso anno ho avuto occasione di suonare accompagnando un danzatore. La commissione era l’interpretazione di uno spazio, all’interno di un piccolo museo, nel quale era ospitata una scultura piuttosto grande di un artista giapponese. Nella mia improvvisazione, che a sua volta era sollecitata da improvvisi cambi di prospettiva provocati dalla gestualità corporea del danzatore, lo sviluppo delle linee musicali, la loro geometria direi, era molto influenzato dalla pulizia, dal nitore, di certe parti di quella scultura. Qualcosa di pesante sostenuto da qualcosa di leggerissimo, la danza fluida all’interno di uno spazio chiuso. Ne è nata una piccola suite, nella quale, pur nell’approccio astratto, è come se indugiassi in un lirismo scarno, ma narrativo per suggerimenti, accenni.
Ho ripetuto in diverse occasioni che un lavoro artistico sussiste di per sé. Un dipinto è un dipinto, una poesia è una poesia. La musica non necessita di poesia e la poesia non necessita di musica. Se sul piano progettuale si accostano musica e poesia, per esempio, entrambi le componenti devono cedere qualcosa, altrimenti si ottengono degli sterili accostamenti, didascalici. Non necessari, ecco. Ma quel nuovo terreno è fatto di molti sentieri, alcuni importanti altri diversivi. Il testo poetico contiene una speech melody, una linea sonora che è suggestiva in molti modi: per senso, per fonemi, per lirismi, per attriti sillabici. Dal punto di vista strumentale si attuano reazioni, fondali, anticipi, ripetizioni e cadenze. Le parole diventano un po’ musica e la musica diventa più parola. Il risultato offre spesso una prospettiva inedita, uno sguardo laterale e rivelatore. Un mio maestro fece un’operazione interessante lavorando con un testo tratto da una guida turistica. La musica aveva conferito a quelle parole un’inesorabilità che a una semplice lettura non potevano avere.
Ho un progetto che porto in giro da un po’: Seven Paintings. In sostanza suono sette improvvisazioni mentre alle mie spalle vengono proiettati sette dipinti in successione. Gli autori di questi quadri sono molto diversi fra loro per epoca e stile. Accade sempre, e a tutte le latitudini, che l’audience attraversi quei dipinti in un modo nuovo, fresco, inaspettato. Piero Della Francesca e Francis Bacon sono nuovi, la musica offre una finestra nuova, un altro sguardo. La parte magica consiste nel fatto che la stessa musica suona in modo nuovo, come se l’immagine ne informasse il percorso.
Il rapporto è strettissimo sul piano ispirativo e sul piano progettuale. Ispirativo perché, per quanto mi riguarda, il livello formale in, per esempio, pittura e scultura possiede una fortissima relazione con la composizione e con l’improvvisazione. Tendo a pensare la musica come luogo, come dislocazione degli elementi, il materiale sonoro, nello spazio. Vi sono gradi di distribuzione dei pesi drammatici, significativi, di colori timbrici che articolano in un brano musicale così come elementi stilistici, toni e pigmenti, figure e prospettive in un dipinto. In un festival lo scorso anno ho avuto occasione di suonare accompagnando un danzatore. La commissione era l’interpretazione di uno spazio, all’interno di un piccolo museo, nel quale era ospitata una scultura piuttosto grande di un artista giapponese. Nella mia improvvisazione, che a sua volta era sollecitata da improvvisi cambi di prospettiva provocati dalla gestualità corporea del danzatore, lo sviluppo delle linee musicali, la loro geometria direi, era molto influenzato dalla pulizia, dal nitore, di certe parti di quella scultura. Qualcosa di pesante sostenuto da qualcosa di leggerissimo, la danza fluida all’interno di uno spazio chiuso. Ne è nata una piccola suite, nella quale, pur nell’approccio astratto, è come se indugiassi in un lirismo scarno, ma narrativo per suggerimenti, accenni.
Ho ripetuto in diverse occasioni che un lavoro artistico sussiste di per sé. Un dipinto è un dipinto, una poesia è una poesia. La musica non necessita di poesia e la poesia non necessita di musica. Se sul piano progettuale si accostano musica e poesia, per esempio, entrambi le componenti devono cedere qualcosa, altrimenti si ottengono degli sterili accostamenti, didascalici. Non necessari, ecco. Ma quel nuovo terreno è fatto di molti sentieri, alcuni importanti altri diversivi. Il testo poetico contiene una speech melody, una linea sonora che è suggestiva in molti modi: per senso, per fonemi, per lirismi, per attriti sillabici. Dal punto di vista strumentale si attuano reazioni, fondali, anticipi, ripetizioni e cadenze. Le parole diventano un po’ musica e la musica diventa più parola. Il risultato offre spesso una prospettiva inedita, uno sguardo laterale e rivelatore. Un mio maestro fece un’operazione interessante lavorando con un testo tratto da una guida turistica. La musica aveva conferito a quelle parole un’inesorabilità che a una semplice lettura non potevano avere.
Ho un progetto che porto in giro da un po’: Seven Paintings. In sostanza suono sette improvvisazioni mentre alle mie spalle vengono proiettati sette dipinti in successione. Gli autori di questi quadri sono molto diversi fra loro per epoca e stile. Accade sempre, e a tutte le latitudini, che l’audience attraversi quei dipinti in un modo nuovo, fresco, inaspettato. Piero Della Francesca e Francis Bacon sono nuovi, la musica offre una finestra nuova, un altro sguardo. La parte magica consiste nel fatto che la stessa musica suona in modo nuovo, come se l’immagine ne informasse il percorso.
4. Parlaci della tua concezione di improvvisazione in musica.
Non faccio molta distinzione fra composizione e improvvisazione. Il tempo creativo è differente. Per me è sempre come perlustrare un luogo, espandere alcuni spazi, elementi costruttivi e decostruttivi, imprimere diversioni e aderire alla musica in un modo immediato. Nelle improvvisazioni più riuscite avviene una specie di transizione continua di significato, uno stretching formale e di senso, un’ineffabilità. L’improvvisazione è l’occasione di una fragranza. In quella di derivazione jazz il linguaggio ha radici evidenti, in quella più libera i piani sono molteplici e il linguaggio è sempre un ibrido. Il termine “composizione istantanea” è forse abusato, ma io improvviso compositivamente, diciamo che colgo l’occasione di avere uno sguardo particolare (reazione-azione) contemporaneamente a uno globale che tenga conto di un riferimento in qualche modo formale. Ecco allora che le forme del mio improvvisare decideranno (e saranno decise) da una narrazione che prende forma sul momento, ma in vista di un quadro complessivo. Il brano è una specie di sentiero da percorrere in parte scegliendo la direzione, in parte appartenendovi.
5. Assumi che l’errore possa essere un elemento generativo nel processo creativo?
Determinante. Personalmente ho bisogno di un certo numero di difetti per rendere al meglio. Thelonious Monk è la risposta alla domanda. Spesso l’errore è un nodo rivelatore. È necessario.
6. Cosa ti ha spinto a concentrare la tua attenzione sul saxofono soprano, rendendolo il tuo strumento (inteso come mezzo) comunicativo esclusivo?
Ho iniziato con il sax tenore da ragazzo, ma ho lavorato per molti anni al sax alto e baritono. Nel ‘77 assistetti a un concerto di Steve Lacy e mi colpì una certa inesorabilità del suo timbro. Già da allora, credo, compresi una specie di esclusività che il soprano ha. Per gran parte dei musicisti che lo suonano esso rappresenta un secondo, terzo strumento. In realtà è uno strumento con una serie di cose incompiute, i suoi gravi affondano nel cuore del tenore, le sue parti più acute sono come punte luminose. Timbricamente è infido, credo più mentale che fisico. Ormai ho una relazione con lui, certe giornate possono essere anche dure.
Ma possiede anche una buona complessità. Non credo lo si possa dominare, ho abbandonato l’idea da tempo. Ma la parte importante è senz’altro la relazione. Strumento piuttosto esigente.
7. Sei un artista che ha tenuto performance e inciso dischi molto spesso fuori dall’Italia, ci sono delle differenze fra la ricettività del pubblico e degli organizzatori di eventi fra il nostro Paese e altri luoghi? Se esistono tali differenze a cosa sono dovute a tuo avviso?
Tutti i luoghi sono particolari. La fruizione, in generale, si è molto trasformata, negli ultimi vent’anni almeno, ma è vero: ci sono ricettività diverse.
Il background culturale e naturalmente una programmazione avvertita attenta ai diversi ambiti determinano la qualità dell’ascolto. È bello, oltre che necessario, che un pubblico possa frequentare egualmente un corale di Bach e un quartetto di Anthony Braxton. Un pubblico giapponese per esempio sarebbe attentissimo. Forse da noi coglieremmo l’occasione per una polemica. Ci sono ragioni anche politiche, in Italia la débâcle culturale è stata massiccia. La curiosità si è fatta effimera, un po’ di omologazione ha fatto il resto. È successo ovunque, mi si dirà, tuttavia l’attenzione e le domande che si trovano in Nord Europa sono qualitativamente più alte. È innegabile.
8. Nel 2006 hai fondato l’etichetta discografica Amirani Records. Cosa ti ha spinto in questa direzione e qual è stata la tua scelta editoriale?
Tutte le figure intermedie: produttore, editore, direttore artistico sono scomparse e il musicista si occupa di tutto, tutto questo da un po’. Ho constatato che ai margini della scena ci sono molte intelligenze. Girando un po’ ho incontrato diverse realtà creative e poco prima di intraprendere l’avventura della label, volevo documentare alcuni progetti attivi al tempo.
L’attenzione all’area dell’improvvisazione non è stata esclusiva, il discrimine è sempre stata la sincerità dei lavori. Nel tempo ho aggiustato il tiro verso una cifra editoriale un po’ più rigorosa. Non nascondo sia faticoso e le difficoltà sono tante. Inoltre, la musica ha preso a girare in formati molto liquidi. Credo che alcune cose vadano documentate. Ho aperto negli ultimi anni una linea di lavori monografici nella collana di Contemporanea. C’è una parte di follia, naturalmente, dovuta al fatto che il lavoro è totalizzante per una sola persona.
9. All’interno del tuo catalogo qual è la registrazione che più ti rappresenta?
Non saprei dire. Sono legato in modo diverso a tutti lavori. Alcuni sono legati a periodi molto importanti e tendo a vederli considerando il contesto in cui sono stati realizzati. Alcuni sono diventati progetti consolidati e meno episodici.
10. Come riesci a far convivere la tua forte connotazione autoriale con un’altrettanta marcata propensione a collaborare a progetti altrui?
Ci sono vari tipi di collaborazione. Per me, anche qui, il discrimine è la sincerità. Talvolta certe collaborazioni sono strette, ma spesso è fuori dalla comfort zone che si dà il meglio.
11. A tuo avviso questo periodo di crisi, durante e dopo l’emergenza sanitaria, può offrire anche delle opportunità agli artisti?
Non vorrei trascurare l’aspetto ammonitorio di questo tempo. L’opportunità per me (magra consolazione, mi si dirà, mentre l’agenda è completamente vaporizzata in una serie di sospensioni, ingaggi rimandati a data da destinarsi, impossibilità di sviluppare progetti, ecc.) è stato osservare anche quello che si è fatto. Dovevo anche rallentare un po’, avverto una tendenza a sovraprodurre, ma forse è anche un tempo per considerare, un tempo di confronto. Di ascolto, anche. Davvero è necessario alzare lo sguardo, questa è una complessità che richiede concentrazione e flessibilità. Certamente è dura, ma non credo siamo qui a fare cose facili.
12. Nel 2019 hai registrato un disco in duo Rumpus Room con un geniale inventore di moderni “intonarumori”, per coincidenza di professione odontoiatra. Vuoi descrivere in alcune parole come è nato quel progetto e le sue caratteristiche?
Luca Collivasone è un artista molto concreto, un assemblatore curiosissimo, e ha inventato questo cacophonator trasformando una vecchia macchina per cucire in un generatore di suoni. Abbiamo stabilito una cadenza settimanale di prove, abbiamo parlato molto, veniamo da due mondi diversi. Suonare interagendo con i rumori è una pratica molto stimolante perché pone questioni estetiche interessanti. Ho lavorato in altre occasioni con suoni ‘altri”, sempre con artisti derivanti da ambiti distanti. Anche in questo caso le derivazioni stilistiche così differenti hanno generato un lavoro molto fresco, per certi versi sorprendente. Ne esce un suono quasi teatrale, nel quale le linee narrative si inseguono e certi timbri concreti sembrano dare una profondità, una specie di costellazione. Un metalinguaggio, forse.
13. Quali sono i tuoi nuovi progetti in vista?
Beh, il primo progetto è riprendere da dove eravamo rimasti e constatare se ciò a cui si stava lavorando merita ancora attenzione. Non so davvero quando ripartirà l’attività concertistica. Il Sestetto Internazionale, il duo con Alison Blunt, il trio con Satoko Fujii e Joe Fonda, il trio Clairvoyance avevano una serie di date in Europa che sono state rimandate. Ma è difficilissimo guardare avanti, i tempi permangono opachi. Da qualche tempo sto pensando a un nuovo album in solo, forse sarebbe un lavoro aderente a questa complessità.
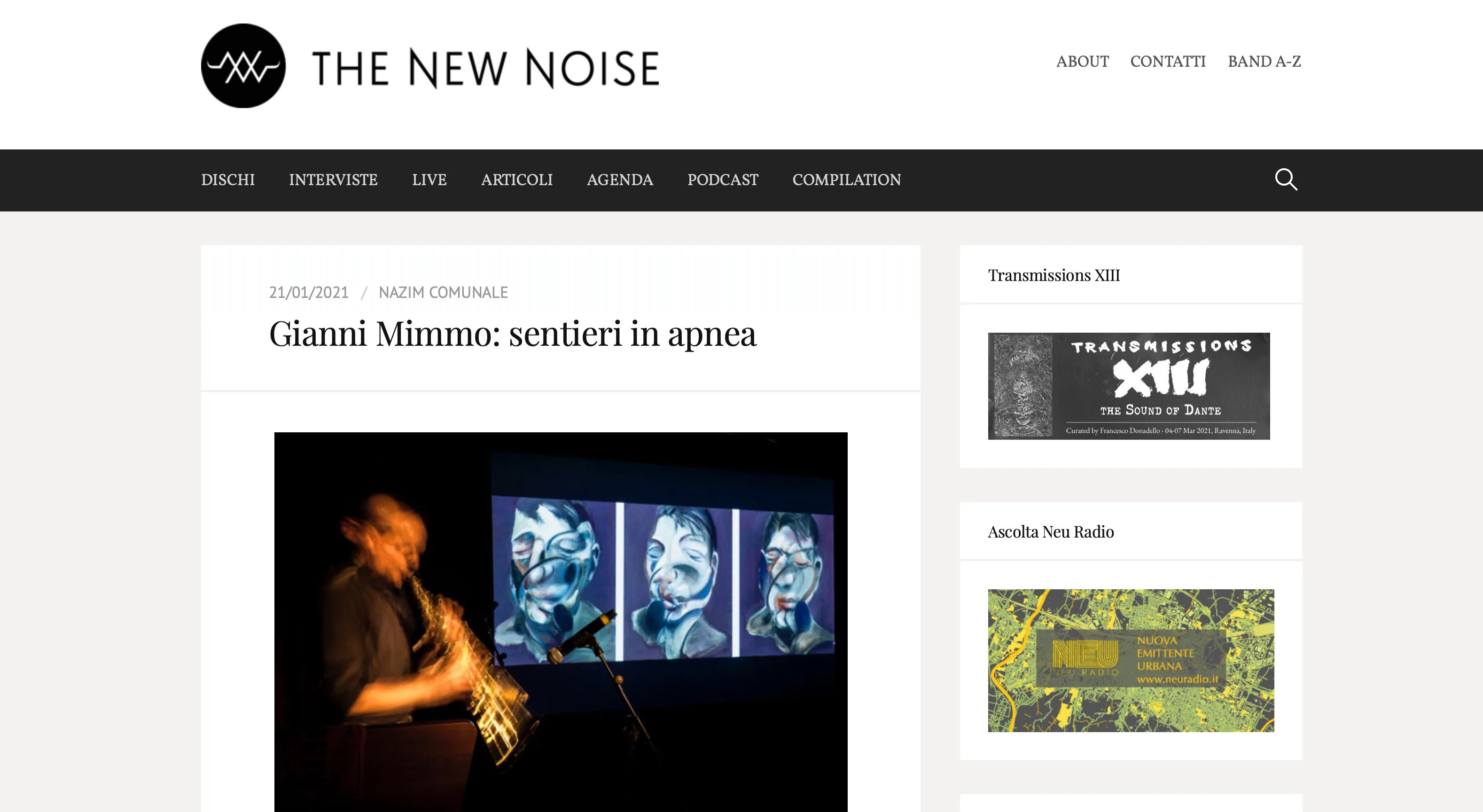
Gianni Mimmo è sassofonista (inconfondibile la sua voce al soprano), artigiano (ha un laboratorio di restaurazione di sassofoni), improvvisatore, pensatore a tutto tondo ed ascoltatore profondo di musica di ogni tipo (lunga ed eclettica la lista delle collaborazioni), oltre che gestore di una etichetta con un nutrito e coraggioso, Amirani Records. Recentemente abbiamo ascoltato e molto apprezzato due suoi lavori che vi abbiamo raccontato qui. È giunto il momento di dargli la parola.
Mi racconti il tuo primo ricordo musicale?
Gianni Mimmo: Ci sono tre momenti che ricordo, risalgono tutti alla mia infanzia: il suono dell’acqua che scaturiva dalla chiusa sul Naviglio lungo il quale la mia famiglia abitò per la prima parte della mia vita (credo che questo ricordo risalga al tempo in cui avevo 3 anni!). Un mio zio era professore d’ orchestra: da bimbo ho a lungo ascoltato i suoi studi alla tromba in certi pomeriggi. Infine intorno ai nove anni sono entrato di nascosto in un teatro vuoto, ma solo per curiosare… qualcuno aveva lasciato una porticina aperta. Una orchestra stava provando “La Mer” di Debussy. Ebbi un’emozione grandissima.
Gestisci un’etichetta dedita a musiche in qualche modo marginali da diverso tempo: il tuo punto di vista sullo stato dell’arte, in Italia e non solo, nel 2021?
La trasformazione è continua. In particolare, la modalità di fruizione si è spostata enormemente. Una “compressione” dell’ascolto è in atto da un paio di decenni. La musica fluisce in mille rivoli, spesso compressa per qualità e per tempo. Si raccoglie in playlist talvolta improbabili, che finiscono poi in minuscole cuffiette per un ascolto in metropolitana. I supporti hanno perso il loro peso, credo. Ciononostante, con fatica ed essendo io un po’ all’antica, credo ancora in una sorta di documentazione, che dimostri attenzione alla sincerità di certi lavori. Diciamo che si resiste consapevoli di dover custodire una piccola luce, ma anche del fatto che le cose si spostano, cambiano. Circa lo stato dell’arte: vedo molto “catalogo” in tutte le forme d’arte. Voglio dire che l’offerta è ampia (e tende talvolta all’entropia), ma anche molto confusa. La qualità tecnica si è alzata moltissimo, non la stessa cosa si può dire dell’aspetto concettuale. Il pensiero creativo è frammentato e ho spesso affermato che non vedo una “scena”. Singole scintille ma non un fuoco, ecco. È questo un argomento che in altri tempi avrebbe avuto forse maggiore rilevanza per gli stessi artisti. Trovo che, a maggior ragione oggi, quando correnti artistiche non esistono che per brevi frammenti di tempo, gli artisti dovrebbero incontrarsi di persona e illustrare i loro rispettivi sentieri. Tornare a parlare. Diciamo che vorrei che quelle piccole luci divenissero, di tanto in tanto, costellazioni. Credo abbiamo necessità di “focus”, ma che la tendenza sia allo “spread”. Oggi abbiamo molti emittenti e pochissimi riceventi, direi.
Musicisti che pochi conoscono e meriterebbero di emergere di più e meglio, secondo te? E poi, oggi che è esploso tutto, basta ancora – – ammesso che bastasse prima – la qualità da sola a farti emergere prima o poi? In Italia abbiamo una miriade di musicisti molto interessanti che lavorano sempre ai margini.
Non credo sia un tempo per “emersioni”. La parola implica un sopra e un sotto e i confini fra i mondi sono molto fluidi. Ma è vero che esiste un mainstream e molte cose che si accendono ai margini. Personalmente io credo che la qualità sia ancora un discrimine che rende i prodotti d’arte interessanti e ripercorribili, come tappe di un cammino cui fare riferimento. La categoria vale anche il mainstream, la qualità è un discrimine.
Continuo a ritenere i margini molto interessanti. C’è sempre una centrifugazione molto feconda, molti elementi si incontrano, certi funzionano, altri meno… Non ne faccio neanche una questione di tempo: credo che ci siano musicisti anche del passato, prossimo e remoto, che meritano di essere indagati. Però è anche vero che mai come oggi abbiamo avuto la possibilità di approfondire, l’esposizione è totale. Anthony Braxton, una volta, mi disse not really sure we can make a living from music anymore, but let’s stick to quality. La presenza, la permanenza, la continuità del nostro lavoro di musicisti si confronta con durate effimere. La legittimazione della nostra qualità è data dall’autenticità, dalla fedeltà al nostro sentiero. Gli ambiti musicali sono spesso autoreferenziali, forse è inevitabile, non so. Ma tutti abbiamo trovato qualità importanti in persone misconosciute, ai margini. Anche le gerarchie di pensiero sono saltate (non bisognava darle per scontate, mi dico): a me la qualità importa, per molti non è rilevante.
Il tuo rapporto con lo strumento: mi risulta tu abbia un’altra attività che lo riguarda, oltre a quella di musicista.
Una sorta di relazione con giornate di routine, gloriosi momenti e qualche scaramuccia. Studiare, sperimentare e apprendere a riparare, restaurare, ricostruire sassofoni, quella è stata benedizione credo. Ho un laboratorio dal 1992. Continuo a considerare quel lavoro prezioso, richiede concentrazione. Ancora lo sento come una meditazione, dopo tutti questi anni ed è una professione che mi resta addosso sempre. Mi ha aiutato a “vedere” il suono, in un certo senso e ad attribuire a ciascun strumento un carattere. L’immagine del suono che produce… C’è anche una prospettiva storica in questo. È un campo di studio che può rivelarsi molto, molto ricco di stimoli.
Che tipo di ascoltatore sei? Cosa stai ascoltando in questo periodo e come stai vivendo questi lunghi mesi complicati? In che modo influiscono sul tuo lavoro?
Il mio ascolto è molto curioso. Io amo moltissimo i rumori… È una cosa che ho avuto sin da bambino e che tuttora pratico. La profondità, la loro posizione intorno o lontano.
Nel tempo credo di aver applicato quella categoria anche nell’ascolto più propriamente musicale. Spesso, nella scelta di un ascolto, procedo per analogie estetiche e spesso le trovo in periodi molto distanti… La pandemia e il silenzio hanno di certo favorito un ritorno ad un ascolto più intimo, anche più accurato, direi. Ho riascoltato molto e, prevedibile, la prospettiva estetica è stata spesso rivelante. In questo periodo ho molto frequentato la musica di Alban Berg e di Webern, Schoenberg e anche Mahler, in generale il periodo viennese dei primi del secolo scorso. Sono interessato alla mutevolezza della forma. A come anche le declinazioni musicali più ardite trovino un riferimento formale nel quale avere luogo. Ligeti, il suo Kammer Konzert e le orchestrazioni di Gil Evans. E ho avuto anche un bel po’ di Bill Evans, cui periodicamente torno. Ci sono poi un paio di lavori a quali ho dedicato particolare attenzione: Rings del percussionista Masahiko Togashi e il concerto del 2000 a Tokyo di Lacy con Togashi e Yuji Takahashi al piano. Circa la “complicazione” di questi mesi: ho avuto più volte la sensazione che stiamo affrontando questa situazione in modo solamente tecnico. La pervasività del fenomeno ci interroga per categorie più profonde e mette in discussione un modello che da tempo mostrava la corda… E forse non abbiamo la statura politica per fare di più. Dal punto di vista artistico è veramente difficile: tutte le possibilità azzerate, svuotamento dell’agenda e difficoltà di mantenere un focus costante. Voglio considerare questo tempo utile per studiare, è indubbiamente complicato, ma credo che anche prima di questo tempo stessimo vivendo contraddizioni molto profonde. Tuttavia, mi colpisce il carattere forse ammonitorio di questo tempo. C’è senz’altro un “ripiegamento”, spero di riuscire a trovarne un’interpretazione fruttuosa…
Come pensi la musica? La “vedi”, la scrivi, la capti intorno? Fonti di ispirazione al di fuori della musica?
La prima fonte di ispirazione per me sono la pittura e la scultura. La dislocazione degli elementi nello spazio. Per me l’ispirazione nasce dalla forma e attraverso un processo, vi ritorna, osservandola da un’altra angolazione. Ci sono spinte interiori, naturalmente, anche.
È anche un’interazione con il proprio pantheon, la musica ha un altissimo potere di transizione. Con la consuetudine si spende meno tempo ad arrivare alla “stanza del tesoro”. Negli ultimi anni vedo più chiaramente che alcune osservazioni contengono dei semi. Oggettivare, sublimare forse, il percorso di quei semi è pensare la musica, per me.
Un mio maestro mi fece osservare quanta armonia risiede in un gesto atletico, mi invitò a riflettere al peso drammatico delle fasi di un salto. E mi invitò ad applicare quelle considerazioni alla mia improvvisazione. Fu molto importante. Anche quando studio ho a che fare con quegli elementi e spesso qualcosa nasce dalla pratica. Non si capisce sempre da dove viene l’ispirazione: a volte mi succede prima, a volte comprendo alcune cose dopo molto tempo. Vedo le radici e succede che ciò che pensavo come nuovo deriva in verità da qualcosa di molto antico.
Ti chiederei un ricordo di Gianni Lenoci, un aneddoto, quel che vuoi.
Abbiamo avuto 10 anni insieme, importantissimi sul piano umano e artistico.
Abbiamo viaggiato insieme in molte occasioni e condiviso luoghi e abitudini diverse. Mentre io, per natura, sono piuttosto adattabile, Gianni era restio, benché curioso, ad allontanarsi troppo dai propri gusti, dalle proprie abitudini. In questo opponeva una piccola ma continua resistenza che, nel suo linguaggio corporeo, si manifestava in una serie di micro-tensioni che a me sembravano buffissime. Ad esempio: le posture di Gianni erano rivelanti per me. In certi momenti era come non sapesse dove accidenti mettere le gambe. In aereo, in auto, in treno o in qualche metropolitana, Gianni cercava sempre un posto nel quale appallottolarsi in modo auto-protettivo spesso facendo scomparire la testa dentro una cuffia di lana. C’era qualcosa di teneramente infantile in questo che mi faceva sorridere. Oppure il suo sguardo smarrito dopo aver assaggiato qualcosa di troppo lontano dai suoi gusti… quello era esilarante! “Interezza” è un buon termine: a me piacevano anche i momenti nei quali perdeva le staffe. I momenti nei quali gli sembrava impossibile avere a che fare con l’ottusità, quando la mediazione e la flessibilità non erano per lui valori sufficienti.
C’era sempre un richiamo alla responsabilità dentro quei momenti. Voglio dire: era vero anche nei suoi momenti meno felici. Era intero.
Cinque dischi che hanno segnato la tua vita da ascoltatore? Se dico che Steve Lacy è stato importante per te, prendo una cantonata o ci siamo?
Steve Lacy è stato ed ancora è fondamentale per me. È un albero dai rami numerosi, al quale devo molto. Lacy, come pochi altri, coincide con il “proprio” suono a tal punto da esserne inscindibile. Questo è forse il primissimo elemento che mi ha segnato.
Allo stesso tempo dalla sua parabola traspare da subito una consapevolezza artistica evidente. Quindi la scoperta del proprio suono, una pazienza critica nel perseguirlo, una coesistenza di attenzione per il dettaglio e visione globale. Questi sono per me dei punti fermissimi della sua costellazione che hanno indirizzato la mia ricerca personale. Sono elementi evidenti nell’intero corpus compositivo e performativo di Lacy: concept, composizione, altissimo grado di libertà e rigore allo stesso tempo, improvvisazione che lascia il segno, sincerità artistica. Sono cose molto luminose, ispirative, che hanno indirizzato buona parte del mio percorso. Un’estetica cristallina e un rigore nella libertà che vanno al di là dello stile. È un poliedro troppo complesso per essere collocato in una posizione stilistica unica. Lacy trascende lo stile.
Cinque dischi sono pochi, ve ne sono molti… Tuttavia, vorrei citare:
J.S. Bach, “Cello Suites” – Archiv [nell’interpretazione di Pierre Fournier]
Anthony Braxton, “Five Pieces 1975” – Arista [con Kenny Wheeler, Dave Holland, Barry Altschul]
Steve Lacy, “Packet”, New Albion [con Frederick Rzewski, Irene Aebi]
Gil Evans-Steve Lacy, “Paris Blues”- Owl Records
Salvatore Sciarrino, “Luci Mie Traditrici” Opera in due atti – Kairos [nell’interpretazione del Klangforum Wien diretto da Beat Furrer]
Ma davvero sono molti, troppi per essere menzionati qui…
Hai collaborato con molti musicisti: cosa ti riserva il futuro?
Molte cose sono state sospese a causa alle restrizioni seguite alla pandemia, molte occasioni importanti sono state posticipate o rinviate a data da destinarsi: Sestetto Internazionale, il trio con Satoko Fuji e Joe Fonda, il mio trio Clairvoyance così come il duo con Alison Blunt e quello con Luca Collivasone. Anche i lavori con il testo, tutto polverizzato in una nebbia finissima. Nell’ultimo mio live il 30 settembre scorso (era dedicato a Gianni Lenoci ad un anno dalla morte) ho presentato un solo insieme alle immagini di Andrea Montanari. Entrambi abbiamo promesso di proseguire questo lavoro. Sto anche lavorando ad altre partiture grafiche e a un nuovo solo album. La scrivania è piena, diciamo che la tengo in ordine, ecco.
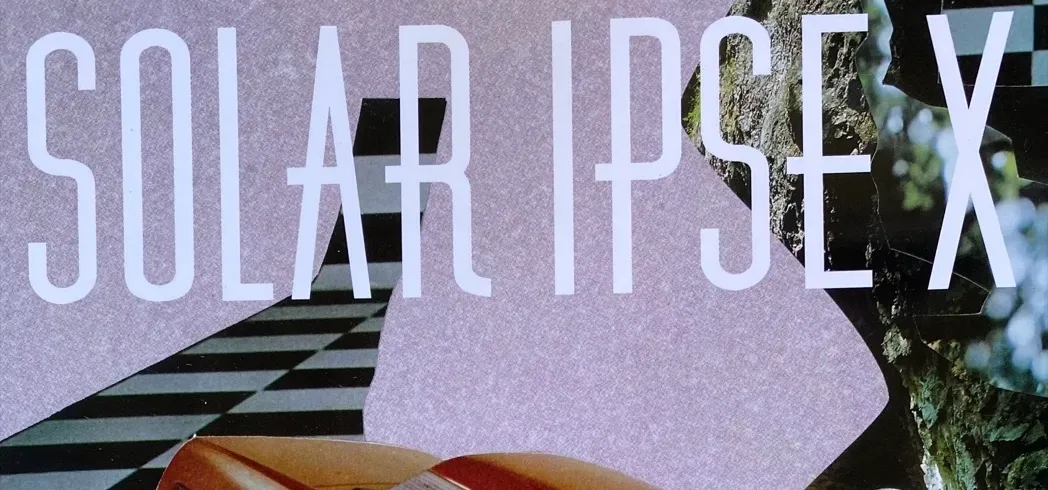
Intervista di Loris Zecchin per Solar Ipse intorno al disco mio preferito edito della label Tzadik:
FINGER LIGHT di Yuji Takahashi, Tzadik, Composer Series
Cito testualmente dalla nostra corrispondenza "penso che non ti indicherò il disco che preferisco, ma quello che ancora oggi mi intriga per una personale propensione a voler comprendere il processo creativo". Dato che è un cd sul quale ritorni spesso la domanda é: che tipo di percorso diresti che hai compiuto dalla prima volta che l'hai fatto girare nello stereo? A che grado di "penetrazione" pensi di esser arrivato?
Il mistero che avvolge questo lavoro per me risiede principalmente nella consapevole disinvoltura di Yuji Takahashi. Un poliedro trasparente nel quale elementi così distanti trovano relazioni e legittimazione reciproca. C’è un alito contemporaneo che attraversa anche l’ambito più tradizionale, c’è un’aura antichissima che risuona nei suoni più vicini al nostro tempo. Non è sorprendente, mi sono spesso detto, è un’attitudine molto presente nell’arte, nella società e nel pensiero giapponese. Una disinvolta coesistenza di elementi, in parte contraddittorii, che permettono sempre alle cose di rivelare una certa ineffabile fragranza. Come se ci fosse data l’opportunità di assistere al manifestarsi di una completezza inafferrabile. Volgere lo sguardo per scoprire l’oltre di un oggetto.
Nella musica di Takahashi mi pare quasi di toccare quella fragranza: l’aspetto, il frammento più lieve possiede un carisma, una assolutezza, in grado di brillare di luce propria. Questo più che al piacere dell’ascolto, più che alla bellezza, più che alla compiutezza e alla coerenza, ha a che fare con la verità.
E tutte le congetture stilistiche crollano come birilli.
Molti anni fa ebbi occasione di assistere a una rappresentazione di teatro Nō.
Come succede per diversi momenti musicali di questo album, i suoni di quella rappresentazione erano inesorabili. Come potessero rendere il silenzio, che li precedeva e che li seguiva, pulsante. Risonante nel suo proprio vuoto. Certi schiocchi, certe secche fratture come se l’aria si potesse piegare a quel silenzio, a quel gesto lentissimo dell’attore, carico di una tensione rappresa e densissima.
Un carattere contemplativo attraversa i colori di ogni brano di questo album e ogni volta ritorno a quest’ascolto rimanendone invischiato, come non riuscissi a comprendere questa totale assenza di ego. Nel brano “Yubi-Tômyô” è come se il suono del pianoforte fosse totalmente involontario, è come fosse il pianoforte a suonare il musicista. Eppure vi riscontro un rigore insondabile, un’aderenza esecutiva e interpretativa di quell’assenza.
Non a caso Yuji è un interprete abbastanza ineludibile di Earle Brown…
In “Mimi No Ho” è la tradizione a piegarsi ad una sospensione concettuale, una musica adagiata su un crinale sottilissimo, dove una non-narrazione compare come provenisse da un sogno.
Un aspetto davvero intrigante per me è il tempo che segna questo lavoro. Un tempo ultra-dimensionale, per così dire, cui non si può che aderire. Ha a che fare con una certa immanenza di questa musica, una sua facilità a contenere/aderire a un ritmo naturale, nel senso quasi letterale del termine. Un vento leggero che appena increspa l’acqua di uno stagno la cui luce è rotta dall’ombra. Non puoi che appartenere a questo tempo. Non lo puoi possedere, in un certo senso.
Io vi vedo scomparire la mente di questo compositore, come se la musica lo sublimasse e non ne avvertissimo che una pallida, fugace, ma assertiva, fantasmatica figura.
Ho visto su discogs che Takahashi ha una nutrita discografia. Quali altri titoli con/di lui, oltre a quello che hai portato in questo speciale, consiglieresti a chi come me non lo conosce?
Takahashi è un musicista capace di traversare gli ambiti più distanti senza perdere mai autenticità, straordinaria profondità e capacità penetrativa dell’ascolto.
Io ho incontrato la sua musica attraverso due album registrati in Giappone con Steve Lacy dove compare come pianista al quale è davvero difficile mettere etichette di qualsiasi tipo. Un caro amico che lo incontrò personalmente mi indicò le sue Goldberg variations e le sue interpretazioni di Satie.
Bellissimi i Six Stoichei per quattro violini, le sue interpretazioni di Cage e certe altre sciabolate elettroniche assolutamente imprevedibili. Ma davvero è un universo sconfinato nel quale perdersi. Certi autori impressionisti minori (ad esempio Frederic Mompou) affrontati con un uso del pedale quasi infinitesimale…
E poi avverto un “coraggio dell’incertezza”, un abbandonarsi consapevole, quasi sempre sull’orlo di un crinale sottilissimo…
Sono attimi così intensi che in Takahashi sono molto, molto frequenti.
Non distante da certe vertigini che trovi in Monk …
Le sue interpretazioni di Satie, per esempio, a mio parere, sono quelle nelle quali le voci interne sono particolarmente vivide, le puoi quasi vedere occupare una posizione nello spazio, nell’immagine sonora.
E poi quasi non distinguo in Takahashi il compositore dall’interprete. In entrambi i casi io ne resto mesmerizzato. Ognuno dei suoi percorsi contiene purezza, come quella di un danzatore, corpo e cuore e abbandono. Lo si ascolti suonare Xenakis o Bach, l’incanto è assicurato.
Strumenti tipici della tradizione del sud est asiatico che ti attraggono.
Ancora ricordo la sensazione simile a quella di librarsi in volo che ebbi a Pisa, alla fine degli anni ‘70, quando assistetti a un concerto di un’orchestra di gamelan.
Era la prima volta che una formazione del genere suonava in Europa, fu davvero un’esperienza totalizzante.
Il koto, la biwa e naturalmente lo shakuhachi… sono molti gli strumenti interessanti, ma rimangono “fuori da me”.
Non potrei suonarli, credo. Si tratta si un’estetica molto lontana anche se di enorme fascino. Durante un tour in Giappone ho assistito ad una cerimonia nella quale due donne suonavano lo shamisen a tre corde. La grazia che abita i movimenti della mano, la figura femminile e infine il suono sono per me indistinguibili.
Forse per ragioni personali sono piuttosto attratto dall’ ichighienkin, uno strumento a una sola corda particolarmente essenziale e per questo dotato di un’assolutezza incredibile.
Se nelle giuste mani è capace di incantare.
Naturalmente il mio interesse è forse più rivolto dai flauti di canna, ma non per lo strumento in sé, quanto per l’approccio fisico che a certe latitudini è in un certo senso svincolato dallo stile.
Hocchiku (Watazumi Doso ne è, credo, uno specialista imprescindibile) è una specie di antenato dello shakuhachi. Più difficile, più crudo se si vuole. La magia sta nella pratica, nell’adesione al respiro della natura.
A questo punto, tuttavia, non credo sia più lo strumento che genera l’attrazione quanto il percorso personale per entrarvi in relazione.
ENGLISH
I quote verbatim from our correspondence "I think that I am not going to show you the record I prefer, but the one that still intrigues me today for a personal inclination to want to understand the creative process". Since it's a CD you often come back to, the question is: what kind of path would you say you have followed since the first time you played it in the stereo? What degree of "penetration" do you think you have reached?
The mystery surrounding this work for me lies mainly in Yuji Takahashi's conscious nonchalance. A transparent polyhedron in which such distant elements find mutual relations and legitimacy. There is a contemporary breath that crosses even the most traditional sphere, there is a very ancient aura that resonates in the sounds closest to our time. It is not surprising, I have often said to myself, it is a very present attitude in Japanese art, society and thought. A casual coexistence of elements, in part contradictory, that always allow things to reveal a certain ineffable fragrance. As if we were given the opportunity to witness the manifestation of an elusive completeness. Turn our eyes to discover the beyond of an object.
In Takahashi's music I almost seem to touch that fragrance: the appearance, the lightest fragment has a charisma, an absoluteness, able to shine its own light. This more than the pleasure of listening, more than beauty, more than completeness and coherence, has to do with truth.
And all stylistic conjecture collapses like skittles.
Many years ago I had the opportunity to attend a Nō theatre performance.
As it happens for several musical moments of this album, the sounds of that performance were inexorable. How could they make the silence, which preceded and followed them, pulsating. Resonant in its own emptiness. Certain snaps, certain dry fractures as if the air could bend to that silence, to that very slow gesture of the actor, charged with a very dense and condensed tension.
A contemplative character runs through the colours of each track of this album and every time I return to this listening, I remain entangled in it, as if I could not understand this total absence of ego. In the song "Yubi-Tômyô" it is as if the sound of the piano were totally involuntary, it is as if the piano were playing the musician. And yet I find in it an unfathomable rigour, an executive and interpretative adherence to that absence.
It is no coincidence that Yuji is a fairly unavoidable interpreter of Earle Brown...
In "Mimi No Ho" it is the tradition to bend to a conceptual suspension, a music lying on a very thin ridge, where a non-narrative appears as if it came from a dream.
A really intriguing aspect for me is the time that marks this work. An ultra-dimensional time, so to speak, to which one cannot but adhere. It has to do with a certain immanence of this music, its ease of containing/adapting to a natural rhythm, in the almost literal sense of the term. A light wind that barely ripples the water of a pond whose light is broken by shadow. You can only belong to this time. You cannot possess it, in a certain sense.
I see you disappear the mind of this composer, as if the music sublimates him and all we hear is a pale, fleeting, but assertive, phantasmatic figure.
I have seen on discogs that Takahashi has a large discography. What other titles with/about him, besides the one you have brought in this special, would you recommend to someone like me who doesn't know him?
Takahashi is a musician able to cross the most distant areas without ever losing authenticity, extraordinary depth and penetrative ability to listen.
I met his music through two albums recorded in Japan with Steve Lacy where he appears as a pianist to whom it is really difficult to put labels of any kind. A dear friend who met him personally showed me his Goldberg variations and his interpretations of Satie.
Beautiful Six Stoichei for four violins, his interpretations of Cage and some other absolutely unpredictable electronic sabres. But really it is a boundless universe in which to get lost. Some minor impressionist authors (for example Frederic Mompou) faced with an almost infinitesimal use of the pedal...
And then I feel a "courage of uncertainty", a conscious abandonment, almost always on the edge of a very thin ridge...
These moments are so intense that in Takahashi they are very, very frequent.
Not far from certain dizziness that you find in Monk ...
His interpretations of Satie, for example, in my opinion, are those in which the internal voices are particularly vivid, you can almost see them occupying a position in space, in the sound image.
And then I almost don't distinguish in Takahashi the composer by the interpreter. In both cases I remain mesmerized. Each of its paths contains purity, like that of a dancer, body and heart and abandonment. Listen to him play Xenakis or Bach, the enchantment is assured.
Tools typical of the tradition of South East Asia that attract you.
I still remember the feeling similar to that of hovering in flight that I had in Pisa, at the end of the 70s, when I attended a concert of a gamelan orchestra.
It was the first time that such a formation played in Europe, it was really a totalizing experience.
The koto, the biwa and of course the shakuhachi... there are many interesting instruments, but they remain "outside of me".
I couldn't play them, I guess. It's a very distant aesthetic, even if of enormous charm. During a tour in Japan I attended a ceremony where two women played the three-string shamisen. The grace that inhabits the movements of the hand, the female figure and finally the sound are indistinguishable to me.
Perhaps for personal reasons I am rather attracted to the ichighienkin, a single-stringed instrument that is particularly essential and therefore endowed with an incredible absoluteness.
If in the right hands it is capable of enchantment.
Of course, my interest is perhaps more for the reed flutes, but not for the instrument itself, but for the physical approach, which at certain latitudes is in a certain sense detached from the style.
Hocchiku (Watazumi Doso is, I believe, an indispensable specialist) is a kind of ancestor of the shakuhachi. More difficult, rawer if you like. The magic lies in practice, in adherence to the breath of nature.
At this point, however, I don't think it is the instrument that generates attraction as much as the personal path to relate to it.

1. “[…] Vorrei dire che esiste un’altra faccia del jazz che non è quella che ci viene presentata quotidianamente nei festival e nei seminari, anche perché credo che il jazz non stia in uno stile o in un linguaggio ma nella perpetuazione della rivoluzione che per esempio dai primi passi di New Orleans ha portato allo swing, da questo al be bop e così via […]”.
Questo è quanto mi diceva Mirko Sabatini in un’intervista nei primi mesi del 2000, concordi e pensi che nel frattempo qualcosa è cambiato?
GM: La situazione non pare cambiata e non credo cambierà. È forse peregrino attendere una legittimazione da luoghi dai quali non può arrivare.
Nel jazz, ma credo senz’altro il senso possa estendersi a tutte le musiche che conosciamo, c’è una tendenza conservativa, quasi ineluttabile, alla antologizzazione, alla definizioni degli stili. Una tendenza che dispone gli avvenimenti lungo una linea temporale tesa a creare dei punti fermi.
È una categoria insufficiente, e per molti versi negativa, in particolar modo per quelle musiche che contengono elementi sempre fertili, generativi.
Nel jazz, nelle musiche che conosco e che studio, ciò che è importante da un punto di vista artistico, è la turbolenza delle singole idee, il loro ripercuotersi nel tempo in modi sempre differenti e intriganti.
Dal punto di vista di una produzione convenzionale questi elementi rappresentano un disturbo: i festival jazz si sono schiacciati sempre più sulla posizione antologica, ripetitiva.
Trovo molto più coraggiose certe programmazioni di musica classica che fanno sempre più posto ad autori più vicini al nostro tempo, spesso inquadrandone le figure luminose a fianco di maestri del passato.
Non esiste solo un’altra faccia del jazz, esiste una profondità percorribile che connette costellativamente momenti storici, relazioni stilistiche, estetiche strumentali fra loro anche distantissime.
È qui che va esercitato il nostro sguardo creativo. È qui che dobbiamo puntare: fare le cose bene. Non credo questo ci verrà spesso riconosciuto dal festival/carrozzone di turno, la sua funzione è altrove.
Anche le modalità fruitive hanno continui spostamenti: si bada con più attenzione a quanto si compare piuttosto che alla qualità di quanto si fa.
Spesso un festival è solo un propulsore del tuo nome, non della tua arte.
Sono categorie un pochino povere, mi pare.
2. Per il tuo esordio discografico, che ha rappresentato anche l'avvio della tua attività discografica con Amirani Records, hai fatto una scelta piuttosto singolare, quella del solo strumentale ... dico singolare per due motivi: primo perché solitamente si arriva a registrare il solo dopo una o più esperienze di tipo collettivo e secondo perché si tratta di un ascolto più difficile e quindi commercialmente poco indicato quale apertura di un'attività discografica. Puoi spiegarci quella scelta?
GM: C’è molta attività precedente quel disco e ho molto lavorato con il testo, il teatro e, in generale, la performance.
In particolare ho lavorato piuttosto a lungo con la poetessa Chandra Livia Candiani e il rapporto solo strumento-sola voce mi ha davvero intrigato moltissimo. Io sono molto attratto dalla speech-melody, le cadenze e il ritmo sillabico. Lacy lavorava molto sulla scansione sillabica del fraseggio, sulla geometria ritmica delle parole. Quando ascoltai Lacy per la prima volta, fu in un duo con il poeta Adriano Spatola. La limpidezza, la nitidezza di quel concerto sono stati rivelatori per me.
Ho cominciato con la solo performance con il sax soprano a metà degli anni 90 e periodicamente l’ho documentata: c’è anche un altro solo album precedente “One Way Ticket” intitolato “Rughe” che uscì autoprodotto alla fine degli anni 90.
Ho voluto aprire in quel modo l’avventura di Amirani Records perché è un album assertivo, perentorio in un certo senso. Se fosse stato un quintetto o un trio ad avere avuto quelle caratteristiche, avrei pubblicato quelli.
È un lavoro molto intero, identitario quasi.
Un recensore americano che incontrai in un concerto negli Usa, mi disse che a distanza di 3 anni dalla sua uscita, quel disco conservava la sua certezza.
“That’s a statement, man”. E’ il mio disco più venduto, credo.
Dal punto di vista musicale era così precisamente connesso al tempo che allora stavo vivendo che non mi parve un azzardo cominciare così questo nuovo percorso. In quel lavoro si concentrano diverse traiettorie, ma sono tutte affrontate liberamente, con un approccio rigorosamente personale.
E’ un disco sui padri: quello in copertina è il mio naturale, che mancò qualche mese prima dell’uscita del disco. Compaiono composizioni di altri padri quali Monk, di Lacy, di Mingus, di Roscoe Mitchell, ma anche Anton Webern e anche mie. C’è una poesia di Scialoja e una di T.S. Eliot.
Sono attraversati. Li attraverso, questi padri.
3. Comunque sia quella scelta è stata azzeccata, se oggi sei piuttosto affermato sia come musicista sia come discografico ... Penso comunque ai molti, che pur facendo una musica di qualità, non riescono ad uscire dall'ombra, qual è secondo te il fattore che più incide nel raggiungimento dei propri obiettivi: la qualità di quanto vai facendo, lo spirito d'iniziativa o la fortuna? Oppure ce ne sono altri che non ho citato?
GM: Non so quando un musicista, un artista, possa definirsi affermato: E’ un’idea molto instabile, oggi. La fruizione della musica si è spostata dai luoghi collettivi a quelli privati, talvolta intimi come quelli creati con l’uso di minuscole cuffiette attaccate a un telefono nel quale pullulano playlist personalissime, confuse forse. C’è un nuovo aspetto, quasi funzionale, applicativo direi, che sembra rivestire la musica nella fruizione attuale per il quale mi riesce più difficile capire quanto sia davvero compreso il lavoro di un musicista. Questo si ritrova a dover coprire una serie di ruoli che lo allontanano invece che avvicinarlo al padroneggiare la propria materia, coltivare la propria formazione, comprendere e rimanere fedeli al proprio sentiero. La gran parte dell’energia se ne va in logistica, nella cosiddetta comunicazione, nella costruzione di ipotetiche relazioni, nel cercare il supporto o nel promuovere i propri progetti.
Capita spesso di assistere a progetti molto ben presentati che presto svelano pochezza di intenzioni e approssimazione nella sua concezione.
Mantenere un equilibrio fra la purezza delle intenzioni, una chiara visione del progetto e la sua promozione/affermazione, richiede senz’altro un impegno che non sarà mai ricompensato a sufficienza da tutti i punti di vista.
Uno dei fattori determinanti nella riuscita è secondo me una buona coscienza della propria forza espressiva. Questo è forse l’elemento più importante.
Pensare, domandarsi perché, essere implacabilmente curiosi nei confronti delle proprie sensibilità. Se tieni aperto quel canale, e non sempre è facile, il tuo lavoro prende spessore e genera ulteriori spinte.
L’ombra nella quale spesso il proprio lavoro, la propria musica, la propria qualità sembrano abitare è insidiosa e feconda al tempo stesso.
Feconda perché molto spesso da questa contraddizione nascono improvvisi slanci creativi; insidiosa perché il rischio inconsolabilmente auto-commiseratorio e la possibilità di avvitamento su sé stessi divengono frustranti e improduttivi.
Mi dico spesso che la legittimazione più severa deve provenire da se stessi. E’ un errore, una dispersione di energia, attendere o credere che debba giungere da fuori.
È certamente importante che il proprio lavoro venga riconosciuto, ma ancora più importante, forse ineludibile, è che sia aderente alla mia propria sensibilità, che stia nel sentiero. Che sia vero, insomma.
Il fatto che sia vero è già essere fuori dall’ombra, direi.
4. So bene che l’attività di un musicista non si limita al fare dischi, seppure seguendo la stampa specializzata del settore possa sembrare così, ma tu sei anche discografico ed è soprattutto come tale che ti rivolgo la prossima domanda. Intervistando piccoli discografici indipendenti attivi in altri ambiti musicali è emerso che oggi i dischi si vendono soprattutto ai concerti, funziona così anche nel settore del jazz contemporaneo?
GM: Sì, I dischi si vendono ai concerti, principalmente. Ci sono anche ascoltatori fedeli che comprano il disco perché hanno un percorso di ascolto personale, un proprio pantheon, ma generalmente i live sono i posti dove vendere i dischi.
Per la musica che faccio mi trovo spesso di fronte ad audience di diversa provenienza. In certe gallerie d’arte, oppure in certe chiese anglicane, in centri sociali, in teatri e in rassegne nelle quali rivesto quasi sempre un ruolo di frangia sperimentale, gli ascolti sono così diversi...
Quindi mi capita di vendere il mio disco a persone che forse non lo acquisterebbero on line (o in negozio, se ancora ne esistono...), persone che non hanno ascoltato niente del genere prima, giovanissimi e anziani.
CD e vinili... molta musica non passa più da questi supporti, ormai. Tuttavia io sono un po’ all’antica e penso che un documento possa avere anche un valore fisico.
Vedo che il vinile sta avendo un forte ritorno. Credo che, in un momento in cui il tutto tende a smaterializzarsi, il gesto di mettere un disco sul piatto continui ad avere la sua valenza micro-catartica.
Rimane intatto il valore documentativo: e forse è questa la vera funzione di una label, per piccola che sia.
La logica economica e i suoi parametri rimangono inapplicabili alla produzione indipendente. Le vendite fruttano guadagni comunque risibili considerando le energie spese.
La spinta produttiva va cercata in regioni più prossime alle proprie intenzioni culturali.
5. Dalle tue stesse risposte si capisce che è in atto una specie di rivoluzione in grado di cambiare come viene fatta la musica, come viene distribuita e come viene recepita (personalmente ho anche qualche dubbio sul fatto che una musica come noi la intendiamo, come oggetto d’ascolto, continuerà a esistere, ho piuttosto l’impressione che ognuno si farà la propria musica e per comunicare con gli altri e come oggetto di sottofondo); si tratta di una rivoluzione forse più sconvolgente di quella avvenuta con l’invenzione dei sistemi di amplificazione e di registrazione. Il disco che nella musica pop rappresentava l’elemento centrale (cioè si faceva il disco e poi si facevano i concerti per promuoverlo), ed essendo quello della musica pop il settore economicamente forte finiva comunque per influenzare tutto il sistema, oggi va perdendo la sua centralità ed è ormai ridotto a biglietto da visita per poter suonare … ti chiedo, di fronte a questi cambiamenti, e di fronte alle possibilità offerte dalla rete, non dovrebbe essere un po’ rivisto il modo in cui si scrive di musica e nel quale si fa promozione, che a questo punto risulta obsoleto?
GM: Sì, credo stia già avvenendo, questa trasformazione.
E da molte prospettive.
E’ vero che si sta spingendo la musica in angoli molto funzionali e il termine “sottofondo”, che tu hai usato, segna per me un discrimine abbastanza importante.
Questo sguardo apre forse un versante un pochino complesso da affrontare: come si è trasformata la qualità e la durata di ascolto nel corso degli ultimi 100 anni?
Già con l’avvento della radio si osservò un radicale cambiamento esperienziale e certo cambiò il modo di pensare e produrre la musica.
Ma, era “una” nuova strada.
Oggi la frammentazione/tridimensionalità delle linee comunicative, la loro continua interconnessione ha prodotto un tipo d’ascolto meno paziente e ritmato da un consumo superficiale e a perdere, qualitativamente schiacciato su una modalità basica. Televisiva, direi.
C’è un aspetto storico/sociologico che investe tutta la fruizione artistica, non solo quella musicale.
Io credo che andiamo verso una coesistenza di forme di produzione, di concezione e di fruizione.
Alcune musiche, alcune destinazioni.
Alcune avranno più porte d’ingresso per un ascolto approssimativo, funzionale magari; altre avranno ingressi più sfumati che aprono a una maggiore profondità.
Anche quando ascolto Schumann, seduto davanti a un giradischi o in una cuffia mentre scendo dal metro, credo di aver già compiuto uno spostamento da un punto di vista concettuale.
E credo sia sempre esistita una differente intensità di ascolto, una collocazione personale.
Quello che penso sarà invece davvero determinante è la qualità del substrato culturale di queste ultime generazioni, quali saranno i mattoni su cui costruire una “propria” estetica.
Forse il tema non è la scomparsa dell’ ”oggetto di ascolto”, ma quella ben più drammatica del soggetto che ascolta.
Questo sarà interessante: capire quali spostamenti hanno subito le nostre categorie in quest’ultima compressione temporale data dal predominio della téchne, come verranno trasformate da nostri nipoti.
Alzerei lo sguardo aldilà dei supporti: i cd, i vinili, l’oggetto disco, il booklet etc. e direi che nonostante questa possibile coesistenza di forme, continueranno a trovarsi modalità comunicative dirette.
Il problema non è solo di ordine produttivo, ma anche performativo.
Ma qui si apre forse un altro capitolo...
6. Il concerto sta comunque acquisendo una nuova centralità nella presentazione dell’opera musicale. Se con l’industrializzazione era stato in parte esautorato dalla diffusione via etere e dalla vendita su supporto, oggi oltre ad essere un mezzo di presentazione diretta è diventato anche un momento di commercio … per utilizzare un luogo comune, dal produttore al consumatore! Non pensi che sarebbe quindi utile lavorare di più sulla pubblicizzazione dei concerti? Le riviste jazz, a differenza di quelle dirette al pubblico della musica pop, hanno sempre riservato ampi spazi alle attività concertistiche, ma comunque si trattava di reportage post evento? Dal momento che le recensioni ai dischi cadono nel vuoto, è dimostrato, non pensi che sarebbe opportuno riuscire a spostare l’ago della bilancia da queste a una presentazione più efficace delle attività performative?
GM: Certamente occorre maggiore puntualità nella presentazione di un concerto, o di una serie di concerti. Ma mancano ormai le figure organizzative con questa funzione, svolta molto spesso dai musicisti stessi.
Il concerto è un momento fondamentale, ma il problema è più complesso.
In questa galassia, qualsiasi parametro tocchi, ottieni ripercussioni sull’intero sistema.
Se in una programmazione non esiste configurazione culturale, o se come spesso accade è solo superficiale, il rischio dell’indistinto, del calderone, è altissimo.
Il tempo sembra essere scomparso: non c’è tempo per provare i propri progetti, molto del rimanente se ne va in sforzi logistici e di promozione, si finisce per concentrare tutta l’energia nell’organizzazione e nel concerto che, nella stragrande maggioranza delle volte rappresenta il progetto in modo parziale. In questo modo si ha una successione di scintille e quasi mai un fuoco duraturo.
I progetti più ambiziosi, quelli forse più indicativi del percorso di un musicista, sono i più difficili da portare in giro: spero di poter presentare almeno una volta dal vivo il mio Prossime Trascendenze (un quintetto e un sestetto), ma sarà davvero impegnativo riuscire.
Negli ultimi anni sento che un rinnovamento della qualità rapporto musicista audience sia più che necessario, in particolar modo per le musiche contemporanee. Se ben introdotte esse trovano attenzione in audience anche molto distanti per esperienze o per ragioni sociali.
Credo ci sia una responsabilità da prendere in carico nel portare su un palco le proprie sensibilità: c’è un ruolo più attento che un musicista deve ricoprire.
Avere un senso della posizione, questo gioverebbe molto.
Agire in modo più mirato da un punto di vista propositivo, portare queste musiche nei luoghi dove raramente sono ascoltate, illustrarne le dinamiche interne, misurare la propria capacità nel comunicarle.
Alzare lo sguardo oltre la logica “ho un gig=esisto”, essere più interi di così.
Qualità: questo è il discrimine. Spesso migliora quando si confronta con territori altri.
È innegabile comunque che l’audience sia piuttosto impigrita, molto ripiegata su sé stessa, spesso senza domande.
Ho qualche annetto e posso dire di aver conosciuto audience molto più attive, piene di interrogativi, critiche, considerazioni.
Il problema è meno evidente in altri paesi, forse più usi a programmazioni più avventurose, ma in Italia è davvero palese.
Ecco: trovare il giusto modo di ri-suscitare qualche dubbio, qualche sospensione, in un’audience così auto-indulgente è il compito più importante, un po’ oltre una buona presentazione.
Il tempo chiede una riconfigurazione del rapporto con l’ascolto.
Non solo per quanto riguarda la musica. È un tempo nel quale ci sono molti trasmettitori ma pochissimi riceventi: è uno squilibrio, le cose stanno fuori rapporto, in uno stallo quasi bulimico. Anche qui: “ fare meno e meglio” sembra una ricetta molto efficace.
7. Tu suoni molto, o almeno abbastanza, anche in altri paesi, quindi sei piuttosto indicato per rispondere a questa domanda: è davvero così diversa la sensibilità del pubblico? Se così è non può dipendere da un’impostazione culturale che, fin dall’infanzia e dalla scuola, riserva alla musica un ruolo più che marginale?
GM: Non c’è alcun dubbio e non riguarda solo la musica. Ma non dimentichiamo che l’impoverimento culturale del nostro paese negli ultimi 20 anni è stato impressionante: uno spostamento pauroso verso una fruizione di tipo Luna Park, una specie di carrozzone permanente.
Pur considerando che il momento storico investe con eguale intensità tutti i paesi del pianeta trovo che, in generale, l’interesse per il fenomeno culturale sia più vivo in altri paesi e la fertilità degli incontri possibili, più forte.
L’educazione scolastica e uno sguardo più curioso sono una peculiarità che abbiamo in gran parte perduto e che andrebbe recuperata.
È come se le aperture fossero più flessibili, i pubblici più eterogenei, l’attenzione più vivace, positiva.
Io credo dipenda in gran parte dalle programmazioni e dalle loro declinazioni.
L’attività artistica, in Austria o in Finlandia ad esempio, è seguita con attenzione dal pubblico e dalle amministrazioni. Non è solo questione di supporto, comunque importante, ma soprattutto di considerazione.
Presentare un progetto è plausibile, semplicemente. Essere soggetti culturali, avere una contrattualità, trovare una relazione culturale di qualche tipo con la società. È una relazione reciproca, aperta da entrambi le parti.
Non è una cosa straordinaria, che succede solo nei paesi avanzati, è una cosa normale. Siamo noi ad essere retrocessi, a non vederne più la necessità.
La società si abitua da subito a frequentare una galleria d’arte, uno spettacolo di danza, un’istallazione in un parco.
Molto spesso le differenze di età si annullano e troviamo ai concerti giovanissimi e anziani, differenti classi sociali, provenienze pronte a mischiarsi.
La cultura è di casa, non un’estranea. Meno guardata, più vissuta da vicino, direi. C’è una compenetrazione più continua fra società e cultura.
Anche in Italia capita, naturalmente, ma più episodicamente. Questo rapporto si verifica in modo più discontinuo, diciamo.
Il sistema educativo musicale meriterebbe una totale riconfigurazione, è una vecchia storia. Il processo appare lentissimo, tuttavia esistono bravissimi didatti che in mezzo a mille impedimenti burocratici fanno un grande lavoro.
E’ davvero durissima, così.
La scuola è uno dei nostri più grandi problemi, gli investimenti nell’educazione, marginali.
Non nascondendo un certo scoramento, penso però che la formazione è senza fine, ma mai come oggi abbiamo avuto la possibilità di approfondire, di creare un nostro, proprio percorso.
I ragazzi devono cercare altre strade, forse autonome. I canali educativi mainstream non sono più sufficienti.
Lavorare con ciò che si ha, diceva Cage.
8-9. Anche se ciò che si ha è veramente poco!!!!
Recentemente mi capita con sempre più frequenza di imbattermi in musicisti che provengono da una formazione musicale punk (in particolare hardcore) e fanno sperimentazione, e anche in musicisti che sono dediti contemporaneamente a entrambi gli aspetti. In egual misura mi capita di incrociare ragazzi di formazione accademica che, oltre a suonare in qualche orchestra o formazione classica, hanno il loro gruppo rock. Tu stesso hai sperimentato delle ‘libere uscite’ dall’ambito che ti è più congeniale. Premesso che apprezzo queste commistioni, vorrei farti, al proposito, due domande ben distinte.
Possono favorire una crescita culturale del pubblico, abituandolo comunque alla conoscenza di un mondo, quello dei suoni, molto più vasto di quanto si può immaginare e facendolo uscire da un approccio aficionadesco?
Quanta è l’esigenza di sperimentare mood diversi, da parte dei musicisti, e quanto è invece un escamotage per sopravvivere in un momento in cui facendo musica in un unico ambito riesci a stento a sopravvivere (vuoi perché, come sappiamo, l’attività del musicista è sempre meno redditizia vuoi perché la concorrenza si è amplificata in modo eguale e contrario)?
GM: Sì, molto spesso le commistioni generano ascolti più interessati, non fosse altro che per il cambio di prospettiva che offrono.
In quelle “libere uscite” può capitare di assistere alla nascita di veri e propri meta-linguaggi, di territori intermedi dai quali le visuali sui rispettivi mondi sono stimolanti. Rivelanti, in un certo senso.
Tuttavia non basta accostare due o più elementi distanti per creare comunicazione, può succedere che il risultato sia anonimo, superficiale. Funziona quando si lavora con un focus, con una buona consapevolezza del materiale in campo.
Certe collaborazioni con altre forme d’arte, sono davvero interessanti.
Suonare con danzatori o poeti o pittori o scultori ad esempio. Succede non di rado che i due diversi pubblici interpretino in modo nuovo ciò che conoscono e scoprano ciò che non conoscono.
Ma anche in termini creativi: è importante misurare la propria cifra stilistica con piani differenti di tensioni, di intenzioni verbali o gestuali o visive...
È anche una questione di attitudini: ci sono musicisti polivalenti, veramente a proprio agio con qualsiasi situazione, alcuni davvero brillanti.
Forse è una vocazione più interpretativa, non saprei dire.
Io sono meno flessibile di così, ma ci sono mondi molto distanti che non finiscono di affascinarmi.
Alla seconda domanda è facile rispondere: ci sono entrambi le possibilità.
Certe volte, l’ho visto succedere più d’una, accade che un musicista non sa dov’è e prende il primo tram che passa, disposto a vedere come andrà a finire.
I tempi sono duri, lo capisco. E poi ognuno ha le proprie fisime, chi sono io per criticare?
Io sono molto attratto da certe forme. Sono piuttosto attratto dalla sensibilità del pittore, dello scultore. Mi piace questa cosa che il pittore o lo scultore vede “prima” di incominciare il lavoro. Lessi, tempo fa, certi diari di Giacometti, molto importanti in questo senso. Certe collaborazioni hanno dentro quella stessa possibilità. Ecco in quel caso sono certo che il lavoro sarà proficuo. Si tratta di relazioni, in fondo.
Artistiche, se vuoi, ma relazioni.
Io voglio continuare a sperimentare, non sempre questa cosa è foriera di libertà! Molto spesso sperimentare vuol dire lavorare in ambiti più stretti, nei quali ciò che puoi dare è, forse, solo un colore sonoro, un’idea.
E lì si concentra tutto quello che puoi fare. Tu hai uno stile, un modo di dipanare la tua matassa di suono, ma improvvisamente il tempo, la line up, il mood così distante rimettono tutto in discussione, sotto un’altra luce.
In altre occasioni il ventaglio si apre totalmente e bisogna trovare una misura senza perdere la giusta intensità. È interessante, naturalmente è una specie di specchio anche. Spesso impietoso.
10. Da parte mia cerco sempre di distinguere fra sincerità e non sincerità, fra arte e mestiere, cosa non sempre facile, tanto che spesso le due categorie vengono accomunate in un unico ordine…
GM: Sì! “Chi ci è e chi ci fa”. L’autenticità ha un valore unico ed è il solo discrimine, anche nei rapporti umani, che garantisce qualità.
In un certo senso direi che “vero” è sempre meglio che “bello”, tanto per essere assoluti.
Oggi in quasi tutti gli ambiti musicali c’è una tendenza ad apprezzare un certo atletismo. Vedo molto “catalogo” in tanti progetti. Come una musica dimostrativa, dura poco ed è presto consumata.
Onestamente trovo spesso sincerità anche in chi fa il mestiere, l’uomo per tutte le stagioni. Conosco professionisti così scrupolosi e appassionati, pronti a sposare l’idea cui partecipano con dedizione e con l’obiettivo di fare bene alla musica.
Ho visto fare il mestiere anche a qualcuno dei miei Dei: che strana sensazione. Ma alcuni erano sinceri anche in quella parte minore di sé.
Se “ci sei e non ci fai” il coinvolgimento è più profondo, forse non tutti vogliono essere convolti così. Per molti è importante sentirsi parte di un mondo così: ne imparano i codici, li sistemizzano, li ripetono e così chiudono forse la porta alla propria crescita. Non so, sono traiettorie diverse.
Si cresce anche in modo disordinato, dopotutto.
11. Tecnica e tecnicismi: spesso mi trovo costretto a difendere l’una o l’altra sponda fra chi sostiene che la musica valida è unicamente questione di tecnica strumentale e chi invece, al contrario, sostiene che dalla tecnica può venir fuori solo un inutile sfoggio della stessa. Come vedi la questione?
GM: La tecnica è il mezzo. È molto semplice. Esistono tecniche oggettive e soggettive. Nel rapporto tra queste due forze sta l’acquisizione della tecnica/mezzo che sublima la musica.
Il tecnicismo è lo sguardo corto. È chiudere il proprio orizzonte affidandosi all’esercizio, come se l’esercizio stesso fosse l’obiettivo. Il trionfo della separazione.
È anche una questione di attitudini, credo.
Sviluppare un’ottima tecnica e sposarla con la consapevolezza, la giusta sensibilità, beh... quello è davvero grande.
Per me tecnica è principalmente esplorazione: posso stare su un particolare a lungo non tanto per acquisirlo, quanto per capire quante cose contiene.
Alcune volte succede che pensi a quanti colori timbrici posso sviluppare da quel singolo segmento o indugi su un intervallo che mi sembra nasconda ancora qualcosa. Ragiono in termini complessi, l’esercizio è una porta.
La tecnica, o forse sarebbe meglio dire “le tecniche”, è/sono comunque parte integrante dell’arte. Alcuni stili, alcune svolte artistiche sono nate dalla frequentazione, dall’esplorazione e soprattutto dalla messa in discussione della pratica tecnica. In certi casi è come se contenessero la scintilla necessaria a sviluppare una cosa cui pensavi da tempo. “Don’t get bored from your own practice. Keep your music fresh”, mi disse un maestro.
Non perdere lo sguardo complessivo, potrei dire.
Ci sono anche aspetti, banalmente funzionali e relativi allo strumento che si suona. Senza un rapporto meravigliosamente bilanciato tra tecnica e sensibilità non avresti Pollini, Coltrane, Cecil Taylor. Non avresti Hendrix, Buckley, Bach. E non avresti la possibilità di ascoltare Ligeti. È quella pregnanza, è quella compenetrazione.
12. Una volta la musica era divisibile in categorie esteticamente ben riconoscibili (in linea di massima): classica, jazz, pop, folk, elettronica … Oggi le commistioni fra queste sono così tante, e poi ci sono quelle fra queste e le varie culture estrinseche, cosicché una categorizzazione è sempre più difficile … Io, da tempo, vado sostenendo una prima suddivisione che si basa sulla tipologia del pubblico, sulla circuitazione degli eventi e dei materiali, sui metodi di vendita e di promozione … in pratica, sempre in linea di massima, mi sembra che la separazione netta sia oggi fra circuiti major e circuiti indipendenti … Trovo che una comunanza di audience, di strutture, di metodologie sia molto più facile da individuare fra la tua Amirani e la Wallace di Mirko Spino che non fra la tua Amirani e la Sony (e non ne faccio una questione di meriti e/o di qualità) … condividi questa mia visione della contemporaneità (una visione basata sul dato di fatto che nella società contemporanea a valere non sono più i titoli nobiliari ma i conti in banca)?
GM: Per quanto riguarda circuitazione, metodologie e, in parte, anche strutture, sicuramente la divisione è netta. L’audience è una cosa più volatile da definire oggi, meno individuabile di un tempo.
Sicuramente in un impianto strutturale economicamente complesso come la gestione di una major, le decisioni creative si sviluppano in modalità executive e sono articolate su linee completamente diverse se le compariamo a quanto avviene in indie labels come Amirani o Wallace.
Esistono tuttavia esempi virtuosi di produzione che combinano il catalogo intelligente, stimolante e vivace, con una produzione curata e di qualità.
Guarda l’austriaca Kairos, per esempio. Se c’è un supporto, anche minimo, e una linea artistica chiara, si riesce a fare bene sia dal punto di vista documentativo che da quello di circuitazione.
Un po’ come l’editoria classica, quella dei libri. Ve ne sono alcune che crescono dal basso e fanno davvero cose egregie anche se fra molte difficoltà.
Le categorie sono più indecifrabili, è vero. Forse ha a che fare anche con il fatto che non esistono più movimenti artistici o scuole, almeno nel senso tradizionale del termine. Gli artisti sono forse più isolati, o perseguono strade, originali o meno, in modo solitario o solo superficialmente condiviso.
Anche qui: penso che ci sia una buona dose di responsabilità da parte degli artisti stessi e che la mancanza di confronti seri sul “che fare”, sulla funzione del produrre arte oggi, sul sentirsi parte di una comunità intellettuale (questo è un ruolo forse completamente perduto), abbiano generato delle linee espressive spesso di corta gittata.
Il momento (ma si tratta di cosa sistemica, credo) è certo confuso, ma anche le risposte creative sono molto mediate, spesso fagocitate da durate brevissime, subito superate da altre cose che dureranno ancor meno.
Una label indipendente può far bene e, proprio perché di soldi ce ne sono pochi, può prendersi il tempo di tenere un rapporto meno superficiale con la produzione di un album. Può fare in modo che il catalogo non sia una raccolta di demo, un album è una cosa un po’ più compiuta.
La facilità di accesso alla modalità produttiva ha spesso generato approssimazione, dobbiamo fare meglio di così.
Ma non sempre l’energia è sufficiente e in genere il musicista è refrattario all’approfondimento. Troppe cose cui pensare, forse.
Ho spesso l’impressione che si pensi più a uscire con un album, piuttosto che al suo reale contenuto. C’è uno squilibrio che mi trovo spesso a dover correggere quando mi si presenta un progetto nel quale intravedo della qualità: alla domanda “perché è necessario uscire con questo lavoro?” il musicista non sa rispondere. Forse non si ricorda più qual è la spinta iniziale, forse non ha avuto il tempo di configurarla, di confrontare questa idea.
Le divisioni del mercato, o da esse generate, sono reali, ma lo smarrimento di consapevolezza da parte degli artisti, è anche un dato importante.
Io sono stato, e continuo a essere, molto critico con l’establishment ma, se la Decca mi proponesse un contratto, manterrei la stessa lucidità, la stessa problematica attitudine? Sarei ancora così critico? O basta essere su un tram che, organizzativamente e produttivamente, funziona per dimenticare le proprie convinzioni?
Se è solo una questione di commodities, le mie categorie sono insufficienti.
Se sono un artista compiuto, problematicamente attivo, potrei rimanere lo stesso anche dopo la firma con Decca.
Il mio amico clarinettista Ove Volquartz, che ha forse un paio d’anni più di me, mi dice spesso che invecchiando si avverte sempre più chiaramente che non c’è bisogno di dimostrare niente. Tutte le cose sono già lì. E quindi si può pensare in modo più libero. Più dedicato, se vuoi.
Ho cercato di fare così anche con la mia etichetta per esempio quando ho aperto la collana dedicata alla contemporanea, territorio spesso in mano a nomi importanti della produzione discografica. Mantenere un profilo serio e credibile e non rinunciare alla propria peculiarità: questo l’obiettivo.
Pur nelle difficoltà economiche mantenere un po’ di rigore editoriale, creare un profilo che resti chiaro.
Amirani è una piccola realtà, non so ancora quanto durerà. L’impegno è piuttosto importante e seguirla da solo è talvolta totalizzante. Tuttavia, quanto fatto fin qui è il massimo che potevo e complessivamente credo sia stato un buon lavoro. Certo alcuni numeri avrebbero meritato anche più attenzione e promozione, ma questo forse presuppone una squadra, un’idea collettiva più che l’azione di un singolo.
Ma sul compito aggregativo dei soggetti culturali nel nostro paese, sulla sua costante frammentazione, sulla carenza di sistema, si può compiere un’indagine sociologica e storica davvero rilevante. E non so se i soggetti coinvolti sarebbero così interessati ad approfondire. “Approfondire” non sembra un’opzione molto frequentata...
13/14/15 A proposito di Amirani, ho notato che (con metodo e senza esagerare) hai aperto il catalogo a musicisti di derivazione non propriamente jazzistica, da una parte, e a musicisti non italiani, dall’altra … volevo chiederti se in conseguenza con ciò c’è stato un aumento nella diffusione?
Volevo anche chiederti quali sono i paesi nei quali le tue pubblicazioni sono più richieste?
E, infine, se fai degli scambi di materiale con altre etichette?
GM: Il catalogo è sempre stato aperto a molte declinazioni e a molte provenienze sin dall’inizio. Inoltre considera che nelle musiche improvvisate, nel post jazz se vuoi, compaiono davvero colori di tutte le specie.
In UK o Germania la scena è composita e non ascrivibile con facilità a questa o a quell’altra strada.
Il mio duo con Alison Blunt o il trio con Elisabeth Harnik e Clementine Gasser ad esempio... Nessuno di questi musicisti viene dal jazz ma il loro apporto è straordinariamente stimolante: una nuova musica, forse più europea con un senso formale “altro”.
Certamente la platea si è allargata e spesso Amirani Records trova più asilo in territori distanti dal jazz. Con l’apertura della linea Contemporary le cose poi si sono ancora più mescolate: avere Arditti quartet che suona un autore contemporaneo italiano e avere nello stesso disco un percussionista come Milo Tamez è un indice delle cose di cui parlo, oppure Lenoci che interpreta Bussotti o Feldman...
Sì c’è stata una maggiore diffusione e una maggiore considerazione, anche.
I paesi esteri dove più vendo sono Germania, Belgio, UK, Finlandia, Francia, USA e Giappone. Molto meno in Italia. Ho poi qualche particolare collezionista qua e là in giro per il pianeta.
Ho sempre scambiato con altre label e anche co-prodotto molto. Molto spesso queste collaborazioni possono portare la musica che faccio e/o che produco verso pubblici che non immaginavo essere interessati.
16. Mi capita sempre più spesso di ascoltare chitarristi che fanno musiche sperimentali, laddove per tradizione la chitarra veniva utilizzata soprattutto nelle musiche folk e popolari, e allora mi domando: è la musica popolare che sta diventando sempre più sperimentale o è la sperimentazione che sta diventando una faccenda popolare?
GM: Vedo che nella “sperimentazione” (troppe cose vengono chiamate in questo modo e molto spesso nascondono una noiosissima vena mainstream) la chitarra è spesso usata come porta per accedere al mondo dei suoni.
Voglio dire che si ascolta raramente il vero suono della chitarra: questa è usata nella gran parte dei casi come generatore di vibrazione e poi processate attraverso una valanga di filtri, pedali, effetti generativi etc.
Molto spesso lo skill richiesto non è quello chitarristico, ma la conoscenza dei vari device. Forse si può parlare di un altro strumento...
Musicisti che si dedicano alla sola chitarra acustica o elettrica: beh non sono molti in quel campo: nella derivazione Bailey veramente pochi, ad esempio.
Molte cose sono successe, e succedono, nell’ambito più accademicamente contemporaneo, anche se finalmente si stanno aprendo, un pochino, le porte. Penso a Scodanibbio, giusto per citare, che ha scritto cose molto belle per chitarra, modernissime. Anche nella musica di derivazione jazz il linguaggio chitarristico ha accolto più di una mutazione (si pensi all’impronta timbrica di uno Scofield o di un Frisell). La precipitazione stilistica della chitarra è più rintracciabile in questi ultimi territori, secondo me.
L’approccio più coloristico, così diffuso fra i giovani, è in parte dovuto alla facilità di accesso, credo, a un’immediata dimestichezza con la manipolazione della timbrica attraverso gli effetti elettronici.
Per molti lo strumento dal quale parte la catena sonora è meno importante di quanto si pensi.
17. Sbaglio o la composizione va assumendo per te un’importanza sempre maggiore (rispetto all’improvvisazione)?
GM: Non tengo le cose distinte, io penso sempre compositivamente anche quando improvviso. Ciò che cambia è il tempo nel quale si può costruire o indicare una possibile forma percorribile.
Molti conoscono ciò che Lacy disse a Frederic Rzewski, quando quest’ultimo gli chiese una risposta (in 15 secondi!) intorno alla differenza fra composizione e improvvisazione: “In 15 seconds, the difference between composition and improvisation is that in composition you have all the time you want to think about what to say in 15 seconds, while in improvisation you have only 15 seconds”, ma pochi ricordano che la frase di Steve prese esattamente 15 secondi.
Ho sempre pensato fosse che quella risposta fosse una composizione in sé.
In fondo, e neanche tanto, si tratta di una questione di forma.
L’improvvisazione più riuscita è spesso quella nella quale l’energia, il reciproco ascolto, la dislocazione delle tensioni, la sovrapposizione di linee e la loro trasparenza sono bilanciate, offrendo un’architettura almeno intuibile, apprezzabile, insomma.
In sostanza una testimonianza diretta intorno a qualcosa che mostra il suo modo di accadere. Una creazione.
L’improvvisazione non è una cosa semplice. È complessa: un alto grado di attenzione, di ascolto, di visione dell’insieme e allo stesso tempo una disponibilità sincera a perdersi, ad appartenere alla musica.
La spontaneità è importantissima, ma la coscienza, anche di quella stessa spontaneità, lo è di più.
Ho incontrato molte improvvisazioni perfettamente inutili nella loro entropica dispersione di energia: non basta aggiungere materiale, creare strati, aspettare che il fuoco si accenda, innescare una catena di eventi di azione-reazione, domanda-risposta, tensione-rilascio e, infine, felicitarsi se vi sono stati alcuni momenti nei quali il climax raggiunto abbia una qualche qualità.
Ho sovente ripetuto che io sono per un’improvvisazione nella quale “succedono cose”, elementi si dislocano nello spazio, offrendo angolature di sguardo e di possibile percorso.
Io mi sforzo di avere “senso della posizione”, di “vedere” la musica che sto improvvisando, di avere coscienza del “suo” tempo.
Negli ultimi anni, gli ultimi dieci direi, ho avvertito chiaramente che è così importante uscire dalla logica enciclopedica e dimostrativa.
L’improvvisazione ha una natura così alchemica che è davvero un peccato sprecare quel tesoro in una routine nella quale sciorinare il proprio catalogo di abilità.
Sto forse privilegiando un’idea più complessiva esercitando un’attenzione dinamica al particolare.
Naturalmente molto dipende dalla natura, dalla particolarità dei musicisti coinvolti: il mio sguardo iniziale è, quasi sempre, influenzato dalla timbrica, dai colori sonori.
Dialoghi a specchio, texture, aree nelle quali certi elementi tornino a presentarsi sotto nuova luce, spazi e pesi drammatici: un po’ come a teatro, direi. Tutti queste cose (e molte altre ancora) con l’obiettivo di comprendere dove va la musica che hai per le mani, di abbandonarvisi con fiducia, di consegnare una sublimazione.
Delivering è una parola che uso spesso nel descrivere la mia musica: al termine di quell’improvvisazione, deve vedersi un oggetto, una forma che rimanga a farsi osservare per un po’.
Ora: non è forse anche questa una sorta di composizione?
Istantanea, se vuoi, ma composizione.
In passato, ma vi sto ritornando ancora, ho lavorato con il testo, la parola, il teatro, la danza, l’immagine, la performance.
Tutte queste cose mi hanno probabilmente spinto a pensare/concepire in termini, appunto, costruttivamente e de-costruttivamente formali.
Ultimamente ho ripreso un discorso aperto moltissimi anni fa: l’utilizzo di partiture grafiche intese come strutture da usare come strategie improvvisative, per piccoli e più ampi ensemble.
In questo caso “vedo” la forma prima, una mappatura che può essere attraversata abbastanza liberamente, ma con indicazioni talvolta molto strette.
Uso simboli che vengono da un mio vocabolario personale, ma anche altri codificati. Più che una campitura, un paesaggio sfaccettato nel quale linearità e astrazione sono vicinissime. Il lavoro Prossime Trascendenze è il più completo, al momento, in questo senso.
Naturalmente il tempo di concezione, applicazione, ragionamento è più lungo. Ma, davvero, non credo così diverso in termini concettuali.
18. Quando pensi a una composizione per ensemble, del tipo non istantaneo, cioè a una tua struttura alla cui realizzazione chiamerai altri musicisti, quali sono gli aspetti sui quali ti soffermi maggiormente, i nodi più difficili da sciogliere, quelli che ti richiedono più tempo e lavoro prima di raggiungere un aspetto soddisfacente (forma, colore, lato emozionale ….)?
GM: Direi che gli elementi che richiedono una maggiore attenzione nella preparazione sono tre:
- Il primo riguarda, se c’è, l’ispirazione: fedeltà all’idea-scaturigine e quanto sono disposto a renderla elastica, trasformabile.
- Poi l’aspetto gerarchico dei suoni: questo ha molto a che fare con i musicisti coinvolti, la loro declinazione timbrica, le loro attitudini. Qui si decide il colore, forse. Si decide l’interazione, si delinea quell’aspetto costellativodi cui parlavo prima.
- In seguito, il modo di illustrare, rendere, la struttura chiara e percorribile ai musicisti. Quest’ultimo è un aspetto davvero importante e, spesso, determinante. E reciproco: si comprende bene la caratura delle forze in campo, ma bisogna talvolta usare esempi e metafore differenti. Quando è curata con attenzione, questa comunicazione può davvero dare grandi risultati e aprire a nuove considerazioni. Una struttura che sia solida ma anche flessibile, lineare ma animata su più livelli, che suoni naturale ma con la porta aperta allo sconosciuto. Spesso nella pittura vedo questi elementi che appaiono oggettivati sulla tela. La forza del segno o della luce. Certi dipinti, certe sculture sono così.
19. Quindi gli strumentisti coinvolti hanno una certa libertà interpretativa... ti capita mai di dover cambiare qualcosa, rispetto all'idea iniziale, o di dover accantonare del tutto un progetto perché non trovi nessuno conforme alla realizzazione della tua idea?
GM: Dipende dalle composizioni/strategie... Nella gran parte dei casi si ha la libertà di usare un certo numero di parametri e, sempre la possibilità di imprimere un’angolatura all’insieme. Tutti i musicisti hanno innanzi a sé l’intera partitura, tutti possono comprendere la dinamica, lo sviluppo complessivo e quello particolare nello stesso tempo.
Talvolta capita di dover rimaneggiare un’idea per diverse ragioni, ma in generale riesco a incanalare le possibilità.
Quando si arriva ad ascoltare il risultato di una forma che soddisfi in buona parte l’idea iniziale... beh, quello è molto gratificante, naturalmente.
E mi è capitato più di una volta di non essere soddisfatto, anche.
Sì, mi è anche successo di non poter realizzare perché i musicisti non hanno le caratteristiche che pensavo, o che credevo. Ma le difficoltà logistiche ed economiche sono la vera ragione per cui la gran parte dei progetti non si realizzano. Non puoi pensare “più in alto” perché l’obiettivo è troppo ambizioso non per ragioni concettuali, ma economiche.
19 bis. Qual è la scintilla che dà lo stimolo per una nuova composizione, qualcosa di reale, e concreto, o qualcosa di immaginario e completamente astratto?
GM: Sono stimoli esterni o interiori che arrivano, in certi casi sedimentano e poi trovano il sistema di sviluppare una loro declinazione musicale.
Come succede per la lettura: certe cose lette, messe tempo prima da qualche parte nel proprio archivio mentale e sentimentale, che riemergono diventando improvvisamente chiare: A volte dopo anni.
L’ispirazione per me ha sempre a che vedere con qualcosa di concreto.
Non sempre è immediatamente comprensibile. Alcune volte comprendo la provenienza, l’origine di quella composizione dopo molto tempo, come se la rivelazione fosse indipendente dalla musica che ha prodotto. In altri casi la forza dell’idea iniziale è chiarissima perché il richiamo che ha è fortissimo.
Certe poesie, certi testi o certi dipinti sono per me fondamentali.
Io penso alla musica come uno spazio nel quale i suoni sono soggetti quasi teatrali: è come se componendo dislocassi quelle forme in quello spazio.
Recentemente durante un workshop mi è stato chiesto se di illustrare il più precisamente possibile la relazione di un brano che ho composto con il dipinto che dichiaravo averlo ispirato.
L’ho fatto spiegando in modo molto dettagliato le funzioni che leggevo in quel quadro: il peso formale dato dalla stasi di una figura femminile, come sospesa, nell’incanto di una finestra spalancata su campi ordinati e obliqui sul versante di un colle. Una scena figurativa, dunque, che si frantuma tutt’intorno in una serie di riflessi sui vetri di quella finestra. Una specie di soglia, di sospensione, appunto. Una sobrietà nei colori di una stagione di mezzo, in quel quadro. Quindi: un forte soggetto centrale, fermo e quasi vinto da una pace fatta di piccole esplosioni di richiami, viste laterali alterate da luci diverse, dialoghi a specchio fra le cose: una calma appena increspata da dolci tensioni.
Un dipinto intimo forse, nel quale le linee sono chiare, ma nascondono il loro aspetto inquieto: è con questi elementi che è costituito quel brano.
Certe volte, accade che le parole o i rumori di un luogo giochino un ruolo attivo nel concepire uno score.
C’è una poesia di Francis Bacon che cito sempre come esempio per questo: la lessi in epigrafe a un racconto di Borges. Nella traduzione italiana risultava appena macchinosa e quindi, per comprenderla, mi accorsi che stavo rileggendo verso per verso, ricominciando daccapo ogni volta e ogni volta capendo un pochino di più. In questo modo certe parti tendevano ad accavallarsi, alcune, ripetute, sembravano scontate, acquisite.
Alla fine tutto si risolveva in una massima illuminante, rivelatoria.
In questo caso, le parole stesse e le loro ondate sillabiche sono state la struttura di quel brano. Recentemente le stavo facendo rivedere alla vocalist inglese Viv Corringham (è una composizione di oltre 10 anni fa) e mentre le dicevo che in inglese sarebbero risultate molto più facilmente musicabili, lei mi faceva notare come proprio la complessità meravigliosa dell’italiano fosse la ragione stessa della struttura del pezzo.
Altre forme arrivano così, mentre stai studiando: certi intervalli chiamano a certe costruzioni, certi suoni mi fanno “vedere” la loro stessa dislocazione e comporre diventa creare relazioni tra loro.
Oppure le armoniche contenute in certi rumori semplici o complessi, nelle voci di bambini, in certi ambienti naturali o artificiali. Si compone quando si ascolta bene, insomma.
Tuttavia non tutte le ispirazioni si concretizzano. Molte cose rimangono lì, a decantare forse. O forse ad attendere di trasformarsi in altro.
20. … E delle collaborazioni collettive cosa mi dici? Come nascono? Quali tempi richiedono per raggiungere un livello accettabile?
GM: Nascono nei modi più diversi, molte volte per connessioni improvvise e con diverse declinazioni. Da alcune nascono ibridi, spesso interessanti ma con gittata di durata variabile. Certe altre sono stabili fin da subito, altre ancora rimangono attive perché ogni volta è una scoperta.
Le formazioni/collaborazioni stabili cui partecipo hanno caratteristiche differenti, ma tutte permettono di indagare funzioni e relazioni diverse.
A livello internazionale il tempo di provare e di rodare un ensemble, un duo, un quartetto, è spesso pochissimo, in taluni casi, occasionale. Quindi, si arriva spesso in studio o dal vivo con le sole armi della sensibilità e dell’apertura.
Quando c’è un buon livello di coscienza non occorre tanto tempo per comprendere la qualità del lavoro che si sta facendo nell’ensemble e se è, o meno, una strada che promette di durare.
E poi certi musicisti sono una vera garanzia, ognuno per le proprie particolarità naturalmente. Con qualcuno di loro il legame si fa strettissimo: due parole o due suoni e si arriva subito alla stanza del tesoro.
Le formazioni sono spesso evoluzioni o spin-off d’idee primigenie, incroci o evoluzioni di un aspetto, di un colore musicale per il quale si sente di dover chiedere a quel musicista particolare di partecipare all’idea.
Come sempre è nel corso di un tour che si prende una misura, che ci si accorge che l’energia sta crescendo e che si ha a che fare con stimoli nuovi.
In certi concerti si avverte chiaramente che la materia sta prendendo una fisionomia, un’identità. Una maturità, forse.
21. Mi risulta che svolgi pure una terza attività, oltre a quelle di musicista e di discografico, sempre legata alla musica, ma di tipo più manuale?
GM: Sì, da circa trent’anni ho un mio laboratorio dove lavoro/riparo/restauro strumenti a fiato, principalmente sassofoni, clarinetti e flauti. Gran parte del mio lavoro si svolge su strumenti d’epoca e, con il tempo e lo studio, ho maturato una buona esperienza. Mi sono perfezionato in Francia alla metà degli anni 90, ma da allora ho poi proseguito da solo. E’ un buon lavoro, in parte meditativo, con molte scoperte sulla formazione del suono, che permette di affinare l’orecchio e di approfondire la timbrica in modo quasi fisico.
C’è una parte manuale che ti permette quasi di toccare il suono e gli strumenti hanno caratteri e differenti personalità.
E’ un lavoro che mi ha permesso anche di studiare approcci differenti e stili, oltre a farmi conoscere tanti musicisti.
22. E' tramite questa attività che, stando a quanto mi scrisse lui stesso in un'intervista, hai conosciuto Xabier Iriondo, con il quale è nata sia un'amicizia sia una collaborazione trasversale piuttosto importante per entrambi?
GM: Sì, ci incontrammo la prima volta nel mio laboratorio. È un carissimo amico, con lui molto ho condiviso, e spero di poterlo fare ancora e a lungo.
Ci siamo spinti fino alla creazione di una sorta di meta-linguaggio che ha fruttato non pochi concerti e la realizzazione di più di un progetto originale.
Il lavoro di recording e di elettronica che Xabier ha curato nella realizzazione del mio video “Kursk _ Truth in the End” è stato perfetto e ha generato una comunicazione e una comprensione reciproca che ci accompagna da allora.
Il nostro lavoro “Your Very Eyes” è stato davvero molto apprezzato ed è stato rappresentato più volte in ambiti molto diversi fra loro, e seguito con eguale attenzione da pubblici molto eterogenei.
Anche il lavoro sulle immagini del film di Serghej Paradjanov “Sayat Nova” svolto insieme a Cristiano Calcagnile alle percussioni è stato molto importante per i nostri rispettivi percorsi.
Percorsi che rimangono diversi, e forse proprio in questa diversità trovano la loro originalità, la loro freschezza.
Nella relazione profonda e sincera si trova sovente più di una risposta, più di un’indicazione. È un’offerta di prospettiva differente che aiuta a vedere le proprie attitudini da altra angolatura. Più di una rivelazione. È affinare la propria estetica, grazie ad uno sguardo “altro”.
C’è un grande valore in questo.
23. Con chi ti piacerebbe suonare o aver suonato (mi riferisco anche a musicisti che ormai non ci sono più)?
GM: Il primo nome che mi viene è Stefano Scodanibbio. Alla sua morte ho veramente pensato che avrei voluto così tanto poter suonare un duo con lui.
Mi piacerebbe suonare con il pianista e compositore giapponese Yuji Takahashi perché ogni volta che lo ascolto scopro un lato che non sospettavo, una modernità e coesistenza di derivazioni impressionanti.
Mi sarebbe piaciuto suonare con Julius Hemphill, con Gil Evans..
Sono tanti: con il passare del tempo mi sembra più interessante guardare ad artisti distanti da me stilisticamente. Mi piace molto la violista Ig Henneman, sono contento di incontrarla e poterla ascoltare molto presto.
24. Ed esiste qualcuno con cui non suoneresti mai, neppure se torturato (si fa per dire)?
GM: Sì.
25. Perché non lo sopporti o per paura di fare brutta figura?
GM: Sono molti i musicisti con i quali non suonerei.
Ma, per rispondere alla tua domanda: nessuna delle due cose.
Sento che non devo, non è necessario.
Vorrei non fare cose non necessarie.
26. Se dovessi consigliare a un neofita alcuni tuoi dischi, quali sceglieresti?
GM: Quando mi fanno questa domanda, di solito rispondo che i dischi in solo sono molto identificativi per riconoscere la “voce” che li anima, quindi i titoli potrebbero essere One way Ticket (Amirani Records) e Further Considerations(Tarzan Records).
In quelli ci sono delle direzioni liriche e una speciale relazione con il silenzio.
Una formula che ho spesso frequentato è quella del duo: ne ho fatti davvero tanti. Lì è più facile e intrigante osservare, data la formula così nuda, lo snodarsi del pensiero, dell’energia che li abita.
I più significativi sono certamente Lasting Ephemerals con la violinista Alison Blunt, Reciprocal Uncles con Gianni Lenoci al piano, Turbulent Flow con il violoncellista Daniel Levin e Live at Bauchhund con Harri Sjöström al sax soprano. Sono tutte collaborazioni che mi hanno profondamente coinvolto, sono lavori concettualmente e stilisticamente “interi” e attraversano quasi tutta l’area delle affinità che ho. Inoltre rappresentano spesso i nuclei generativi di ensemble più estesi come trii e quartetti fino ai più recenti Prossime Trascendenze (quintetto e sestetto) e Aural Vertigo con Sestetto Internazionale. Mentre questi ultimi sono certamente più indicativi del rapporto con una complessità a più livelli e forse i più maturi in senso musicale, i miei lavori in trio con The Shoreditch Trio (con Hannah Marshall al cello e Nicola Guazzaloca al piano) e con Wild Chamber Trio (con Elisabeth Harnik al piano e Clementine Gasser al cello), hanno una freschezza particolare e trasversale.
Il recentissimo lavoro con la pianista giapponese Yoko Miura, Departure uscito per la label Setola di Maiale del carissimo Stefano Giust, ha riscosso subito una grande attenzione nei pochi concerti live fatti finora. Le composizioni sono di Yoko, minimali, quasi infantili nella loro candida linearità. Eppure è un mondo così delicato, così suo, che non potevo approcciare che con rispetto.
Ma mi rendo conto che sto consigliando l’intera mia discografia a questo neofita!!
27. Dovendo invece consigliare a un tuo estimatore l’ascolto di materiali altrui dove cadrebbe la scelta?
GM: Ci sono alcuni ascolti che consiglio quasi sempre e sono quelli cui spesso ritorno. Hanno prevalentemente a che fare con le varie mappe che ho mentalmente redatto, hanno a che far con questo pantheon estetico così affollato che frequento.
Ascolto cose molto distanti fra loro, sia in senso temporale che stilistico: musica classica, contemporanea, jazz e derivati...
Qui metto delle cose che consiglio a tutti:
Ad esempio i brani “Se la mia morte brami” e “Sparge La Morte” di Gesualdo da Venosa dai Madrigali a cinque voci. È roba della fine del ‘500 accecante per bellezza, arditezza formale, profondità.
Io trovo, sembrerà strano, molta attinenza sperimentale con “Four Compositions” di Roscoe Mitchell uscito per Lovely Music anni fa.
Salvatore Sciarrino in “Luci Mie Traditrici” uscito per Kairos ha toccato un vertice davvero altissimo. Così come Steve Reich in The Cave, dove il concept coincide con la musica in modo completo. Non molti conoscono il lavoro di Steve Lacy sui testi di Judith Malina e Julian Beck intitolato “Packet” uscito per New Albion. Lì il suono più bello di Lacy per me.
“Interstellar space” di Coltrane e Rashed Ali e il “Kammer Conzert “di Ligeti.
Quali sono le origini dell’etichetta? Come è nata l’idea? Quali ispirazioni ci sono state? A quali modelli, se ci sono stati, si è fatto riferimento?
Le origini di Amirani records risiedono nell’ascolto di una parte incosciente del mio pensiero. In realtà non esistono giustificazioni di ordine artistico o esigenze di visibilità o altro.
È stato l’unico sistema possibile per lavorare alle mie condizioni, cioè concentrando il massimo dell’attenzione sulla contraddizione tra fare della musica e assumersi la responsabilità di farla circolare.
Credo di aver fatto questa scelta testarda perché in fondo amo complicarmi l’esistenza. Dal punto di vista economico è, semplicemente, una scelta suicida. Quindi se lo fai ci deve essere un valore quasi imprescindibile, fatto di attenzione, valore della relazione e soprattutto sincerità.
Poi mi sono detto, e ancora mi dico, che era una necessità, in fondo una specie di dovere. C’era un sacco di lavoro fatto e l’assurdità di non averlo fermato, testimoniato.
L’aiuto e i consigli di persone provenienti da mondi musicali diversi è stato fondamentale. Mirko Spino di Wallace mi ha dato linee molto concrete e in fondo è stata una spinta d’entusiasmo.
Poi la mia testa e la testardaggine ha fatto il resto. Ci sono diverse label che mi piacciono, quasi tutte di ambito contemporaneo, e sì, mi piacerebbe avere un catalogo e un profilo come l’austriaca Kairos, ma semplicemente non posso e il mondo nel quale mi dibatto è diverso.
Come scegli le produzioni? Come scegli i gruppi?
Il discrimine è sempre, e sempre sarà, la sincerità. Se viene mene questo semplice e raro parametro, a me la musica non interessa.
Abbiamo molta calligrafia, molta enciclopedia, molta dimostrazione e non c’è bisogno di aggiungerne altra.
Io voglio occuparmi di cose intere, possibilmente profonde che mi venga voglia di ri-pensare, che siano fragranti e complesse, che abbiano una gittata comunicativa e non siano auto-referenziali.
A me non piace quasi niente, anzi se una cosa mi piace molto, mi insospettisco. Invece sono molto attratto dalla forza dei tentativi, mi attrae l’impressione di avere qualcosa di luccicante fra le mani e incominciare a farsi domande. In fondo credo che la musica sia questo: avere una luce e farla riverberare. Io non so davvero se scelgo cosa produrre, sicuramente so cosa “non” produrre. Eppure, davvero vorrei poter fare di più, ma in questo tempo confuso e vano forse è illusione. Alcuni musicisti che stimo mi dicono che questa è documentazione, e forse è vero. Ma io mi dico spesso che è un gesto prezioso, semplicemente prezioso. Un tentativo enorme, con ricaduta blanda, di penetrazione sociale.
Il rischio di frustrazione è praticamente inevitabile, ma ogni volta questa possibilità di trovare e fare il meglio che si può con quello che hai rende il tutto appetitoso e fresco.
Come sono i rapporti con i musicisti?
Normalmente buoni, i taluni casi ottimi, in certi, trascendentali. Certe relazioni sono fatte per crescere a poco a poco, altre vogliono dire tutto ciò che possono subito. A me piace indagare a fondo il concept, seguirne l’evoluzione e comprendere perché mi attrae. Quindi se i musicisti sono persone profonde, il rapporto è destinato a fruttare. Spesso parto da un punto di vista di necessità. A volte capita di avere prodotti bellissimi fra le mani, ma, come dire, un po’ inutili… Così, siccome io posso produrre poco per ragioni di denaro, preferisco farlo per cose che siano, a loro modo, imprescindibili. Con taluni musicisti poi, è una gioia lavorare.
La rifinitura, l’idea grafica, il peso del tempo e un’urgenza di freschezza sono le soddisfazioni di questo lavoro.. Prima di diventare un album, la musica è uno spazio molto interessante da frequentare anche nei suoi aspetti laterali.
Cosa pensi delle coproduzioni?
Ho avuto solo soddisfazioni dalle co-produzioni. È importante e strategico stare in più cataloghi. Si arriva a platee finalmente diverse, si istilla differenza, si hanno relazioni con persone altre. Che poi è la funzione di questa storia: arrivare in altri posti. Se il pubblico che ti ascolta non è il tuo pubblico, si aprono scenari fruitivi totalmente diversi. E, credimi, questo, oggi, è agire nel sociale.
Ho prodotto con la Wallace, per fortuna così diversa da Amirani, con LongSong records di Fabrizio Perissinotto, con la Phonometak di Xabier Iriondo la ReR Megacorp di Chris Cutler, Grim Media records. E con loro c’è una differenza, un rispetto e uno stesso sguardo schietto che mi fa sentire orgoglioso di conoscerli e di stare con loro in mezzo a sto casino.
Quali pensi siano state, analizzando questo primo spaccato di uscite, le produzioni migliori targate Amirani Records? Quali le peggiori?
Amirani ha oggi 5 anni e 25 produzioni al suo attivo, mi sembra di dover rallentare. Lo dico sempre e non lo faccio mai, ma, prima o poi, dovrò fare meno e meglio di così. Tutte le produzioni di Amirani dovevano uscire secondo me. Le migliori per me sono quelle nelle quali ho potuto approfondire di più l’idea iniziale, trattarla come materia viva e arrivare a un prodotto che non vedeva l’ora di andarsene in giro, via dalle mie mani. Cito il primo numero One Way Ticket perché è stato il seme giusto al momento giusto. Cito Kursk perché è un video che ha richiesto una preparazione infinita, ma ancora oggi mi commuove e poi Samsingen, dove ho fato il produttore puro. Your Very Eyes con Xabier è un piccolo capolavoro, forse neanche tanto piccolo. Il 6 cds box di Braxton, il concept “on War”intorno al concetto di guerra,nel quale ho coinvolto molti progetti diversissimi e tutti intensissimi, Forgiving July, il trio che ha girato molto, Five Rooms e poi gli ultimi The Shoreditch concert, Reciprocal uncles e Blastula con Cristiano Calcagnile e Monica Demuru fino all’ultimo proprio ora in uscita “ Flatime” secondo capitolo di EaSilence. Ma avete sentito Eclipse? O Noble Art? o il live di Enzo Rocco con Lol Coxhill? Davvero non ci sono passi falsi. Ci sono cose che avrei dovuto approfondire di più, questo sì.
È che faccio tutto da solo, con una presunzione talvolta fuori misura…
Con chi ti è piaciuto collaborare sia come produttore che come musicista? Con chi vorresti collaborare sia come produttore che come musicista?
Sto provando a co –produrre con un paio di label americane, la Rastascan di Gino Robair e la Balance Point Acoustic di Damon Smith, nel tentativo di pubblicare il mio tour con Reciprocal Uncles( io + Gianni Lenoci) e quindi gli incontri fatti laggiù. C’è in arrivo una co-produzione con Setola di Stefano Giust, prezioso amico, musicista e documentatore infaticabile.
Ma amerei spingermi un po’ più in là e vedrò che riesco a fare. Per esempio varrebbe la pena di confrontarsi con label con i soldi, ma che lavorano con serietà e rigore. l’idea è ancora quella di un concept molto forte coivolgendo progetti diversi, sulla linea di On War.
Come vedi la scena musicale italiana?
Non vedo nessuna scena, vedo solo persone. Spesso il linguaggio è molto omologato, in parte inutile. Mi spiace essere amaro, ma la sento così. Vedo poi molte scintille, bagliori, e poi piccoli progetti e anche grandi progetti, ma slegati fra loro. Non esiste una scena, se mai esistono luoghi, con minore o maggiore densità.
Ma proprio perché è confusa, la situazione va osservata con schiettezza evitando il più possibile la superficialità. E poi tentare connessioni con le linee fertili. Ma è un momento assai opaco, quindi oltre a vedere, bisogna anche “sentire”.
Come vedi la scena live italiana?
Vorrei parlare della scena live parlando di ciò che c’è giù dal palco. Questa e la vera cosa da osservare: di come è cambiata, sottraendosi, la fruizione. Più passiva, meno selettiva, televisiva e “divanizzata”, la fruizione è molto difficile, per certi versi impossibile. Questo succede proprio nel massimo della possibilità di indagare le proprie curiosità. È la sottocultura, è il rapporto quasi masochistico del non esserci davvero.
Ho visto momenti migliori, molto migliori e credo che siamo a un punto di non ritorno. Il pubblico non esiste, secondo me. O meglio non esiste più. Esistono singole possibilità e forse, per la mia musica, l’obiettivo è ritentare di tessere, piano piano, una rete comunicativa che rimanga attiva anche dopo il concerto. La musica non può essere solo il concerto. La musica è un fenomeno sociale. Esce e penetra nel sociale. Anche il musicista più remoto e solo, su di un’altura dell’Uzbekhistan, è un fenomeno sociale. L’arte è un aiuto fondamentale all’interpretazione del mondo. Un’occasione di usare categorie altre. Quello che chiamiamo pubblico, sembra un insieme smarrito, che cerca di ridurre ciò che gli accade innanzi a fenomeno fine a se stesso, un’immagine fra le tante.
Alterare, spostare, e nello stesso tempo ricominciare a spiegare, a narrare questo è oggi il compito di un live.
Progetti futuri?
Molti, troppi forse. La label aprirà presto una piccola collana di musica contemporanea, altra follia, come non bastasse quello fatto finora.
I progetti musicali personali attivi sono parecchi e tutti importanti: sarò con Gianni Lenoci di nuovo in Usa il prossimo febbraio, perché Reciprocal Uncles davvero funziona in modo molto serio, si apre un nuovo quartetto di fiati con Alessio Pisani_fagotto, Mirio Cosottini_tromba e il mio fido Angelo Contini_trombone. Lo Shoreditch trio( con Nicola Guazzaloca_piano e Hannah Marshall_cello) sarà in tour in Belgio nel prossimo ottobre, in uscita il cd e in tour il mio duo di sax soprani con il grande Harri Sjöström, incisione e concerti in Italia e Uk per Granularities in compagnia di Martin Meyes_french horn e Lawrence Casserley-signal processing instrument, un trio incredibile. E poi la prospettiva alterata e spirituale di Mistaking Monks con i miei due fratellini Xabier Iriondo e Cristian Calcagnile. Qui abbiamo un lavoro sulle immagini di Serghei Paradjanov, regista visionario e magico che sarà in giro a settembre e poi un lavoro in arrivo.
Ma c’è anche un mio vecchio lavoro su testi di Beckett, Bacon, T.S.Eliot che vorrei far venire alla luce dopo che è stato ri-arrangiato per quintetto da camera dal compositore Federico Cumar.
Credo inoltre che entro al fine dell’anno avremo un piccolo festival della label.
Verrà un tempo nel quale sedere e guardare, anche.
"Il talento fa quello che vuole, il genio quello che può"
(Carmelo Bene)
Abbiamo già avuto modo di raccontare ai nostri lettori dell’immenso Tesoro che abbiamo qui in Italia, e che ancora troppo pochi conoscono.
È privo di senso affermare che nel desolante panorama del jazz italiano Gianni è un faro. Anzi il faro. Perché il jazz, come altri generi codificati, stanno davvero troppo stretti agli araldi della nuova musica. Figure come Derek Bailey ( che dell’arte dell’improvvisazione ha addirittura fatto verbo scritto, accettandone il concetto di sepoltura dell’orale) o Keith Tippett davvero non sono biodegradabili in un genere, specie codificante come, appunto il jazz che in questi casi suona come un insulto aggettivante al puro genio.
Saxofonista soprano, colto intellettuale, umile artigiano dell’ancia, teorico del verbo nuovo, agitatore culturale verace e consapevole, rapace assimilatore di vibrazioni inaudite, sognatore di onde, editore e discografico di eccezionale purezza d’intenti ma, soprattutto uno dei più grandi musicisti che ho avuto l’onore di conoscere nella mia lunga carriera di ascoltatore di suoni.
Con la sua etichetta, Amirani Records, da anni scandisce con regolare rintocco i vertici della migliore musica libera mondiale e, si sa, la libertà non è mai a buon prezzo. Con caparbia lucidità e progettualità, l’ho seguito da anni in iperbolici duetti con musicisti di palpitante passione e talento, da Vinny Golia ad Angelo Contini.
Lo incontro nella suggestiva Next Gallery a Piacenza: un bellissimo spazio arso dell’incenso dell’indifferenza della massa e del potere politico che sperpera i quattrini altrove e condotta da un artista multimediale di enorme talento, Lino Budano: in questa occasione Gianni Mimmo suona con un quartetto che vede Angelo Contini al trombone e conchiglie, Fabio Sacconi al contrabbasso e Alsion Blunt al violino.
Chiedo intanto a Gianni alcune delucidazioni e poche -le solite- ricette.
In tanti avatar ti abbiamo sentito suonare. Parlami di quello di questa sera che ti vede assieme a Angelo, Alison e Fabio.
Gentle Vertigo è quartetto che cerco sempre di combinare quando con Alison Blunt torno per qualche gig in Italia. Amo molto la combinazione fiati-archi e trovo che la derivazione classica di Fabio Sacconi e di Alison spingano l’improvvisazione in un ambito formale molto elegante, senza perdere la possibilità dello slancio, della costruzione emozionale e della moltiplicazione delle linee. Angelo Contini è sempre una garanzia di generosità e io “vedo” davvero la possibilità del disegno. Sono musicisti che agiscono, più che reagire. Da qualche tempo la band ha un suo suono e questo è un bel segno. Angelo è un mio collaboratore da sempre, con Alison credo sia la quarantaquattresima che saliamo su un palco insieme e Fabio è ogni volta più inventivo, davvero un gran suono. E’ una musica di spazi e sfaccettature, ma ora c’è molta più coscienza dei pesi “drammatici”: ci sono colori weberniani e funamboliche esposizioni solistiche. È un oggetto che cambia in continuazione.
Dedicheremo il concerto a Ornette Coleman che è scomparso ieri. Credo gli dobbiamo molto tutti quanti. Durante il viaggio, io e Alison canticchiavamo la sua Lonely Woman. Credo che certe sue sfuriate armolodiche faranno capolino stasera...
Oltre che a un argonauta della musica nuova come musicista lo sei anche come discografico, parlami della straordinaria etichetta che conduci: la Amirani e la sua storia, la sua mission.
Amirani Records sta diventando adulta: ha compiuto ora dieci anni e ha al suo attivo oltre quaranta uscite. C’è un’identità ormai evidente, c’è testimonianza, c’è qualità, c’è attenzione per la musica sincera, ci sono accostamenti coraggiosi, musicisti bravissimi e persone vere.
Ogni singolo disco porta con sé un po’ di luce proveniente da questo sforzo di sincerità.
L’intenzione di Amirani è guardare ai nodi vibranti di una rete artistica non banale. Io credo molto alla possibilità di una “ricaduta sociale” di questi atti produttivi. Mi piace pensare si tratti di un soggetto che istilla dei dubbi, che offre uno sguardo obliquo. Voglio che Amirani continui a star fuori dai cortili... che continui a sentirsi straniera in ogni luogo:
sai, come quando ti capita di incontrare la luce mentre non te l’aspetti... Piccole rivelazioni, lievi scuotimenti.
Tanto per complicarmi l’esistenza, ho deciso di aprire anche una collana di contemporanea nella quale già compaiono nomi quali Bussotti, Cage, Clementi, Feldman, Palermo (un autore davvero interessante che nel volume a lui dedicato vanta un’interpretazione del quartetto Arditti) e presto avremo Earle Brown.
Talvolta succede che chi compra un album Amirani, si incuriosisca e individui un percorso personale all’interno del catalogo. Perché alcune linee trasversali sono davvero possibili: derivazioni, declinazioni, impatti.
In fondo si tratta di un semplice sforzo culturale ma oggi è significativo e coraggioso. È una pratica politica, credo.
Come è nata la tua passione x la musica e per il sax? Quali le tue influenze?
La mia passione è per il suono, è sempre stato così. Io sono sempre stato attratto dai rumori, ancora oggi mi appassiono per il rombo di un aereo nel cielo, di notte. O per l’improvviso silenzio di certi pomeriggi e per il conseguente ronzio nelle orecchie (Cos’è? La circolazione sanguinea?).
Quando ero ragazzo registravo il passaggio dei treni su un piccolo recorder a bobine che mio padre portò a casa. Ci sono episodi, che mi hanno spinto verso la musica, per i quali provo grande riconoscenza: entrato, appena dodicenne, di nascosto in un teatro, l’ascolto delle prove di un orchestra francese che aveva in programma La Mer di Debussy, per esempio. Oppure le lunghe sedute di ascolto cui un mio zio professore di tromba mi sottoponeva: opera lirica, sinfonica, soprattutto musica da camera. Il sax compare a 14 anni, più per il fascino della sua forma, ma dopo l’acquisto di un disco Impulse di Archie Shepp, ho aperto una porta e non l’ho più richiusa.
Attraverso quella porta sono passate moltissime influenze: è persino banale ripetere nomi come Lacy, Coltrane, Dolphy, Braxton, Mitchell, Ashley, Hemphill.
Ma ho forti debiti con strane voci trasversali come Marion Brown o bianchi come Warne Marsh.
Ho sempre avuto una forte volontà autodidatta e non ho mai smesso di sperimentare: sono stato a lungo altista e anche baritonista. Il jazz più spericolato è stato la mia scuola, ma non la sola. Io ho sempre amato la sperimentazione: nel 78, io compravo Cage edito da Cramps e ho sempre trovato affinità con certa letteratura. Mi sono sempre interessato alla musica per la danza e per il teatro.
Sono arrivato presto alla contemporanea attraverso la mia passione per l’arte: la pittura e la scultura. Una lezione che Emilio Vedova tenne all’università, cui assistetti da liceale in fuga, mi rivelò l’esistenza di Berio, Maderna, Bussotti, Cage.
Decisamente le mie più grandi influenze vengono da artisti come Giacometti, Bacon, Rothko, naturalmente Pollock, ma anche da molti classici: Vermeer, Piero della Francesca. Un certo seicento fiammingo, una certa luce d’interni hanno per me una bellezza quasi insostenibile, ma anche certa geometria del design anni 50/60 genera attenzione e rigore.
Webern è un po’ così: certi intervalli impossibili hanno lo stesso peso di certi vuoti del miglior Miles. Non faccio molte distinzioni di genere, mi piacciono le cose vere. Ultimamente ho visto una mostra molto completa di Felice Casorati e da lì vengono due forti ispirazioni all’origine di un mio recentissimo progetto.
Ho un pantheon ampio, ma non confuso. Mi attrae la “strategia del perdersi”.
Il sax soprano è una scelta invece maturata molto a lungo: io sapevo già alla fine degli anni 70 che avrei finito per dedicarmici in modo completo.
Lacy e un suo lavoro con la poesia di un poeta che ora non c’è più, Adriano Spatola, furono in una loro performance una vera rivelazione. Ancora oggi ne ho un ricordo vivido e indelebile. Sono stato allievo di Lacy per un pochino e le cose si sono fatte ancora più complesse. Ecco: la complessità, la ricchezza delle possibili sfaccettature, la ricerca timbrica in uno strumento così ingrato... sono tutte lì le cose che mi attraggono, che mi tengono acceso.
So che è un maëlstrom ma azzardo a chiederti quali sono i tuoi progetti x il futuro prossimo…
Ho alcuni progetti che devo finalizzare e ai quali guardo con interesse e timore (il timore è di non avere il tempo necessario per realizzarli al meglio): vorrei dedicarmi un po’ di più alla composizione attraverso le partiture grafiche e i text score. Le cose che più mi hanno dato in termini progettuali hanno caratteristiche strategiche abbastanza stimolanti per me.
Il lavoro con Alison Blunt “Lasting Ephemerals” mi ha confermato che una attitudine compositiva sta emergendo con forza nel mio modo di improvvisare. Un’attenzione formale che sapevo di non avere smarrito, sta facendo capolino e voglio darle una buona chance.
Ho registrato in due sessioni un quintetto (sax soprano, corno inglese, corno francese, violino e percussione) e un sestetto (sax soprano, tromba, trombone, corno di bassetto, viola e contrabasso), due suite per un lavoro che avrà il titolo “Prossime Trascendenze”. Sono partiture grafiche che utilizzano strategie e indicazioni abbastanza precise e guidano l’improvvisazione verso una zona nella quale la forma respira a pieni polmoni, forse con un’attitudine narrativa che nemmeno sospettavo.
Sarò di nuovo in Finlandia a Settembre con il Sestetto Internazionale che il mio “fratello sopranista” Harri Sjöström ha approntato, ma nel frattempo il mio duo con l’appena scomparso Garrison Fewell e quello con Vinny Golia devono essere ultimati per la produzione.
Ci sono poi cose sempre pronte a trasformarsi, sono come dei landmark fluidi e importantissimi. Ogni volta che torno a questi musicisti le cose che accadono sono sempre vive e interessanti: Gianni Lenoci, Cristiano Calcagnile, Angelo Contini, Alison Blunt...
In realtà io vedo anche più lontano, ma è meglio attendere il tempo del “fine tuning”.
Un lavoro che davvero mi piacerebbe riproporre, e che ho rappresentato una sola volta, è un text-score intitolato “Heraclitus, Luminosi Frammenti” per pianoforte e piccola elettronica, sax soprano e voce di baritono/basso. Il trio con Lenoci e Nicholas Isherwood ha davvero un impatto emozionale potente e le parole dei frammenti di Eraclito sono forti e modernissime...
Come vedi la situazione della musica jazz e di quella improvvisata in Italia e nel mondo?
Questa è una domanda che mi fanno sempre e alla quale rischio di rispondere in modo ripetitivo.
Io non credo nel valore dell’antologizzazione delle categorie e degli stilemi.
Credo sia il momento di portare certa musica nei luoghi dove certa musica non si è mai ascoltata. La musica improvvisata, la composizione istantanea, il jazz, se vogliamo, deve abbandonare la strada della (auto) celebrazione e (ri) pensarsi come forza sociale, una forza alterativa.
Per me è un problema di programmazione e di fruizione: stimolare la modalità fruitiva, riallacciare le connessioni con un audience autoindulgente e pigra. Bisogna pensare “alto”. Un ripensamento dei modelli di comunicazione è necessario anche da parte del musicista: io trovo molto pressapochismo dappertutto, devo dire.
Tuttavia bisogna ricordare che per un musicista oggi la vita è davvero dura.
Un musicista si trova a dover ricoprire tutti i ruoli della filiera produttiva: dalla creazione alla realizzazione finale, dalla promozione alla vendita... E’ davvero un’impresa nella quale è facile perdersi e perdere il contatto con il proprio sentiero.
Tuttavia esempi luminosi esistono: artisti meno” seduti” nel proprio supposto “ruolo”, più coscienti e responsabili, intendono la musica come un’arte dal forte potere sublimativo, un’arte destinata a un percorso più complesso: che non si esaurisce nel circolo, quasi vizioso, di performance, produzione, recensione (anche banale), scomparsa. Un respiro più ampio è necessario: molte musiche, anche quelle interessanti, devono pensarsi fuori dai loro cortili.
Ecco: “pensarsi”. Basterebbe questa parola per rispondere alla domanda.
Con quale musicista sogni di incidere un album? Intendo un sogno ancora irrealizzato…
Mi piacerebbe molto realizzare un lavoro corale che coinvolga molte discipline contemporaneamente: luce, scultura, architettura, pittura, teatro, urbanistica, testo, video-grafica, danza e una grande orchestra.
Un’opera che investa la comunità non come un evento spettacolare, ma come una costante presenza interrogativa.
So che mi metterebbe in relazione con categorie complesse e concettualmente stimolanti. So che potrei fare bene.
Naturalmente ci sono musicisti con i quali certe cose sarebbero più facili... Ma vorrei pensare in modo meno minimale, talvolta.
Credo che alzare il tiro serva davvero a tutti, oggi.
Domanda di rito: quali 10 dischi porteresti con te sull’isola deserta?
Beh, io ho diverse “isole deserte”! Ci sono isole dove giro scalzo e lacero e altre nelle quali mi trovi col blazer...
Porterei musiche che hanno ancora cose da dirmi, da scoprire.
Lascerei a casa dischi, anche importantissimi, che mi hanno detto e dato tutto quello che mi serviva. Quando riascolto certi capolavori, mi accorgo di cedere alla celebrazione.
No, su un’isola deserta porterei cose che ancora mi spostano... Diciamo che non porterei ricordi. Porterei musiche che possano contribuire a rendere l’isola deserta un posto interessante, una possibilità.
Ad esempio e non in ordine d’importanza:
- Steve Reich “The Cave” S.R. dir. Paul Hillier (Nonesuch)
- Salvatore Sciarrino “Luci Mie Traditrici” Klangforum Wien, dir. Beat Furrer (Kairos)
- John Cage “Sonatas and Interludes for Prepared Piano” versioni di Joshua Pierce (Wergo 1975), Yuji Takahashi (Fylkingen 1965, Denon COCO 1975), John Tilbury (Decca 1974)
- Gesualdo da Venosa “Libro Sesto dei Madrigali a Cinque Voci” (molte edizioni)
- Robert Wyatt “Ruth is Stranger than Richard” (Virgin)
- J.S.Bach “Cello Suites” Pierre Fournier (Archiv)
- Terry Riley “Salome Dances for Peace” Kronos Quartet (Nonesuch)
- Steve Lacy “Packet” (New Albion)
- Evan Parker “Aerobatics , Saxophone Solos“ (Incus 1975)
- Morton Feldman “Something Wild” (Kairos)
- J.S.Bach “Six Partitas” Maria Tipo (EMI)
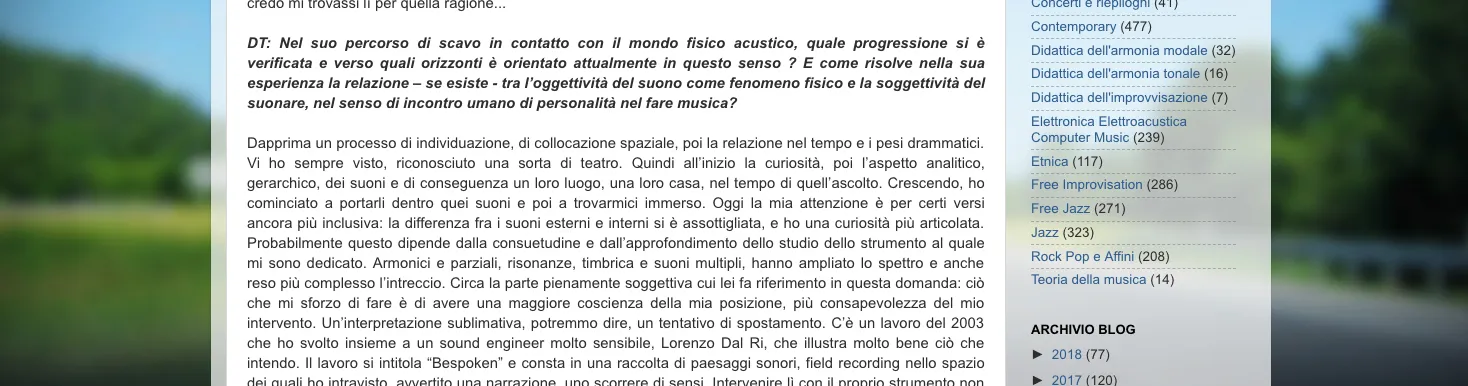
Negli anni della sua formazione quale è stata la sua prima esposizione alla musica non idiomatica o informale o, forse e meglio, “altrimenti formale” ?
Grazie per la parola “esposizione”! E’ proprio così. Mi sono esposto presto, direi. Ricordo molti episodi che ora forse tendo a schiacciare nella prospettiva temporale.
Ricordo l’impatto dirompente di un live in solo di Cecil Taylor nel 75, alcuni dischi di Archie Shepp che aprirono delle porte importanti... Mitchell, Braxton, Marion Brown, naturalmente Coltrane, Lacy, Rivers...
Il primo numero della collana Musicha Nova della Cramps dedicato a John Cage fu una rivelazione incredibile. Lo comprai durante un festival rock davvero storico nel 76 a Milano, perché un brano era interpretato da Demetrio Stratos non conoscevo Cage.
Dei lieder di Webern che mio zio professore di tromba aveva messo sul giradischi mi sembrarono subito straordinari perché astratti e così simili a una sorta di paesaggio sonoro che andavo costruendo con il registratore a bobine che mio padre portò a casa, quando ero ragazzo...
Ho sempre avuto una forte curiosità per i suoni, per la loro dislocazione nello spazio. Ancora oggi mi appassiono spesso per il rumore di un’auto che corre in viale deserto di sera, per il clangore di certe officine o per il vento in montagna. A 14 anni ho registrato il treno e nel laboratorio di un tecnico il suono di quattro radio contemporaneamente accese sulla ricerca delle frequenze a onde corte...
Una volta lessi un’intervista a LaMonte Young nel quale ricordava il suono, lo schiocco, dei cavi elettrici al sole del deserto come la prima vera colonna sonora della sua vita. Capisco molto bene cosa intendeva...
Tuttavia credo che il concerto che Lacy tenne nella mia città in duo con il poeta bolognese Adriano Spatola nel 76, fu luce chiarissima.
L’aspetto sillabico, la geometria imprendibile e un lirismo astratto, puro... quello è un punto molto alto. E Musica Elettronica Viva, Alvin Curran...
Scoprì poco prima dell’esistenza di Nono, Berio, Maderna attraverso Emilio Vedova il quale tenne una lezione universitaria alla quale partecipai da liceale in fuga. Io penso alla pittura come alla mia più grande influenza, credo mi trovassi lì per quella ragione...
Nel suo percorso di scavo in contatto con il mondo fisico acustico, quale progressione si è verificata e verso quali orizzonti è orientato attualmente in questo senso ? E come risolve nella sua esperienza la relazione – se esiste - tra l’oggettività del suono come fenomeno fisico e la soggettività del suonare, nel senso di incontro umano di personalità nel fare musica?
Dapprima un processo di individuazione, di collocazione spaziale, poi la relazione nel tempo e i pesi drammatici. Vi ho sempre visto, riconosciuto una sorta di teatro. Quindi all’inizio la curiosità, poi l’aspetto analitico, gerarchico, dei suoni e di conseguenza un loro luogo, una loro casa, nel tempo di quell’ascolto. Crescendo, ho cominciato a portarli dentro quei suoni e poi a trovarmici immerso. Oggi la mia attenzione è per certi versi ancora più inclusiva: la differenza fra i suoni esterni e interni si è assottigliata, e ho una curiosità più articolata. Probabilmente questo dipende dalla consuetudine e dall’approfondimento dello studio dello strumento al quale mi sono dedicato. Armonici e parziali, risonanze, timbrica e suoni multipli, hanno ampliato lo spettro e anche reso più complesso l’intreccio.
Circa la parte pienamente soggettiva cui lei fa riferimento in questa domanda:
ciò che mi sforzo di fare è di avere una maggiore coscienza della mia posizione, più consapevolezza del mio intervento. Un’interpretazione sublimativa, potremmo dire, un tentativo di spostamento.
C’è un lavoro del 2003 che ho svolto insieme a un sound engineer molto sensibile, Lorenzo Dal Ri, che illustra molto bene ciò che intendo. Il lavoro si intitola Bespoken e consta in una raccolta di paesaggi sonori, field recording nello spazio dei quali ho intravisto, avvertito una narrazione, uno scorrere di sensi. Intervenire lì con il proprio strumento non è utilizzare un tappeto sonoro, è rendere complesso e sciogliere dei nodi di quel divenire, è cambiare prospettiva. Dopo questo processo la restituzione è quasi spirituale, c’è un respiro più profondo che attraversa la percezione.
Come interludi, abbiamo utilizzato il rumore di una stessa pioggia, ad una stessa ora, ma ripresa da differenti posizioni, interno ed esterno di una costruzione. Allora ecco che una naturale drammaturgia offre dei piani creativi molto interessanti. In fondo è sempre una questione spazio, di campiture espressive.
Con i musicisti con i quali collaboro, questa relazione si ripropone a seconda delle personalità, delle caratteristiche e delle derivazioni di ognuno, naturalmente. Il mio lavoro con la violinista Alison Blunt ha davvero a che fare con la prospettiva, con un pensiero formale complesso.
Con un terzo partner attivo dell’ensemble rappresentato appunto dall’ambiente nel quale suoniamo. Anche lì, con declinazione strumentale, abbiamo a che fare con la dislocazione di elementi, con sovrapposizioni, con gerarchie e con ritorni. Stessi oggetti sonori che si mostrano da altre angolature.
Questo è piuttosto evidente in Reciprocal Uncles, il mio duo con Gianni Lenoci, (ma anche ormai un brand che consente ampliamenti e intersezioni con altri musicisti disposti alla relazione). In questo duo gli oggetti sonori che si formano hanno poco a che vedere con un processo reattivo. Le risposte agli stimoli reciproci sono raramente dirette, ma piuttosto concorrono ad un’improvvisazione nella quale succedono delle cose, accadono fatti.
Esercitare un’attenzione al particolare e conservare un’idea complessiva:
conservare il senso della posizione, appunto, ma con un grande coinvolgimento fisico, attivo. Per certi versi estatico.
Ha partecipato a tutte le 8 edizioni del festival dell’ ISIM, società internazionale di base negli USA, di impronta accademica che “promuove performance, educazione e ricerca nella musica improvvisata e fa luce su connessioni fra improvvisazione musica le e creatività attraverso i diversi ambiti”. Puoi farci conoscere il valore di quel contesto e parlarci della sua workshop/performance in quella sede con Reciprocal Uncles nel luglio scorso a Chateau d’Oex ? Può precisare quali sono la sue procedure, declinazioni e linee di condotta nell’equilibrio del sound complessivo in ognuna delle formazioni con le quali ha maggiore consuetudine ?
Il principio, la scaturigine, per me è quasi sempre di natura timbrica. Voglio dire che il mio sguardo iniziale è spesso determinato dai timbri coinvolti.
Il mio duo con Harri Sjöström per esempio è un dialogo a specchio, un duo di sax soprani: in questo caso si parte quasi sempre da “dentro”, da una densità evidente e fortissima. Il processo è una dipanazione, uno sciogliersi in colori, uno scarto che da coincidente diviene parallelo e intersecante al tempo stesso. L’improvvisazione con Harri è una successione di big bang, nella quale la ricombinazione degli elementi derivanti dal dissolversi della densità dà luogo a una ricombinazione spesso divergente, dove si possono seguire più linee contemporaneamente.
Una delle mie combinazioni preferite è il trio con pianoforte e cello: ho due formazioni stabili con questa line-up: lo Shoreditch Trio (con Hannah Marshall al cello e Nicola Guazzaloca al pianoforte) e il Wild Chamber Trio (con Elisabeth Harnik al piano e Clementine Gasser al 5-string cello). Qui è interessante distinguere come, in una stessa line-up timbrica dichiaratamente cameristica, cambi la declinazione formale a seconda dei musicisti coinvolti. In entrambi le formazioni sento che il ruolo del sax soprano sia piuttosto assertivo, “davanti”, ma che proprio per la configurazione del trio le possibilità di interplay e di texture sono altissime. Nello Shoreditch Trio emergono spesso squarci melodici, per certi versi passionali, che sono interessanti da mitigare con la scelta di spazi, di aree larghe dove le voci tornino a farsi evidenti; nel Wild Chamber Trio le linee sono più algide, rigorose e pure: è un cristallo che non vede l’ora di sporcarsi un po’. Recentemente al Taktlos Festival di Zurigo abbiamo davvero fatto bene con questo trio: musica molto bilanciata, in termini espressivi. Abbiamo lavorato su una sorta di lunga suite, sentita però per capitoli. Movimenti, direi.
Reciprocal Uncles è un luogo dove davvero possono succedere cose. Suonare in duo con Gianni significa frequentare senza scampo la possibilità di spostamenti immediati, di cambi di profondità, di ricerca timbrica, di corse a perdifiato e di ascetiche astrazioni. Da quando abbiamo compreso di avere per le mani questa plasticità abbiamo aperto le porte alle collaborazioni: Cristiano Calcagnile, Ove Volquartz, Alison Blunt, John Hughes, Vinni Golia, Angelo Contini, Fabio Sacconi... Abbiamo lavorato insieme al cantante baritono-basso Nicholas Isherwood sui frammenti di Eraclito, con cori di canto gregoriano, con orchestre e large ensemble, con la danza. Davvero una logica propulsiva che abbiamo portato in Europa e negli USA.
Il mio lavoro con Alison Blunt è di genere alchemico, trasformativo. Negli ultimi due anni abbiamo condiviso il palco in oltre quaranta concerti, in Italia, Germania, UK, Belgio, Austria, Scandinavia e un lungo tour negli Usa. Abbiamo suonato in teatri, chiese, case, navi, centri sociali, festival, club, scuole, stazioni e parchi e ogni volta questo duo agisce una grande sincerità: per esempio non ha paura di essere lirico. Alison ha una formazione classica, un elegante senso formale e una flessibilità autentica, mai enciclopedica o dimostrativa. In questo duo la relazione con l’ambiente è fondamentale: ci sono concerti nei quali si operano sottrazioni: l’ultimo all’inizio di Agosto, nella chiesa di Sedbergh, Lake District, ne è stato un chiaro esempio. Certi concerti sono più importanti per le note che non suoni... Ma sempre privilegiamo un’idea complessiva, tendiamo a chiudere quando davvero vediamo un oggetto completo. In inglese usiamo spesso la parola delivering per descrivere la nostra performance. Alla fine rimane un oggetto. Delivered. La musica ha prodotto un oggetto che rimane lì, come a farsi osservare, per un poco.
Provo sempre stupore nel pensare alla disparità nel rapporto quantitativo tra la musica “scelta” per essere pubblicata/documentata e tutta quella “vissuta” privatamente e quotidianamente da un artista. Vuole dire qualcosa di questa relazione, tenendo conto anche delle implicazioni sulla produzione di musica definita “d’arte”?
E’ un tempo questo nel quale essere discriminanti rappresenta una funzione irrinunciabile. È un mondo nel quale la funzione principale per una mente creativa è discernere. Davvero è inutile, e in parte anche colpevole, aprire la propria cornucopia e versare soltanto perché oggi è più facile farlo. Inoltre in molti casi la cornucopia non esiste proprio. Ci sono cose che vanno consegnate e altre cui è bene riconoscere un ruolo più immediato, più funzionale. Poi ci sono dei semi che vanno fatti germogliare. Devi tenere un’attenzione complessiva sulla tua parabola . E poi ci vuole un tempo per pubblicare, per comprendere quale linea tenere. Negli ultimi due mesi sono dedicato a un lavoro registrato in duo con il chitarrista Garrison Fewell che è recentemente e prematuramente scomparso. Il materiale è davvero buono per molti motivi, tuttavia ci siamo trovati a scartare alcuni brani particolarmente ben riusciti, ma esteticamente isolati, a favore di una linea complessiva più coerente a tutto il lavoro. Il risultato ha un’intensità che permette una visione completa, una complessità fruitivamente permeabile e intera al tempo stesso, voglio dire che è importante capire dove va la musica che hai per le mani, che la tua considerazione non si può fermare al livello: “mi piace, ci faccio un disco”. Inoltre ci troviamo davvero di fronte a problema di mutamento, di frammentazione della fruizione che mette forse in discussione il concetto stesso di produzione. La tenuta nel tempo del tuo prodotto è un problema che investe oggi principalmente il suo versante appunto concettuale. E poi non è che siamo qui a fare antologia... La produzione è un’aggiunta, bisogna esercitare una qualche responsabilità circa la penetrazione che avrà, per minuscola che sia, quando sarà là fuori...
Come artista di questo tempo, quale comportamento sociale ritiene di mantenere? Occorre esser profeti, carbonari, monaci, non allineati per non subire le logiche mercantili che premono per “competenze” e “efficienze” allo scopo di auto - legittimarsi, de-potenziando invece, di fatto, lo sviluppo di autonome e sincere ricerche individuali?
Occorre essere sé stessi. Il compito di un artista è la sincerità, è osservare con attenzione i nodi e le contraddizioni del tempo in cui vive e trovare la possibilità di offrire un altro sguardo. Questa è l’unica legittimazione che serve alla propria crescita e alla ricaduta sociale del proprio “fare”. Se hai bisogno di legittimazione esterna, c’è qualcosa di incompleto. Ma almeno non cercare una legittimazione in un posto dalla quale essa non può arrivare. Se la tua funzione è quella di istillare dubbi, prospettive differenti, provocare spostamenti lievi o profondi; e se vuoi farlo assumendone la responsabilità, facilmente sarai già non allineato. Probabilmente starai già compiendo un cammino rigoroso e monacale. Questo rigore non lo si trova soltanto nei percorsi non convenzionali. Personalmente conosco artisti che agiscono davvero bene in ambiti non carbonari per i quali nutro un grandissimo rispetto. L’autenticità non ha confini. Ho avuto modo di vedere una mostra molto esaustiva dei dipinti di Felice Casorati: non stiamo parlando di un rivoluzionario della pittura, ma stiamo parlando di un artista intero e consapevole, essenziale e straordinariamente ispirato. Casorati era sé stesso, credo abbia mantenuto questo contatto per lungo tempo.
Forse non possiamo dire la stessa cosa di un Basquiat, ad esempio, che amo e al quale nulla voglio togliere naturalmente. Ma in lui c’è anche molta energia sprecata per esempio...
E’ un percorso accidentato e intrigante allo stesso tempo, questo che facciamo.
Ritiene di doversi assumere delle responsabilità verso i fruitori della sua musica per una loro capacità di ascolto più evoluto e cosciente, o ha fiducia nella spontanea abilità individuale dell’audience di espandere il proprio orizzonte sensoriale ed estetico?
È una questione politica, sociologica e forse anche antropologica, molto complessa e che non manca di riservare sorprese. Ho curato per qualche tempo una serie di incontri di “invito all’ascolto musicale” presso un centro sociale. Proponevo ogni sera e per la durata di un paio d’ore diversi brani registrati che andavano dalla musica classica, l’opera, a quella popolare, al jazz, alla contemporanea e anche field recording. Ogni sera il titolo era rappresentato da concetti antipodali: Antichissimo- Modernissimo, Narrativo-Astratto, Profondità-Trasparenza etc. Il pubblico dei partecipanti variava ogni volta e le età andavano dai 12 agli 80 anni. Mi colpì moltissimo il grado di attenzione, di definizione dell’ascolto, la capacità di riconoscere dei più giovani e dei più vecchi. Nell’audience di età più centrale, l’attenzione era più “televisiva”, distratta, sommatoria, poco incline a un’analisi anche minima. Ecco, io penso che il rapporto da ricucire con l’audience sia particolarmente necessario in Italia per la fascia di età centrale. Tornare a suscitare delle domande, dei dubbi mi sembra particolarmente utile qui. Per farlo sembra necessario una specie di piccolo accompagnamento, talvolta. Questo, per motivi che sospetto politici e sociali, è meno frequente in altri paesi europei, dove in generale la curiosità è più attiva meno seduta, auto-indulgente, in sostanza pigra (divanizzata, dico io). Un’abitudine a programmazioni più varie, all’interno delle quali compaiano proposte diverse, aiuterebbe non poco. Un po’ di stretching mentale sarebbe senz’altro utile. Tuttavia sono complessivamente ottimista e credo che uno degli obiettivi più interessanti sia quello di portare questa musica nei luoghi dove non è spesso ascoltata. Questo è utile anche da questa parte del palco: sollecita una concentrazione e una messa in discussione circa le proprie pratiche comunicative. Ogni tanto mi viene suggerito di introdurre a parole un concerto, una performance: lo faccio volentieri, ma molto spesso introduco non a parole, ma con la musica stessa, attraverso una costruzione nella quale gli elementi musicali restino visibili ed individuabili per qualche tempo. Rendere più lentamente, come parlare con più calma. Questa è una cosa che mi intriga tantissimo, non semplicissima, ma straordinariamente stimolante...
Nell’ambito della musica improvvisata circola costantemente tra i suoi praticanti l’affermazione – e anche vanto – dell’ idea accogliente di “apertura”. Lei ritiene che questo si realizzi effettivamente ? In caso affermativo ritiene che questa riesca a superare la soglia del rapporto interpersonale “uno a uno” o, al grado massimo, di tante ristrette “cerchie” isolate le une dalle altre ?
Il rischio del cortile, intende? L’apertura di cui si parla è spesso poco più di una parola e la tentazione di circoscrivere un sicuro, auto-legittimante, rifugio è piuttosto diffusa. È necessario tornare ad alzare il livello del proprio pensiero anche riconoscendo che per un musicista la vita è molto dura oggi. Ci sono luoghi dove avere comunità artistiche aperte e curiose risulta più facile: mi manca molto il confronto con musicisti di area differente e anche di area contigua. In Italia la frammentazione è un problema che riguarda l’intero paese, non solo il mondo della musica.... Però anche qui, mi viene da esercitare un sano disincanto: pensare alto è una necessità. Un respiro più ampio è proprio salubre. Non si può pretendere che certe cose cambino immediatamente, ma si può fare il possibile per cercare un contatto con la piccola luce di ognuno. È un principio gnostico al quale sono particolarmente legato. La luce è sempre l’antidoto contro l’oscuro. Tuttavia all’oscuro mi piace sempre lasciare una chance... molto spesso giocare con le contraddizioni genera cose interessanti e positive. Quindi: non tanto l’apertura, quanto la sincerità della relazione mi sembra essere importante. La verità è sempre più importante della bellezza.
Un commento a questa affermazione di Paul Bley sul Tempo:"..I gave my metronome away when I was at Juilliard. I broke mine. They need to be smashed. Because breathing is not metronome. Breathing is circular. Up and down phrases, rushing through… The heartbeat is also not metrical. It’s PAH-BOOM, PAH-BOOM. And you can’t measure it exactly right. If you’re walking around the room, it’s definitely not metrical...This is the perfect time to wipe the blackboard clean and start with a fresh page.
PAH-BOOM è bellissimo e naturalmente amo questa affermazione.
Dopo aver cancellato la lavagna e, in certi casi, non avendo proprio considerato la lavagna, la pagina appare chiara, nuova, pronta per essere percorsa. A me capita di vedere che certi segni precedenti riemergono qua e là e il percorso diventa anche interessante per la profondità di certe radici.
In realtà la lavagna non è mai veramente pulita, ma è assolutamente vero che la mediazione antologizzante della teoria è un peso molto ingombrante. Alla parola “metronomo” oggi mi torna alla mente Ligeti: lui fa implodere la funzione stessa del metronomo sovrapponendone 100 con lievi de-sincronizzazioni. Un’operazione che è anche una metafora riuscitissima della modernità e della multi-versalità. Ecco una sublimazione di grande livello, nella quale le categorie coinvolte sono totali, da qualsiasi parte la si osservii, con la lavagna scritta e con quella pulita (o fatta di cancellazioni?).

Una delle etichette che nell'ultimo periodo ha presentato i progetti più stimolanti in ambito jazz-impro è certamente la Amirani Recods di Gianni Mimmo, sassofonista e artigiano, oltre che propulsore di una piccola realtà fatta di idee e progettualità. Gli abbiamo chiesto illustrarci alcuni dei lavori da lui pubblicati sia in veste di produttore che di musicista. Ne è scaturito un modo meno ellittico per approfondire il percorso di una piccola ma stimolante realtà.
In catalogo ci sono lavori che testimoniano una situazione consolidata e altri che testimoniano passaggi. Entrambi hanno eguale importanza per me, ma differente declinazione. Il primo album, il mio One Way Ticket, equivale per me a un riconoscermi, è un lavoro che svela e dice chiaro chi mi credo di essere. Ha una sorta di rispetto, una specie di severità che sento essere utile. Qui io giro una pagina, guardo meglio e capisco le prospettive. Questo è un disco nel quale è come se parlassi. È nato in un momento denso e duro, ma anche fertile. E' anche un lavoro sul silenzio. Questo è l'unico lavoro che assomma entrambe le caratteristiche che dicevo: testimonianza e passaggio.
Two's days/tuesdays è il duo con Angelo Contini e dice di una consolidata prassi di scombinare, di come stare su una lama affilata sia una pratica che regala sempre il meglio. Con Angelo è una gioia suonare, è materia concreta e plasmabile, è ficcarsi in certi vicoli bui e trovare all'improvviso il modo d'uscirne, è lavorare con poco e bene. Dal vivo questo duo scolpisce la luce, ascoltarlo è sempre come vedere la musica.
Bespoken è un lavoro che viene da una lunga, strana e proficua indagine. Incontrare Lorenzo Dal Ri è stato per me una scuola. Ho letteralmente cambiato il modo di ascoltare il suono grazie a questo ragazzo. Questo cd continua ad essere impiegato in ambientazioni, performance di danza, gallerie d'arte, luoghi. È una narrazione che potrei ascoltare per ore e trovare sempre una parte che chiama ad uno sguardo nuovo. Lavorare con il trattamento elettronico, il field recording è per me come avere un altro sé, il mio saxofonismo ha trovato una strada purissima qui. Non c'è idiomatismo. Era impossibile non metterlo su cd.
Samsingen è la testimonianza di una relazione, dell'incontro fra persone prima ancora che fra musicisti, del desiderio e della possibilità di abitare una distanza culturale in modo profondo e non percorrendo la via di un semplice accostamento. È un gruppo di giovani musicisti che mettono in scena questo incrocio, uno spostamento, una ricollocamento del testo (sono testi arcaici in lingua e dialetto svedese) in un ambito quasi contemporaneo. Ne esce una specie di narrazione magica, ma non esotica, scandita dalla voce di Anna Kajsa Holmerg, Luca Serrapiglio (clarinetto basso), Andrea Serrapiglio (cello e lo-fi devices), Nicola Guazzaloca (vibes e accordeon). Quando l'ho ascoltato ho compreso che era la musica ad indagare questa relazione, che c'era un'appartenenza alla musica e che tutti ne erano stati trasformati. È stato un punto di partenza: mastering, grafica, ma soprattutto motivazione concettuale sono stati a lungo indagati e anche testimoniati dal lavoro di remix di un brano affidato a Lorenzo Dal Ri, che ha curato il mastering creativo e sobrio di tutto il lavoro. È una produzione nella quale ho fatto davvero il produttore.
Kursk_Truth in the End è un dvd nel quale ho speso molto tempo. È un lavoro al quale tengo in modo particolare per molte ragioni. La musica è senza dubbio l'asse portante dell'intero progetto. Abbiamo avuto la grande opportunità di suonare e di registrare in questa chiesa sconsacrata millenaria sfruttandone possibilità dinamiche, sottigliezze timbriche, riverberi naturali. Xabier Iriondo e Lorenzo Dal Ri hanno dislocato alcuni microfoni estremamente raffinati in differenti parti della chiesa, così da poter catturare ogni effetto naturale proveniente dai nostri strumenti. In effetti è stato un filmare il suono mio e del trombone di Angelo Contini. Così certi suoni gravi sembravano venire da una distante profondità, tutta la performance è stata estremamente intensa, gli effetti dinamici molto thrilling e tutte le persone coinvolte hanno avvertito una meravigliosa vibrazione. L'elaborazione elettronica e il trattamento del suono curato da Xabier Iriondo ha suggerito strane e stranianti possibilità d'intonazione.
Ogni aspetto della tragedia del Kursk è stato così a fondo indagato dai media: da una parte abbiamo una massa di parole, di schemi tecnici, verità ufficiali,versioni differenti e supposti misteri. Dall'altra la nostra interpretazione della tragedia: ciò che possiamo pensare intorno alla impossibilità di riemergere per un sottomarino di quella portata, più di 100 persone di un equipaggio. Possiamo certamente avvertire la grande forza metaforica, lo sconosciuto, l'invisibile, l'umana piccolezza e l'eroismo scritto in un piccolo biglietto ritrovato nella tasca di un tenente di vascello lucido nel momento della morte. Elda Papa per esempio immaginava i corpi dell'equipaggio come visti in trasparenza, un mare di visi oltre il tempo, oltre il mare come una specie di bandiera sommersa. L'aderenza lo stretto spazio condiviso e gli odori del sottomarino.
Agua Mimmo diceva che lui poteva solo far riferimento a frammenti di vecchi film. Era anche affascinato dall'aspetto tecnico dalla perfezione costruttiva messa in crisi dall'errore umano.
Così ha pensato di filmare anche devices e comandi dei sottomarini. Terminare l'editing della parte immagini è stato veramente difficile perché la musica era lo storyboard. Ma credo che le immagini possano arrivare ad assumere la forza dei poemi omerici trasportata ai nostri tempi.
A Watched Pot è un trio che amo perchè è seminale, condiviso, smagliante come un cartoon. È come se sapessi che incontrare e fare campo con altri viandanti dei quali avevo colto una certa luce nello sguardo, potesse dare un cambio di prospettiva utile a tutti. Infatti solitamente i musicisti coinvolti in questo trio non suonano così nei rispettivi progetti. Il lavoro è totalmente improvvisato, con qualche mia indicazione generica circa la necessità di stare scomodi, della utilità di uno smarrimento. È un lavoro di un lirismo sbilenco e raffinato insieme. Francesco Cusa è un distillatore qui e Andrea Serrapiglio ribalta i piani armonici con un piglio a volte romantico. È come un susseguirsi di stanze, ognuna con strane finestre oblique.
Dare voce al lavoro di Claudio Lugo che con Esther Lamneck ha interpretato e "suonato" le strade di Genova, i suoi docks, i suoi muri salmastri. Genoa Sound Cards è speciale, è musica "nella" vita di una città. È una musica suonata "dalla" città. Poi due timbri sonori che si sentono provenire e andare, come navi. Bellissimo.
Sono tornato ancora a fare il produttore con Wanderung di NovoTono, questo duo contemporaneo dei fratelli Adalberto e Andrea Ferrari. Quando ho sentito il loro demo ho trovato un'idea compositiva molto insolita. La timbrica estesa della famiglia dei clarinetti, il lavoro sulle pause e, per me fondamentale, sulle dinamiche sono stati i motivi primi della fascinazione. Poi ho scoperto una motivazione concettuale finissima intorno all'idea del "wanderer" (il viandante nella sua accezione romantica di adesione, concidenza appartenenza alla strada), che stava intorno alla modalità di composizione. Qui ho voluto curare in modo particolare la resa sonora e ho sviluppato anche il tema del concept con cura sulla scelta grafica del cd.
Cosa ti aspetti da un progetto come quello di Amirani? Si può ancora fare cultura attraverso un'etichetta discografica e, per ultimo, dove speri che arrivi la tua musica?
Amirani mi dà un privilegio, una postazione per osservare. Mi aspetto che continui ad essere interessante indagare e provocare i musicisti e le fresche intelligenze. Amirani non vuole enciclopedia, vuole lavori urgenti e sentiti e discussi, in un certo senso. Mi attendo che divenga una specie di luogo nel quale chi ha avuto la ventura di entrare si senta parte di un processo, di una possibile trasformazione. Desidero e voglio che chi passa da certi sentieri ne ricordi i segni, gli incontri e le possibilità.
Qualche settimana fa mi è capitato di riascoltare la voce di Pasolini, il peso profetico delle parole, ma soprattutto mi ha di nuovo colpito il coraggio della possibilità di parlare. Amirani può essere un posto fatto per dirsi il perché del proprio fare musica. Un posto di domande, intere e profonde.
Dopo questi due primi anni di vita della label ho forse insistito troppo su questa impostazione, ma i risultati sono buoni e i musicisti che incontro non dicono o fanno cose banali. Pensano a cosa proporre e soprattutto aprono una considerazione sul proprio far musica. Beh, anche se in piccola misura, credo che questo sia fare cultura. La label è solo un pretesto ma, grazie a questo stesso pretesto, cose si agitano.
Spero che la mia musica arrivi a persone e a luoghi in modo non rassicurante. Spero sempre che faccia sorgere qualche dubbio e qualche domanda, attenzione. Spero in una funzione un po' sbilanciante. È meravigliosa la gratificazione, la soddisfazione di veder riconosciuti i propri sforzi. Sensibilità accese, stima. Tutto questo è straordinario regalo. Ma io credo che utile sia sentire che qualcosa si muove, che un pubblico venga toccato nel profondo. Un po' meno sicurezza e più apertura.
Sai, anche il pubblico dell'"avanguardia" (so che sorridi anche tu a questa parola) contemporanea è molto convenzionale. Prova a suonare un solo, improvvisa e prova ad indugiare in una melodia scaturita dal percorso sonoro. Bene, alla fine qualcuno te lo rinfaccerà, come fosse un cedimento. Anche lì avrai provocato uno spostamento, uno smarrimento. Sono momenti di grande importanza comunicativa.
Per finire cosa ne pensi dell'attuale scena jazzistica?
Io non vedo una scena jazzistica, ad essere precisi non vedo scene. Vedo individui. Non sono tempi buoni. Ma ci sono brillanti intenzioni e poche connessioni, se naturalmente escludiamo i clan autoreferenziali. Il jazz è davvero jazz se diviene. È una musica che diviene, trova la sua ragione nel divenire. Non credo si debba celebrarlo, nel momento che lo si fa, e lo si fa in continuazione, lo si uccide. Vedo ripetizione, pattern, modi. Non so, sono un po' sfiduciato circa questa coazione a ripetere.
Gianni Mimmo è stata un po’ la sorpresa dello scorso anno, quando alcuni suoi CD, pubblicati dalla propria etichetta indipendente Amirani Records, lo hanno rivelato agli appassionati, colpiti dal suono penetrante ed espressivo del suo sax soprano, palesemente memore della lezione di Steve Lacy. Incuriositi dall’estrema maturità messa in luce in quei lavori e dall’incapacità di reperire alcun tipo di informazione sul loro autore, siamo andati a cercarlo e abbiamo fatto altre sorprendenti scoperte, che hanno svelato una personalità artistica e umana molto interessante e originale.
Abbiamo raggiunto Gianni Mimmo a Pavia, la sua città, nel laboratorio di riparazione di strumenti a fiato, il “lavoro” che gli permette da anni di dedicarsi, poi, alla musica, senza l’assillo del mercato. Attiguo al laboratorio ha un piccolo studio, dal quale passano realtà musicali in cerca di realizzazione e lui stesso si occupa della produzione della sua etichetta che, oltre ai tre CD nei quali egli stesso è all’opera, ha pubblicato anche un lavoro di canzoni tradizionali svedesi affrontati dall’obliquo quartetto contemporaneo Samsingen, con la cantante Anna-Kajsa Holmberg.
È la solita, difficile situazione: non si vive di sola musica…
Sì, però va anche detto che in un posto come questo non mancano le connessioni tra ambiti musicali diversi, spesso anche molto lontani, e questo è il vero guadagno del praticare musiche “trasversali”: l’incontro con realtà diverse e molto stimolanti - come la contemporanea, il post-rock - tutte però con le “antenne dritte” verso un certo sentire e sempre con molto rispetto verso le altre diversità. Cosa che, anche alla mia veneranda età, è molto importante.
Veneranda età… Quanti anni hai? E qual è la tua formazione musicale?
Sono del ’57, quindi ormai arrivato ai cinquanta. Sono completamente autodidatta, anche se ho iniziato a dedicarmi al sassofono fin dall’età di quattordici anni, ma devo dire che l’ho fatto sempre con uno spirito di curiosità e con la “testa dura”, con la convinzione, cioè, di non voler fare le cose così come “devono” essere fatte.
La cosa che mi ha sempre colpito di più e alla quale mi sono maggiormente dedicato è il suono. Il primo disco di jazz che ho ascoltato fu l’unico di Rhythm & Blues che abbia mai fatto Archie Shepp (si chiamava Kwanza). Mi comprai un tenore, con risultati terrificanti… Poi ho cominciato a studiare da solo, più che altro seguendo le forme del free. Credo di aver visto un numero impressionante di concerti dell’Art Ensemble of Chicago, quando ancora la formazione non era neppure propriamente quella (ad esempio, ricordo un concerto a Parigi del Roscoe Mitchell Sextet). Ho sentito prima il free del bop, sempre attratto dal suono. Recentemente, durante un trasloco, ho ritrovato una cassetta del 1969 - ero piccolissimo! - dove avevo registrato i rumori della ferrovia vicino a casa, che poi avevo rimontato con i suoni della radio! Mi è sempre piaciuto “smontare e rimontare” i suoni.
Dopo il tenore, ho avuto una lunga passione per l’alto e il baritono, ma al primo concerto di Lacy a cui ho assistito sono andato letteralmente per terra. Fu a Pavia e Lacy era assieme a un poeta bolognese oggi scomparso, Adriano Spatola, che lavorava molto sulle cellule fonetiche e si sposava bene con il linguaggio lacyano. Da lì ho iniziato a scrivere a Lacy e pian piano ho attinto da lui un atteggiamento verso la musica che non riguarda tanto l’“essere sassofonista”, quanto l’“essere monaco”! Gli insegnamenti che dava Lacy, o almeno quelli che io da lui ho ricevuto, erano relativi a come trovare una propria via per “picchiarci dentro duro”… Una strada faticosa, ma è quella che io ho sentito e praticato di più.
Certo, poi ho avuto molte collaborazioni e varie “cotte”, in ambito sia jazz che classico. Questo perché sono sempre stato alla ricerca di un linguaggio non strettamente “musicale”, ma più in generale “artistico”, multiforme. Nel jazz c’è spesso una certa uniformità idiomatica; ad esempio, si ascoltano un sacco di musicisti dalle grandi qualità tecniche, che fanno cose fantastiche, e tuttavia impersonali, appiattite, prive di una suggestione che porti aldilà dell’ambito idiomatico ristretto. Direi anzi che oggi siamo in un momento particolare, pieno di promesse e ciononostante non pienamente felice.
Dicevi però poco fa che trovi maggiori riscontri oggi che non nel passato. Come spieghi questo contrasto?
Semplicemente perché questi riscontri li trovo più fuori del jazz che non al suo interno. Non che anche in esso manchino persone attente o artisti meravigliosi; però i contatti più stimolanti mi vengono dal suo esterno. Quel che mi interessa è ciò che è “vero”, a prescindere dalla connotazione che può avere. Non solo: direi che quando suono io non voglio “stare bene”, non mi interessa; voglio andare più a fondo, e questa ricerca coincide con una sorta di “scomodità”, in primo luogo per me, poi anche per chi ascolta.
Oggi si parla spesso di “contaminazioni”, parola un po’ inquietante, dato che si è spostata con troppa facilità dall’ambito medico a quello musicale… Io preferirei parlare di “accostamenti”. E accostare non significa necessariamente comunicare… Tenendo anche presente che quello che conta negli accostamenti non è tanto il realizzarli, ma cosa hanno da dirsi tra loro le cose che vengono accostate…
… e cosa hanno da dire a chi le osserva/ascolta, aggiungerei! Capisco e condivido quel che dici, dato che io - che professionalmente faccio il filosofo - nei miei seminari faccio ascoltare selezioni musicali molto diverse tra loro, e anche ciascuna ricca di “accostamenti” al proprio interno (un esempio per tutti, il duo di Sainkho Namchylak e Ned Rothemberg), proprio per far scoprire a chi ascolta cosa questi accostamenti si dicono e dicono loro. Si tratta per me di ampliare la comprensione degli individui. Mi sembra di capire che lo sia anche per te, iniziando dall’ampliamento del tuo stesso habitat musicale. Mi sbaglio?
No, sono d’accordo. Recentemente ho fatto un esperimento tra musica e video, con musicisti che ruotavano nelle varie serate. Una cosa in parte interessante, in parte meno. Ma la cosa che mi ha veramente fatto imbestialire è che si avvertiva nettamente come spesso l’improvvisazione diventi un luogo estremamente “comodo”, un posto tranquillo nel quale non rischiare nulla. Forse aveva ragione Cage a dire che l’improvvisazione vera non esiste! Invece, una cosa che mi ha insegnato Lacy è che un musicista deve assumere su di sé almeno una parte di responsabilità, e che questo vuol dire non ridursi ad un lavoro “tranquillo”, tutto basato su pattern rodati.
Personalmente mi esprimerei con le parole di un filosofo, Ugo di S. Vittore, il quale diceva che l’uomo affezionato al luogo natale è un tenero principiante, quello che si sente a casa dovunque è già più maturo, ma perfetto è colui che si sente sempre straniero in ogni luogo.
Molto bello e molto significativo! Come tutte le citazioni, ben aldilà di quanto può apparire ad una prima lettura. Ma dato che siamo sul tema dell’estraneità, come si spiega che di te non si sapesse nulla fino all’anno scorso?
Beh, come dicevo prima, perché ho fatto troppo il monaco! Ho fatto montagne di esperienze e anche di demo, cercando di trarre fuori dalle esperienze il meglio, ma fino all’anno scorso non avevo mai pubblicato niente. Ho suonato con Lacy, ma sempre in ambiti didattici, con musicisti dell’area dell’Italian Instabile Orchestra, ho fatto cose… ma non ho mai fatto niente per “comparire”. Per caso mi sono incrociato di recente con dei magnifici trentenni dell’ambito rock, che si sono messi a produrre dischi (la Wallace Record). Alcuni di loro un bel giorno mi hanno detto: “ma non si spiega perché ancora tu non abbia fatto un’antologia di tutto quello che hai fatto girare in modo clandestino!” Mi hanno stimolato e così, pian piano, mi sono deciso a pubblicare qualcosa.
Poi c’è un’altra ragione, ed è il fatto che ho lavorato molto più in ambito teatrale, legando musica e testo, che non sul piano strettamente jazzistico.
In effetti, ho avuto notizia recentemente - e da tutt’altro canale - dei tuoi spettacoli con la poetessa Livia Candiani.
Sì, è uno degli spettacoli che anche adesso sto portando in giro, quando capita l’occasione, ad esempio l’estate scorsa al festival di Colle Val D’Elsa e a settembre al festival Gezziamoci di Matera. È un lavoro che dobbiamo registrare, molto bello, anche perché Livia è una persona “magica”.
Anche lavori di questo genere ti avvicinano alla personalità di Lacy.
Sì, è vero, verissimo. In effetti una della cose che mi ha maggiormente colpito di Lacy, molti anni orsono, fu il suo lavoro sulle poesie russe. Io sono molto affezionato ad alcuni poeti russi e quando vidi che Lacy aveva fatto quel lavoro me ne interessai subito e rimasi molto impressionato da quel trio, in particolare da un pianista assolutamente contemporaneo come Frederic Rzewski. Perché il rapporto che Lacy riusciva a stabilire in quelle che chiamava “art songs” tra l’incedere sillabico della musica e l’incedere sillabico della parola era quello che sentivo a me più vicino. Così, anch’io iniziai a indagare questo campo, lavorandoci molto, sia su testi miei che di altri. Ne venne fuori un lavoro che s’intitolava Empty Cups and Pieces, una scelta di aforismi e frasi che andavano da Cage a Rama-Krishna. Certo, questa è una cosa che Lacy mi ha trasmesso. Ne abbiamo anche parlato assieme: a suo parere si tratterebbe di una cosa un po’ ebraica, che deriva dalla cantillazione ebraica. Ho fatto alcune ricerche e ho scoperto che i primi lavori di quella che viene denominata “speech melody”, e che è stata sviluppata soprattutto da Steve Reich, vengono da Schoemberg, che per primo ha cominciato a indagare quella forma di melodia che si produce quando si parla.
“Quando suono io non voglio “stare bene”, non mi interessa; voglio andare più a fondo, e questa ricerca coincide con una sorta di “scomodità”...”
Steve Reich ha pubblicato un CD - di quelli che per me sono da “cinque stelle assolute” - The Cave, che è tutto basato sulla “musica delle interviste”, ovvero sulla trascrizione della melodia del parlato. Lui poi ci lavora sopra in un modo molto “da Steve Reich”, ma che ha un valore concettuale molto forte, perché parte indagando un concetto, quello della caverna, e tu che sei un filosofo sai che se lo leggiamo in un modo andiamo da qualche parte - verso Platone - se lo interpretiamo in un altro modo andiamo da tutt’altra parte - verso Abramo - e che se poi ci spingiamo oltre abbiamo conseguenze ancora diverse - per esempio, negli States se dici “Abramo” tutti pensano ad Abramo Lincoln… C’è questa bellissima migranza dei concetti sulla quale Reich raccoglie il materiale delle interviste attraverso un lavoro sui timbri, tirandone fuori cose stupende! Ecco, tutto questo mi affascina molto, ma certo l’origine del mio interesse parte da Lacy.
Veniamo ai dischi che hai pubblicato recentemente. Anch’essi hanno ispirazione decisamente lacyana, anzi, direi che è stato per me stupefacente ascoltarli e trovarvi dentro la più nitida voce lacyana che mi fosse mai capitato di udire. E questo senza che i tuoi lavori siano solo un’operazione calligrafica - comunque sempre difficile, perché la voce e il timbro di Lacy sono incomparabili. Tu a mio parere hai fatto un lavoro molto rispettoso, però anche tuo proprio, quasi tu fossi un epigono “degno”.
Ti ringrazio, perché davvero quel che dici tocca delle corde che stavano dentro l’intenzione della mia operazione. Il primo dei CD che ho fatto uscire lo scorso anno, One Way Ticket, per solo soprano, è in realtà un’operazione sui padri. Sulla copertina c’è la foto di mio padre, ritratto a Sidney più o meno all’età che ho io adesso. Partì per l’Australia per starci quindici giorni, tornò invece tre mesi dopo, con mia madre in fibrillazione perché non capiva cosa stesse facendoci. La realtà è che mio babbo - con il quale quand’era in vita ho avuto soprattutto scontri i quali, adesso che non c’è più, appaiono meravigliosi - in quella foto ha la faccia di un protagonista di un film di John Cassavetes; è forse la foto più ottimista che ho di lui. Io ero in sala d’incisione nei giorni in cui lui stava andandosene e, nel mio sentire, le improvvisazioni mi sono apparse impregnate da quest’idea del “transito”, del biglietto ad una sola corsa - come recita il titolo - senza che si capisse bene se si trattasse di una partenza o di un ritorno...
Al tempo stesso, mi affascinava l’idea delle cose che si ricordano nei momenti “forti”, com’era quello in cui registrai e com’era stato il viaggio di mio padre a Sidney. Nella mia immaginazione, le cose che si ricordano sono quelle “minori” (come la moquette dell’albergo, o un corridoio, per intendersi), che però sono il “colore di fondo” di una situazione.
Ma in questo disco compaiono anche altri “padri”: naturalmente Steve Lacy, ma anche Thelonious Monk e Charles Mingus. E questo riferimento ai padri è anche un capriccio, che contiene al tempo stesso un rispetto e un ‘affanculo: il rispetto sta nelle cose che ho detto, nell’omaggio che faccio a queste figure; l‘affanculo invece sta nel fatto che in questo disco, secondo me, rispetto a tutte le altre cose che ho fatto in passato c’è molto più Gianni Mimmo. E questo perché riesco a mettere dentro, adiacenti ma nello stesso ambito, Webern e Monk, una poesia di Eliot e una di Scialoja. Queste cose viaggiano insieme e sono fatte “di testa mia”: sono convinto che Lacy mi sgriderebbe almeno in tre o quattro passaggi, mi direbbe “ma sei sicuro che è proprio la tua voce?”, mentre Webern mi prenderebbe proprio a calci per come ho fatto il “Die Sonne”! Ma sicuramente è come lo volevo fare io…
Con lo straordinario senso di autostima che ho non potevo fare altro! Forse, c’è solo un pezzo di troppo, ecco tutto.
Perché? Spiegati meglio.
Ci sono due brani piuttosto vicini, “Highway Tale” e “Unsaid e.”, due brani pressoché equivalenti e che non aggiungono molto l’uno all’altro. Come si dice, qui sono “andato un po’ lungo”, mi sono fatto prendere un po’ la mano.
E il secondo CD, Two’s Days / Tuesdays? Anche questo è molto lacyano, con un duo tra soprano e trombone.
Certo. Tra l’altro è registrato prima del solo, anche se è uscito un po’ più tardi. Questo è un lavoro “di specchio” con Angelo Contini, con il quale mi trovo molto bene, perché è una persona semplice, con il cuore gentile, molto per bene, ma che ha anche un suono molto “animale”. Ci siamo trovati subito bene e lavoriamo ancora insieme, anzi abbiamo un progetto con elettronica e immagini, sul tema del Kursk, il sottomarino nucleare russo che finì in tragedia.
Una storia che ha una morale epica straordinaria, perché tutta la soluzione della vicenda sta in un biglietto ritrovato nelle mani di un tenente che si era chiuso all’interno dell’ultimo compartimento stagno e solo attraverso il quale si è venuti a sapere la verità su quel che era accaduto - che è veramente una cosa omerica! Ci abbiamo lavorato sopra, e ne sta venendo fuori qualcosa di molto diverso. Sarà un DVD con immagini di una fotografa straordinaria e nascosta come Elda Papa, parti filmate ed editing curate da mio figlio Agua Mimmo; con la musica mia, di Angelo Contini e di quel mago del suono che è Xabier Iriondo. Si tratta di un’immaginazione e non di cronaca.
I tempi di Omero sono andati. Lui assommava nel poema fatti ed archetipi. La fruizione era benedetta, secondo me. Oggi la cronaca dettagliata, analitica, indagatoria, sviscera tutto ciò che avviene. Pensa a CNN o BBC. Qui ho preferito lavorare sull’immaginazione delle varie fasi di quel fatto. Ma avremo modo di parlarne ancora, vedrai.
Così come diverso è il terzo CD uscito, Bespoken, dove l’indagine è sulla narrazione dei suoni quotidiani. È un lavoro elettro-acustico che, grazie alla collaborazione con Lorenzo Dal Ri e alla sua perizia nel live electronics, nei campionamenti e nel field recording, ha dato un risultato speciale. È una specie di soundscape e anche una bella avventura per un sassofonista.
Dicevi di essere stato attratto fin dall’inizio dal suono. L’approdo al soprano e anche dalle ispirazioni lacyane deriva principalmente da questo, immagino?
Si, deriva da questo. Il soprano è uno strumento ingrato, molto ingrato: è il più imperfetto dei sassofoni. Devi odiarlo di continuo, è impossibile, non funziona, ha molte parti imprecise. Ho fatto anche delle ricerche fisiche in proposito: ogni strumento ha una zona morta, i fiati in particolare e i sassofoni, per la forma conica, ancor di più. Però è chiaro che nel soprano queste imperfezioni sono decuplicate! Inoltre ha un timbro che a seconda dei registri trova, come dire, un modo solo per venir fuori, e bisogna studiare forse un po’ troppo per ottenerne dei risultati, così che si finisce per assumere una forma un po’ maniacale di elaborazione del suono che ha più a che fare con la scultura che non con la musica.
In questo senso credo che per chi affronti il soprano solo sia molto difficile non venire da Lacy. Al mondo ci sono pochissimi sopranisti: ci sono moltissimi sassofonisti che suonano anche il soprano, ma di sopranisti ce ne sono pochissimi.
Vuoi dire puri sopranisti.
Esatto. Lo stesso Evan Parker, che è un musicista che adoro perché ha sviluppato un linguaggio assolutamente personale, conosce il soprano come le proprie tasche e ha un controllo della respirazione come nessun altro sul pianeta, viene però dal tenore. Ci sono tre vie per il soprano moderno - perché se andiamo più in là troviamo Bechet, che però ci arrivava dal clarinetto e da un suono comunque del tutto particolare - e cioè la via di Steve Lacy, quella di Evan Parker e quella di Lol Coxhill. Non ce ne sono altre. Forse Bruce Ackley, il sopranista del Rova Saxophone Quartet, che è stupendo e ha un timbro meraviglioso, ma personalmente non l’ho mai sentito da solo. In questo caso suona “anche” il tenore…
Io sono per i tagli estremi, così recentemente ho registrato con il sassofono basso - e qui viene fuori un po’ l’anima di Roscoe Mitchell. In realtà, per ragioni di lavoro, io suono tutti i giorni ogni tipo di sassofono; però è ormai tanto e tanto tempo, circa quindici anni, che sul palco non porto che il soprano. Ma resta il fatto che è un sassofono difficile. Anche Lacy diceva che non puoi dominarlo: puoi farlo per un po’, ma poi riprende il sopravvento, perché devi lavorare più degli altri sassofoni sull’imboccatura, e proprio per questo ti offre grandi potenzialità sulle tecniche alternative, sui multiphonics, però i particolari sui quali devi concentrarti sono molto minuti e ti costringono a un lavoro estremamente impegnativo sugli armonici.
Da dilettante dello strumento, sono molto colpito dalla tua immagine che paragona il lavoro sul suono a quello dello scultore. Pur senza essere un professionista, ricordo che nei momenti in cui mi sono impegnato di più avevo anch’io una vera fissazione sul suono: cambiavo bocchini, ance, tipo di imboccatura…
Certo! Io ho passato periodi in cui mi veniva da piangere! C’è stato un periodo in cui studiavo solo gli armonici. Avevo uno stage con Lacy a Bologna e volevo fare un figurone. Prima di andarci, per tre mesi tutti i giorni andavo dalle 18,00 alle 20,00 in un bosco e facevo due ore di studio degli armonici, costruendoli sulla fondamentale…
Gli uccelli rispondevano e io vedevo cose… Era un santo rimbambimento, ma pur sempre rimbambimento, avevo spostato tutta la mia attenzione solo sugli armonici! E quando tornavo a casa mi veniva davvero da piangere. Mi chiedevo: ma come hai fatto a ridurti così? Che accidenti ti è preso? Poi andai a Bologna e Lacy fece un pezzo con gli armonici e mi chiamò per un solo. Durante l’intervallo gli dissi: “guarda Steve che io so fare gli armonici benissimo. Finita la storia che li sai fare solo tu!” E glieli feci sentire. Lui mi fece i complimenti, me ne fece sentire altri, con altre posizioni - anche perché lui era veramente speciale: se lo sollecitavi tirava fuori sempre nuove cose e sempre più magiche, più belle, più nuove, di un mondo che non conoscevi! E che forse non conosceva neppure lui, ma esplorava sul momento con te... E quindi ridemmo di questa mia fissazione, perché continuavo a chiedergli cosa potessi fare, ora, per il suono...
Ricordo che mi fece una lezione sui sovracuti, che si basava sull’idea che i sovracuti sono in un corridoio, nel quale devi trovare le porte, cercandole là dove non si vedono. Poi ricordo che mi disse: gli armonici li sai fare piuttosto bene, i sovracuti devi cercarli, per entrambi usava la parola “fishing”, pescare. Poi mi ha lasciato con una frase che non dimentico: “now you can learn from the duck” - adesso puoi imparare dall’anatra. Io non avevo mica capito! Finché, quando lui se ne stava andando, mi resi conto che parlavamo dell’attacco della nota e che Lacy, nell’attacco delle note, spesso emetteva un respiro prima di fare la nota, che è esattamente quello che fa l’anatra! Ne ho parlato con uno specialista e mi ha spiegato che l’anatra appena prima di emettere il suono manda fuori un po’ d’aria dalle narici (hai presente Paperino?), fa uno spostamento in avanti che favorisce l’emissione. Però la frase di Lacy, “imparare dall’anatra”, senz’altra indicazione, ti dà la dimensione della follia che sta nella ricerca ossessiva del suono al soprano!
Tra i sassofonisti italiani chi apprezzi di più?
È difficile dire, anche perché non sono molti quelli che sento vicini al mio modo di suonare. Recentemente ho avuto modo di sentire dei lavori di Luciano Caruso, che ho apprezzato per il lavoro sul timbro. Poi c’è uno straniero che vive a Bologna, Tim Trevor Briscoe, che è straordinario sull’alto e sul clarinetto. Nessuno suona così. Ha qualcosa di sgusciante, come era Julius Hemphill. Roberto Ottaviano è un superbo sopranista specie qualche anno fa. Ma apprezzo sinceramente anche musicisti che sono molto lontani da me, come Claudio Fasoli, che ha un suono scuro e maschile, o Tino Tracanna, che usa molto la testa. Mi piace il Lost Cloud Quartet che lavora con Sciarrino e rende il contemporaneo fresco e flessibile. Il musicista-strumentista italiano che preferisco però è un contrabbassista: Stefano Scodanibbio. Beh, lui ha una gran classe e ha il potere di abitare completamente ciò che fa.
Anche perché, in fondo, ho capito che le cose che mi piacciono non sono necessariamente quelle che si avvicinano al mio modo di interpretare la musica, ma quelle che contengono qualcosa di vero. Espresso in parole può sembrare un po’ insoddisfacente, ma di fatto quando sento che c’è del “vero”, allora funziona - almeno per me.
Che cosa tiene insieme "One Way Ticket" e "Samsingen", il dialogo materico tra un trombone e un sax soprano e le liquide atmosfere postmoderne di Bespoken?
La relazione, un dialogo lungo fatto con le antenne dritte. Non c'è esercizio in questi lavori, non c'è enciclopedia. Ci sono i linguaggi nei quali si è abituati a comunicare, ma, messi in relazione, accettano di modificarsi. Ne esce una sublimazione buona, una santa confusione. Samsingen, ad esempio, è un prodotto sincero, quasi instabile nella sua emozione, la musica trema da quanto è vera. È speciale perché non si compie, lascia sospesi. In Tuesdays è lo scontro fra due suoni: un timbro ruvido, viscerale, quello del trombone di Angelo Contini, e uno mentale, tutto dinamiche e punte aguzze, del soprano.
Eclettismo? parola spinosa... Amirani Records è eclettica?
E’ spinosa perché è connessa con Versatilità, Compatibilità. In ambito artistico non mi piace, perché penso che sia una specie di capacità pratica a fare tutto, ma operando una sintesi superficiale fra le parti. L’eclettico non indaga, fa. No, Amirani Records non è eclettica. Per ogni singolo prodotto impiega molto tempo, investigando le linee che l’hanno generato. Il fattore scatenante è la sincerità. Sono attratto da originalità vere, anche se distanti.
Perchè Amirani?
La storia alla quale sono affezionato è quella dell’eroe mitologico di area Caucasica. Amirani è il personaggio di una saga popolare e mitica, le cui gesta sono ancora rappresentate nei teatri di burattini in Armenia, Georgia, Iran occidentale, Adzerbaidjan, ecc…. È un titano, dotato di una forza erculea, combatte contro mostri, conosce i segreti della lavorazione dei metalli. È amico delle popolazione e dona loro il segreto del metallo, per questo gli dei, per la sua generosità lo incatenano sulle fredde cime dell’Elbruz. Il suo cane lecca le catene, le catene stanno per spezzarsi, ma a quel punto gli dei comandano a tutti i fabbri del Caucaso di picchiare insieme col martello sull’incudine. Con quel grande suono le catene si riformano. È tragico, buffo ed eroico allo stesso tempo.
Gianni Mimmo: artigiano, musicista, studioso, compositore, "produttore"...
Tutto depone a favore della presenza di un enorme ego. È così. Ma anche non mi riesce di fare diversamente. Prima mi piace mettere le mani sulle cose, poi le cose cominciano a farmi domande e da questo rapporto nasce il lavoro. Suono il sax da quando ero ragazzo, poi ho voluto smontarlo, poi ho dovuto rimontarlo e questo mi ha fatto studiare e pensare. Il detto zen dice che la meditazione consiste nell’andare al pozzo a prendere l’acqua, che tutto sta lì. E così la mia meditazione è il fare. Ma riesco bene anche nel non fare niente. Verrà il tempo per stare seduti sul muretto a dondolare le gambe. Il lavoro mi ha dato modo di conoscere una quantità di musicisti nella loro parte più concreta, fisica. Le loro mani sullo strumento, i trucchi, certe manie, da tutti ho imparato qualcosa. Ma soprattutto ad ascoltare. Ora ho l’impressione di vederlo il suono. Tutto il lavoro sul timbro, sulla qualità, sui parziali. È stato più facile avendoci a che fare dal punto di vista manuale. L’interessante, quando si parla di suono, è che si usano metafore, la comunicazione è raffinatissima, filosofica, si parla di colore, di scultura, di vuoto, di pieno. E’ una scuola. La composizione per me è togliere, davvero sento la cosa come fosse scultura. Lavorare con i testi è speciale, ma richiede un tempo lungo. Emergono dopo anni le idee, come ci fosse un tempo perché le parole divengano chiare e quasi sempre si portano addosso il loro suono. Non è guidare il processo, è appartenervi. Presto riprenderò alcune cose scritte tempo fa attorno a testi di Bacon, Stevenson, di nuovo Beckett e sulle cellule fonetiche della lingua italiana...
Penso che l'esperienza dell'etichetta Ti abbia messo in contatto con realtà trasversali, al di fuori del jazz e della musica contemporanea, ambienti che forse ti erano più noti sin dall'inizio. Che cosa hai trovato di nuovo, insospettabile, e che cosa hai trovato di "immutabile"?
Ho trovato una socialità che credevo smarrita, molta preparazione sulla tecnica elettronica, una conoscenza trasversale sulla musica contemporanea e jazz. Questo onestamente non me lo aspettavo dal post rock. Trovare poco più che ventenni che conoscono Cage o Xenakis o Coltrane così a fondo, con una curiosità di ricerca sulle possibilità strumentali viva e continua, beh, questo è grande! Guarda i cataloghi di certe piccole label, ci sono mille derivazione e derive: noise e ballerini contemporanei a proprio agio su Sciarrino o su chitarre di sangue… Ne esce una musica più possibile, non più solo bidimensionale. È la rete che vibra nelle sue mille giunzioni.
Gianni Mimmo parte dal jazz laddove il migliore post-free incontra la musica "colta" contemporanea, e trova a metà strada Xabier Iriondo, che arriva dal noise come escrescenza sperimentale di un alveo post-punk. Due percorsi apparentemente opposti...
Con Xabier c’è grande amicizia e affetto. Quando comunichiamo siamo subito nella stanza del tesoro. Progettare è facile e, grazie alla perizia che ha, gli scarti, i passi successivi alla nascita di un’idea sono quasi sempre di qualità. Non credo che i nostri percorsi siano opposti, sono diversi e molto, questo sì. Ma abbiamo la stessa capacità di messa fuoco, una volontà costruttiva simile, molte passioni in comune. Il lavoro in dvd sull’epopea del sottomarino nucleare Kursk, che Amirani pubblicherà prossimamente, ne è un esempio. È un’idea di materia che va oltre la musica in sé. È un’esperienza, un lavoro. E anche una responsabilità. Non è poco..
Jazz o non jazz?...la domanda sembra più semplice del ‘to be or not to be’ del vecchio William, eppure il discorso come al solito contrappone aderenza alle premesse e mummificazione da istituzionalizzazione? Eresia da superamento di un confine e arroccamento all’interno delle solide mura della cittadella dei dogmi?. Tuttavia leggendo le riviste jazz specializzate ogni tanto fanno capolino anche nomi Zorn (Tzadik) e quel Tim Berne (Screwgum) che sarebbero proprio i corrispettivi americani di etichette come l’Amirani (www.amiranirecords.com)... misteri della fede (o forse dovremmo dire dell’esterofilia)!. Come anche per l’Improvvisatore Involontario ero rimasto incuriosito dal tipo di uscite e dal modo di proporsi ed ho finito con l’imbattermi in un tipo di realtà che spesso è molto più nobilmente ‘off’ di quelle che già conoscevo. In fin dei conti se gente come Krimson, Iceburn, Primus, Anatrofobia, Flying Luttembechers è partita da altri ambiti ibridandosi con il jazz è anche vero il contrario e non parlo di misconosciuti jazzisti o di ‘neo radicali’… Davis, Coltrane, Coleman... dicono nulla? Ellington stesso non era un famoso alchimista? ...ma in tempi di integralismo ‘catto-islamico’ meglio non esprimere mai apertamente certi pensieri.
John Zorn (Tzadik), Tim Berne (Screwgum), Roy Paci (Etna Gigante), Francesco Cusa (Improvvisatore Involontario)…e Gianni Mimmo con Amirani: perché un jazzista decide di aprire un’etichetta?
Vorrei cominciare col dire che io non mi sento propriamente un jazzista, ma vengo da lì. A dire la verità non mi sento neanche interamente un musicista. Tempo fa, molto tempo fa, lessi una frase di Pierre Klossowsky che è divenuta una specie di fissazione per me: ‘aggiungere al mondo solo sinceramente’.
È un tempo di enorme, forse eccessiva, produzione: libri, dischi, performances. Alla fine degli anni 70 Stockhausen dichiara che ‘tutta la musica era già stata scritta’ e che ‘non avremmo avuto che la possibilità di tentare assemblaggi’. Io penso però che accostare non sia sempre ‘comunicare’. Ad incuriosirmi continua ad essere la scintilla che rende possibili le relazioni fra le persone, fra gli artisti e il loro sentire, la necessità di rendere documento un urgenza di espressione. Ecco, credo che a muovermi sia stata soprattutto la scoperta che queste relazioni sono spesso magiche. Mi piace scoprire che aspetti inattesi sgorghino da private e a volte minimali investigazioni. Il lavoro artistico sincero è spesso velato da modalità stilistiche. Ma se a quella persona mi è dato di rivolgere domande circa il suo lavoro, trovo o meno quella sincerità di cui sono ghiotto. Nel caso in cui l'indagine si rivela positiva, trovo un punto vibrante in una rete immaginaria che a poco a poco scopre la verità di connessioni ed incontri. Ho aperto la piccola avventura di Amirani Records perché credo nella relazione tra sensibilità.
La seconda ragione è di ordine documentario. In un percorso certe tappe meritano di essere segnalate da una bandierina. Una mappatura direi. Sono noioso, mi piacciono poche cose. Non è giusto chiedere ad altri di occuparsi di produzione di cose che piacciono a me. Così mi è più semplice tracciare una linea editoriale rigorosa e monacale, che sia un setaccio circa la responsabilità. La terza ragione è di ordine quasi religioso, gnostico. È come se la luce fosse frammentata in miriadi di luminescenze sparse, l'etichetta ha potere aggregante delle luci sparse. Mi dona l'occasione di riconoscerle da una posizione di investigazione. Cosa che soddisfa il mio ego in modo sublime.
È portentoso sapere che una quantità di cose si agitino là fuori.
La ricerca, la sperimentazione, questa adiacenza con i suoni concreti è divenuta una faccenda che è uscita dalle accademie. I ragazzi dai 20 in su si danno un gran da fare, ci sono belle intelligenze che frugano oltre la sindrome di default, oltre il solito, oltre il televisivo. L'etichetta è frugare nel ‘tra’ per parafrasare Deleuze. Inoltre, produrre significa per me arrivare a pensare il prodotto finale come un intero e coinvolgere i musicisti, gli artisti, in una riflessione completa circa la loro e la mia idea del fare.
Quindi l’etichetta non produce/produrrà solo dischi che coinvolgono te in prima persona?
No, certo che no. Il quarto numero appena uscito intorno a natale è già infatti una produzione di un gruppo piuttosto interessante: Samsingen. Il mio coinvolgimento qui è solo produttivo e di concept. Insieme a Samsingen abbiamo a lungo discusso del progetto, della migliore resa del suono, del mixing e infine del progetto grafico. Sto ascoltando anche alcune musiche e gruppi che mi hanno inviato materiale. Lo faccio nel modo più attento che posso e vedo se qualcosa mi sollecita attenzione. Credo anche di non avere grandi preclusioni circa i linguaggi, vorrei che il profilo editoriale non fosse a tutti i costi rigido. Trovo che in certi progetti, anche distanti da me dal punto di vista stilistico, brilli un po' di quella luce che ti dicevo...
Interessante…come anche il fatto che tu sia in ‘combutta’ con Mirko di Wallace, ma non rischi di precluderti una attenzione/fruizione da parte di un pubblico più affine al jazz (so che per altro sei stato votato fra le ‘nuove proposte’)? Per altro di recente ho letto un’intervista a Vandermark dove sparava a zero sull’‘istituzionalizzazione’ del jazz americano per mano di Marsalis e delle ‘alte sfere’ del circuito…
Adoro Mirko e mi ricorda un po' di sana energia che alberga nei giovani cuori. Da lui come da altri giovani leoni del fare ho appreso molte cose negli ultimi tempi. La comunicazione è facile con lui e capisce al volo come impaginare le mie idee grafiche e mi dà una grande mano e molti disincantati suggerimenti sulla produzione. In tutta sincerità non ho mai goduto di grande popolarità negli ambiti propriamente jazz e il fatto di comparire nel rank dei migliori nuovi talenti nella classifica del mensile musica jazz alla mia età, ha un che di imbarazzante. Ho molti amici che fanno mainstream jazz, che stimo, dei quali ascolto talvolta i lavori e dai quali ricevo attenzione ed ascolto, quasi sempre critico, direi. Conosco qualche eccellente musicista che si sente un po' prigioniero del jazz. Ma avverto un po' di grigiore e trovo più attraente l'atmosfera croccante proveniente da altri ambiti. Da tempo il jazz ha svelato la sua natura fortemente idiomatica e auto referenziale. Ma anche so di molta gente che lavora sodo perché lo spazio divenga più fertile. Non sono mai stato ecumenico ma credo che le strade non sono mai state così confuse. Ho trovato attenzione per certi miei lavori in ambiti impensabili e anche in certi jazz club un po' retro'. Molte sono le cose del mondo.
So che fra le uscite in programma c’è un concept dvd dedicato alla tragedia del sommergibile Kursk, per altro se non sbaglio hai coinvolto anche Xabier Iriondo e chi altro? Ce ne vuoi parlare?
Grazie per questa domanda. Nell'avventura di questo lavoro, che sarà un dvd, non è esatto dire che ‘ho coinvolto’ Xabier Iriondo. Xabier è soprattutto un amico vero, una persona con grande sensibilità e con qualche grossa esperienza emozionale alle spalle. Questo me lo rende vicino come persona. Per certi versi è come un fratello, per me. Entrambi abbiamo una certa passione per la Storia, recente o meno che sia, entrambi restiamo colpiti dai suoi aspetti epici, dai suoi drammi, dalle pieghe che imprime sulla vita a venire, pieghe che sono più o meno consapevolmente avvertite dagli uomini. La registrazione che egli ha curato è avvenuta in una chiesa sconsacrata a Piacenza. Io e Angelo Contini, personalissimo trombonista dal timbro molto Roswell Rudd e mio sodale nel duo “Two's days/Tuesdays”, abbiamo dato vita a un duo intenso e drammatico a causa di certi strani e profondi riverberi che sono in quel luogo. La registrazione ambientale è stata semplicemente geniale. Xabier ha dislocato microfoni in vari posti della chiesa e ha operato una vera e propria regia della ripresa. Inoltre è intervenuto con l'elaborazione elettronica in tempo reale del nostro suono acustico lavorando e distribuendo vari piani sonori. Questo ha creato delle profondità e delle linee di suono che si sono andate sovrapponendo, elidendo, sollecitando nel corso della performance. La massa ottenuta ha rivelato subito una grande suggestione e ha immediatamente toccato la mia parte sensibile. C'erano sensazioni di qualcosa di intoccabile, una specie di claustrofobica oppressione e senza dubbio qualcosa di drammatico e quasi teatrale. Angelo diceva che era una specie di danza compressa. Io ho avvertito dei suoni di macchina navale, di profondità scura e anche una sorta di ricerca. E poi mi è stato tutto chiaro: era il Kursk. Rispetto al lavoro, questa chiave di lettura della musica registrata, ha rappresentato una rivoluzione.
È iniziato un lungo elaboratissimo lavoro di editing delle parti che insieme a Xabier e Angelo abbiamo svolto con la cura che meritano le cose non minimali. Da questo punto in poi comincia il vero e proprio lavoro: ho elaborato una specie di questionario e ho rivolto le stesse domande ad artisti visuali: i fotografi Elda Papa e Simone Fratti e a mio figlio Agua per la parte video e il montaggio. L'idea non doveva, e non è stata, documentaria. Io ero e sono ancora affascinato dall'aspetto epico della vicenda.
I tempi di Omero sono andati. Le sue parole assommavano storia e narrazione e archetipi. Sono le radici dell'immaginario. Oggi gli eventi sono esaminati da una cronaca attenta, analitica e indagatoria. Così quello che la cronaca poteva darci ci è stato dato. CNN, BBC, la tv Norvegese hanno fatto esaustivi servizi su tutti gli aspetti del fine del Kursk e persino del suo recupero. Beh, io vorrei occuparmi di una immaginazione intorno alla faccenda. Così è successo che per es. Elda ha pensato che uno degli items fosse ‘aderenza’ fra i corpi all'interno del sommergibile, i corpi erano ‘nella’ tragedia, erano ’la’ tragedia. Simone ha pensato che ormai potevamo pensare a Kursk solo grazie ai resti, Agua ha pensato che il suo immaginario era principalmente filmico. Io sono affascinato dalla figura del tenente di vascello Kolesnikov che chiuso nell'ultimo compartimento sicuro del Kursk insieme a un manipolo di sopravvissuti all'esplosione scrive una piccola nota tecnica nella quale con lucidità ci dice che nessuno di loro si salverà. Chiude quella verità nella propria mano. Il rescue norvegese che giungerà laggiù dopo settimane troverà quel biglietto nel suo pugno. Beh se questo non è degno di Omero.. Stiamo finendo il montaggio video, credo che sia una delle cose migliori cui mi sia stato dato modo di partecipare.
Beh, per altro con Xabier in un certo senso condividi anche la professione esatto? So che hai una bottega di liuteria (si dice così?) per sassofoni…
Non è esatto dire ‘liutaio’ di strumenti a fiato. In italiano si dice più volgarmente ‘riparatore’. Io mi sono specializzato in strumenti ‘vintage’ e faccio questo lavoro da circa vent'anni. Xabier invece si è dedicato alla ricerca di strumenti ‘vintage’ o meno su strumenti particolari, a corde, primi grammofoni, monochord, pedali artigianali etc., abbiamo un tipo di curiosità molto simile in effetti, ma le nostre ricerche sono diverse.
In “Bespoken” il sax o gli strumenti acustici hanno una parte di secondo piano rispetto agli altri tuoi lavori ed alle altre uscite dell’etichetta. Parlando con te ho avuto come l’impressione che tu subisca parecchio il fascino di certe forme di elettronica…
Sì, l'elettronica ha sempre avuto un grande fascino per me. Una specie di incantamento.
Proprio dall'inizio del mio interesse per la musica o per il suono, se vuoi. C'è una cassetta registrata, ma anche un nastro di un tape recorder che si chiamava Geloso, parlo della fine degli anni 60, in cui gioco con le frequenze ad onde corte di una bellissima radio Grundig che il mio babbo aveva portato a casa. Avevo 13 anni. Mi piace molto la pionieristica analogica, i primi esperimenti Ircam, in particolare la loro applicazione ambientale su testi classici. E poi tutti quegli esperimenti negli studi Rai : Berio, Maderna e naturalmente MEV, con Alvin Curran e Richard Teitelbaum, che ho visto dal vivo diverse volte anche in duo con Braxton con quel progetto.. “Time Zones”. Esiste una intera serie di letture radiofoniche della Divina commedia con la voce di Vittorio Sermonti e la musica a cura dell'Ircam di Parigi che è un capolavoro. Questa possibilità di trasportare l'ascoltatore in modo quasi onirico, questo appellarsi direttamente a uno strato profondo della fruizione, beh questo è grande! Il passaggio al digitale ha, come tutti sanno, operato una ulteriore trasformazione con benefici e perdite. Ma il musicista che opera nell'elettronica con sobrietà e gusto ha per le mani notevoli possibilità. Espressive e di precisione. Credo che con l'elettronica, a lavorarci sodo, un musicista comprenda molto anche di sé e del suo modo di organizzare le componenti del suo lavoro.
Lorenzo Dal Ri è un maestro per me, una specie di avatar. Ho imparato ad ascoltare con più attenzione i suoni lavorando con lui e anche con Xabier Iriondo. Con entrambi si va verso una specie di metalinguaggio. Per “Bespoken” Lorenzo ha lavorato con grande cura e sobrietà e credo che abbiamo messo a fuoco la relazione. A differenza di altre esperienze, dove emergono narrazioni più marcatamente soliste e di derivazione idiomatica e stilistica, nel rapporto con l'elettronica spesso devo abituarmi a qualcosa di più complessivo e sommatorio. Quindi è buona abitudine esercitarsi nel mettere a fuoco diverse profondità. Ecco, proprio questa possibilità di rimettere in discussione il proprio suono con il live electronic, questa idea del suono come campione…le trovo categorie di grande interesse. Senza parlare delle possibilità di una qualità migliore della registrazione, grazie all'elettronica.
Ritorno sull’intervista nella quale Vandermark (ma anche Gustavson) sparava a zero sul processo di istituzionalizzazione del jazz americano. Per quel poco che so/vedo quello italiano segue a ruota, per altro recentemente leggevo un’intervista fatta a Bollani in cui rispondeva amaramente ad un giornalista che le cose andavano meglio per il jazz italiano solo se ci si riferiva a 3, 4 musicisti e che, essendo anche organizzatore di un festival, vedeva come purtroppo a meno in cartellone non comparissero Rava, Bollani, Fresu o Cafiso la gente non si muoveva…tu cosa pensi in proposito?
Il jazz è istituzionalizzato perché non è percepito più come divenire e perché è ossessionato dalla sua matrice popolare. Ha bisogno ancora di legittimarsi come forma d'arte. Solo che lo fa come tutte le musiche classiche del pianeta e cioè con la celebrazione. D'altra parte non è mai stato così celebrato. Musicisti ripercorrono stili di 40/50 anni fa come fosse il linguaggio, l'arte. Sono venute meno le mozioni artistiche. Tutto qui. Mai come ora gli stili hanno mostrato la povertà del loro stesso autodefinirsi. È il tempo dei manager seduti, dei PR e di una commedia del tempo che fu. Che posso fare se non continuare a cercare? Questa è la domanda che dovrebbe farsi un musicista. Ma molti impiegano molta parte del loro tempo a studiare le frasi di Parker, e fin qui tutto bene, ma la cosa grave che ciò diviene il loro linguaggio e con fondono il loro linguaggio con al propria musica. Non aggiungono, non tolgono, non crescono. Anche Parker era ‘out’ al suo tempo, ma aveva strada davanti. Nella classifica dei suoi musicisti preferiti il primo jazzman veniva al quarto posto. Prima c'era Stravinsky e il poeta Omar Kayam. Quando suonava, la gente diceva: chi accidenti è sto pazzo? Ma si sapeva che era lui, si capiva che scavava. Ne sarebbe certo scaturito qualcosa…se ascoltavi il disco dicevi: ecco Henderson, ecco Coltrane, ecco Dolphy e così via. Oggi dici: assomiglia a Henderson, questo è un coltraniano ecc. Si riconosce quasi tutto fino a Braxton, a Hemphill. Poi, nebbia.
Oggi per un musicista in contatto con sé non c'è strada davanti, il jazzman di oggi guarda indietro. La verità è che le strade sono confuse e che c'è una rete di possibilità estremamente ricca tutto intorno. Alcuni dei musicisti bravissimi che hai citato sono anche ottimi manager di sé stessi e questo è un vantaggio nel rapporto con le istituzioni e con il denaro. Il festival di Fresu a Berchidda è abbastanza coraggioso e la gente ci và. Poi non sono così sicuro che la gente non si muova se non ci sono certi nomi. Sono i luoghi strani che hanno strane impennate. Mi ha sempre colpito come certe piccole, piccolissime realtà locali abbiano idee e proposte più coraggiose di grandi città. Per una volta all'anno un teatro greco in cima a una montagna ospita migliaia di persone che vengono e sentire concerti alle cinque del mattino, bellissimo. È che l'attenzione a ciò che si muove non c'è da parte delle istituzioni e la cultura alle volte è nelle mani di funzionari-politburo che applicano tutti i parametri possibili tranne quello della attenzione a ciò che si muove. In molti ambiti è così: guarda le programmazioni delle stagioni concertistiche teatrali: la musica che vi si ascolta ha almeno 100 anni.
Vaneggio un tempo in cui molte realtà possano esibirsi vicine. Vaneggio tempi vivi e fecondi, nei quali metallari che spaccano chitarre possano scambiare idee e palchi con serissimi violoncellisti bachiani. Anche la socialità è venuta meno, incontrarsi ai festival negli anni settanta era una esperienza di comunicazione. Oggi nella migliore delle ipotesi la fruizione è televisiva. La contraddizione sta nel fatto che oggi i musicisti sono più avvicinabili di prima. La mail, i siti, la rete. Il problema è, come dicono a Roma: ‘che se dovemo dì?’ Io mi dico che è sempre una conquista quando la gente non capisce, quando non riconosce, quando non riesce a categorizzare. Non mi interessa che ci sia consenso. Mi interessa che se la gente non esce sorpresa da un concerto, almeno che ne esca sospesa…che gli resti qualcosa da pensare e da provare a decifrare. La musica così non rimane fuori da chi ascolta, gli rimane in po' addosso. Non finisce lì. che poi è il suo compito.
...certo il metallaro di fianco al jazzista ed al bassista dub sono un’immagine che funziona bene (anche nei Painkiller)...ma il rischio latente non è quello di cercare di ‘fingersi aperti a tutti i costi’ quando poi alla luce dei fatti non è così? Insomma il rischio non è che poi ci si forzi in un'apertura a 360° che poi è solo virtuale?...a volte provo ‘quasi’ simpatia per certi ambienti reazionari, almeno hanno l'onestà intellettuale di parlare apertamente e di dire come la pensano...non trovi?
Io parlavo della possibilità di esibirsi nelle stesse programmazioni. Voglio dire che le programmazioni delle stagioni, dei festival, non possono continuare a essere settoriali in un momento dove i settori hanno fluidi confini. Una programmazione deve avere una linea concettuale e applicarla con i contributi di prospettive differenti. Anche in filosofia è così: l'archetipo è limpido, i pensieri che gli si agitano intorno sono molteplici. Non puoi continuare a basare ogni scelta sul budget e sul suo rientro, questo è ormai palese. Io non sono affatto aperto, ma sono possibilista. Io non ho paura della mia curiosità, ad essere precisi, non me frega un accidenti. Sono i reazionari, come tu li chiami, che sono solo chiusi. È facile fare affermazioni che sembrano oneste, quando si ha il potere. Questo atteggiamento genera fascino e simpatia. È tattica, fratello. Non si tratta di sincerità, si tratta di arroganza. Questo in generale. In questo paese poi, si possono succedere governi di ogni colore, ma chi ha il potere, ad esempio della difesa, è e sarà per lungo tempo ancora un democristiano, qualunque sia il nome del partito al quale appartiene. C'è da riflettere, direi.
Sono estremamente critico circa le collaborazioni a tutti i costi. Ho già detto e ripeto che ‘accostare non significa affatto comunicare’, il più delle volte non succede. Non sono affatto convinto che operazioni tipo Scanner (Robin Rimbaud) che mixa Sciarrino siano necessarie, e sto citando senza dubbio un nobile esempio. Le cose non sono fatte sempre per funzionare. Anzi io credo che le cose siano fatte per non funzionare. Solo che provarci, il meglio possibile, porta in scena questo lavoro. Ed è questo che la musica deve fare: lavorare e mostrare il proprio lavoro. Non c'è bisogno di domandarsi cos'è, quando è. Se vogliamo parlare di ciò da cui il jazz, o quello che continuiamo a chiamare così, dovrebbe trarre nutrimento le contraddizioni sono veramente evidenti nella loro povertà. Vorrei chiedere se, per caso non c'è patologia nel ripercorrere stilemi e pattern consolidati e dire che il jazz è quello. Il jazz, ma direi tutta la musica, è il divenire. Il musicista che sta fermo sperimenta il suo limite e ne rimane prigioniero. Non sarebbero esistiti Armstrong, Cecil Taylor, Stravinsky, Miles, Giacometti, Braque, Picasso. Se l'apertura è virtuale, non è apertura.
Qual è il presente di Amirani? Ed Il suo futuro? Ed il tuo di musicista?
Ah, beh, il presente di Amirani Records è luminoso e caotico e travolto e ottimista. Cominciano ad arrivare con lentezza anche recensioni prestigiose (è di questi giorni quella eccellente di “Cadence” e anche di “Phosphor”). Ma soprattutto arriva musica ed idee fresche. Cerco di ascoltare tutto quanto con attenzione e cerco, dico cerco, di pianificare. Però c'è anche qualcosa di buffo e di nuovamente sociale, questo è davvero speciale. Si è aperta una nuova stagione di comunicazione per me, ad un livello più profondo, con partner, musicisti e con tutta la legione delle parole dette e scritte. Tutto questo con i pochi soldi che riesco a metterci e con il tempo che riesco a dedicarci. Ma è buono, questo tempo, è vivo e promette bene. Ho ascoltato buona musica e ho avvertito grande desiderio di fare. Le produzioni a venire sono interessanti e originali, voglio farle bene e con la cura che meritano i buoni progetti. Quest'anno vorrei uscire con quattro o cinque numeri e trovare una distribuzione. Le immagini del primo dvd Amirani records, “Kursk”; sono nella fase finale di montaggio e il suono sarà spaziale, promesso. Dovrebbe essere pronto a primavera. Tengo molto a questo lavoro. Poi sarà la volta del progetto “On War” con molti musicisti impegnati con i loro rispettivi progetti intorno a questo concetto. Un trio con Francesco Cusa alle percussioni e Andrea Serrapiglio al cello, oltre al sottoscritto, un duo di fiati che si chiama “Novotono”, contemporaneo e misterioso e un altro paio di cose che dirvi non voglio.
Il futuro è quello di maggiore e più matura identità per l'etichetta. Vorrei tenere ben saldo il principio di qualità e di fertile curiosità. Spero anche di non dover continuare a fare tutto da solo e di trovare qualche collaborazione per la comunicazione e qualche aspetto pratico...io come musicista voglio continuare a studiare la relazione con immagini, testo e approfondire lo statement elettroacustico fiati/elettronica attraverso buone collaborazioni. Lo strumento continuerà a assorbirmi molto con lo studio delle tecniche e del suono. Credo che quest'anno riprenderò l'idea del quartetto/sestetto dedicato a ‘sbagliare’ i temi di Monk. Credo di non poter vivere senza Monk, ma non sopporto l'idea di antologizzarlo…ma anche mi piace molto fare ‘stretching’ di alcune partiture contemporanee, così come è successo con Webern in “One Way Ticket”. È un mondo pazzesco, se penso che quel pezzo è stato scritto nel 1924…in passato ho a lungo lavorato con i testi di Samuel Beckett e ho diverse cose pronte. Vorrei tenere acceso il fuoco, così che quando qualcuno o qualcosa arriva... beh, spero di rimanere accogliente....
What I would like from you. Your personal (idiosyncratic/ phenomenological/ entirely peculiar) take on the role of shape in the processes involved in creating, playing, listening to or reflecting upon music. In other words: Do you ever think about 'shape' in relation to music?
I always do. Both listening and/or playing, I feel music strongly related with shape or relationship among shapes. There’s a morphing attitude in music, this is evident. The most surprising thing is that while playing one experiments the privilege of a vision from his own spot of musician and a more general overview of the elements dancing around.
I’m for an improvisation where things happen, I strive for a multi-perspective musical creation and I feel improvisation always related with something concrete, never abstract.
To me painters and sculptors are main influences in my style and in my improvising approach. More than musicians, that are much important of course.
The first image I feel more appropriate to describe my idea of improvisation is a “Pendulum in motion”. This Pendulum is moving from a position I’ll call “Ego” to more complex positions that I call “Sound Theatre”. In all improvisations I always start from an “Ego” position, both acting or re-acting to other musician/ensemble or behavior stimulation. I always want to push the music somewhere, this is a very “Ego position”. Then, after the initial push, the Pendulum starts to move, both in terms of amplitude and vertical angle, toward the “Sound Theatre” where other Pendulums (other musicians inputs) are acting/re-acting. At this point (which is not that precise of course because each musician has a different degree of Ego and decisions and self-delivering to music), the “Sound Theatre” becomes simply MUSIC.
Sometimes, hopefully most of the times, the MUSIC becomes so strong that I can only belong to her. From that point I don’t determine music anymore, MUSIC determines me.
Whilst you are improvising -- either solo or with others? (in time)
When I play solo concert the same category occurs, but I think more in a sculpting way. I usually decide “areas to play on”, tools to work with, horizontalities and verticalities, weight of dynamics and empty-full objects.
I often combine different plans and surfaces in a more complex solid tri-dimensional structure. Sometimes happens that the elements dance pretty alone. I mean some of these faces are strong enough to stand alone for a while, so I can feel the need of a silence.
Silence is a terrific opportunity to lend an ear to what rings true in the music one just played before.
There’s a little difference when happens to play interpretations of other’s music. I mean: every music has is own image, shape, place.
Once I played, and recorded too, my interpretation, a solo version, of “Die Sonne” op.19, a lied by Anton Webern.
I simply played the voice/sung line, but in order “to go unto” that line I started to stretch it, enlarging the horizontal melodic and the vertical harmonic possibility, but mostly dramatically increasing the dynamic jumps. After the first recording I decided to add/ record a second line starting at a certain point, just in order to reverberate in a new turbulent order the dancing elements I played before.
It was like to see the music in transparence, in a film-like perspective: notes as standing elements in a surrealistic De Chirico’s square.
Some other pieces are incredible in terms of shape imagination for me.
I love Charlie Mingus’s music and I studied quite a number of his most famous compositions. One of the most clearly “shaped” piece is “Reincarnation of the Lovebird”. Since the first moment I listened this track, it was several years ago, I felt it like a house. This theme is powerful in its own mysterious way. While I play it I started to proceed to inhabit as if my home.
A home with rooms and windows and flights of stairs and dark corners and sudden flashes of light. I often play that theme, but its’ completely different from the initial theme, I recognize the house, but I chose to look at it from a different spot every time and I can stay in each room for the time I want to...
What about before (planning, learning) during (listening or playing) or after (reflecting upon or talking about music)? Could you give some examples? Is this more relevant at the level of a whole piece? or note? or particular passage or relationship with others?
The whole piece and the single passage (and in defining the mood/space within all passages, single element shapes are important as well) are crucial in playing improvisation. I feel the improvisation like instant composition. Each improvisation delivers something. I try to deliver solid objects. They remain for a while out there, to be observed, seen.
Do you think in terms of just as many other metaphorical spaces? (colour, feeling, mood etc.)?
There are single colors and multi-colors.
Single colors: expression tools, techniques, dynamics, rhythms, gestures
Multi-colors: the combination of different expressive instant strategies, to see connections between lines, to see possible combination areas/moods.